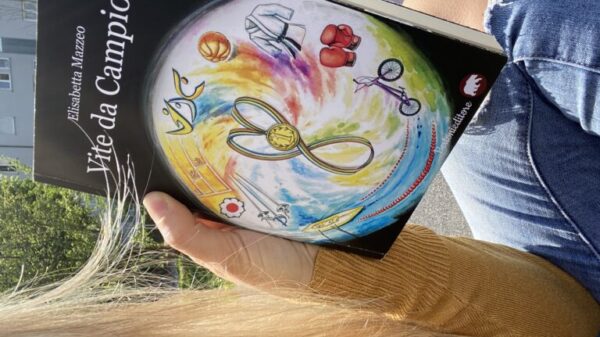La legge e l’uomo, connubio complesso
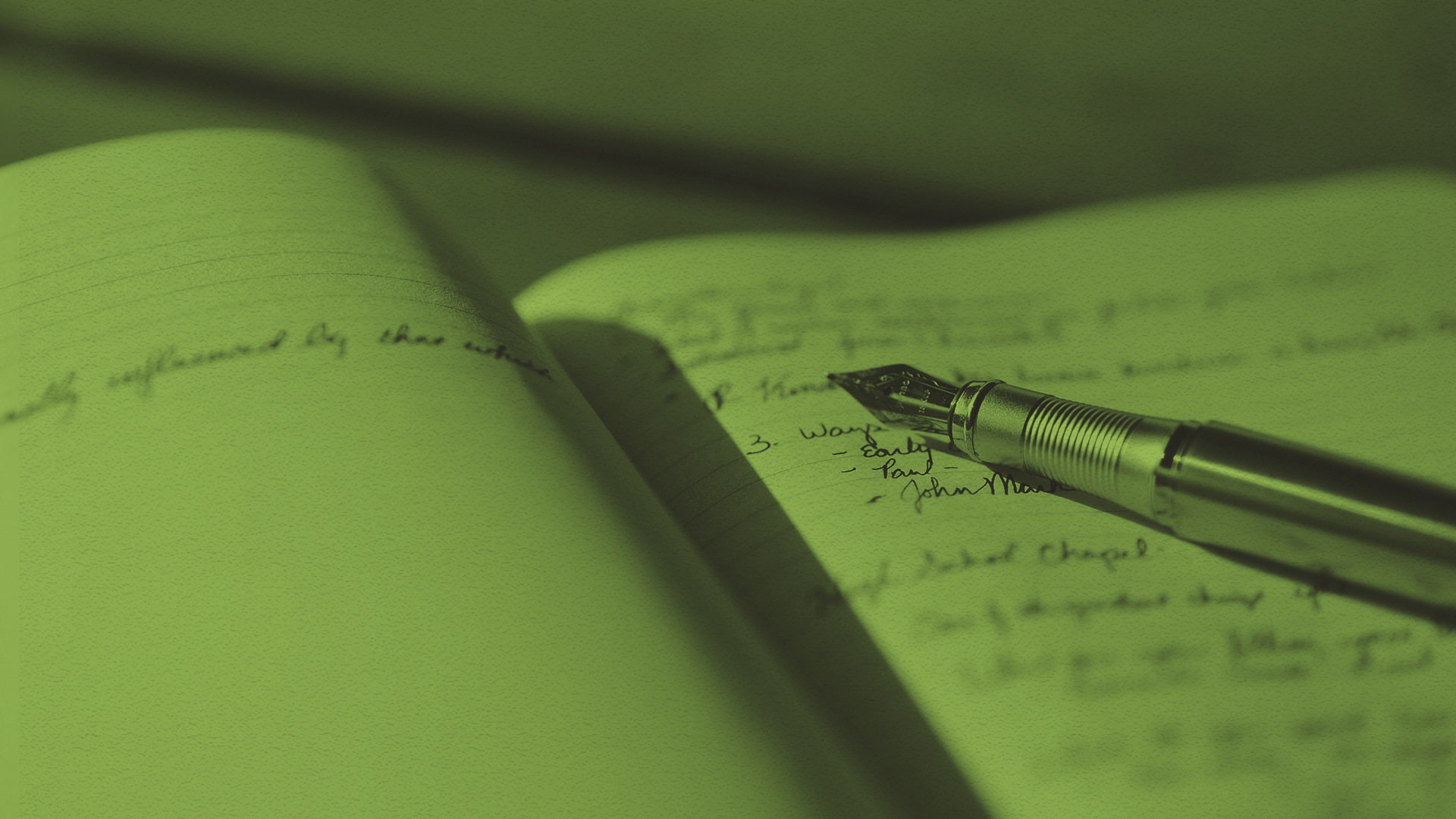
La riflessione di Giacomo Leopardi sulle leggi e i sistemi giuridici, in un saggio curato da Laura Melosi, che approfondisce la figura del bardo di Recanati indagando un aspetto poco conosciuto del suo vasto percorso intellettuale. Il volume, pubblicato dalla casa editrice fiorentina Leo S. Olschki, è inserito nella collana “Biblioteca dell’Archivum Romanicum”. Pag. V-112, Euro 20.
FIRENZE – A tutti è nota la sensibile anima poetica di Giacomo Leopardi, che ha donate all’umanità profonde e commoventi riflessioni in versi sulla condizione dell’individuo sulla Terra, e la sua condizione di “schiavo della Natura matrigna”. A fianco di questo sommo aspetto del suo genio, si pongono però anche il Leopardi filologo – perfetto conoscitore della classicità -, il filosofo attento osservatore degli antichi Greci, e infine, assai meno conosciuto, il giurista studioso di filosofia del diritto così come del diritto positivo. Un percorso che deriva in linea diretta dalle sue riflessioni sull’essere umano, sulla ricerca dell’armonia in senso platonico, e quindi anche nelle manifestazioni legate all’ordine della società. Laura Melosi, professoressa di Letteratura Italiana all’Università di Macerata, ha coordinato un ristretto gruppo di studiosi che ha affrontato, con un lungo lavoro di esame delle fonti, un inedito aspetto umanistico del pensiero leopardiano.
Ius Leopardi. Legge, natura, civiltà, è la fatica saggistico-letteraria scaturita da questo lungo lavoro suddiviso in quattro saggi, che delineano Il Leopardi giurista, inquadrato però nel suo contesto storico.
Tempi non facili, quelli vissuti da Leopardi, attraversati da sensibili cambiamenti sociali e politici, ma anche da repentine successioni di scenari diametralmente opposti: gli entusiasmi napoleonici del primissimo Ottocento e l’eco illuminista che lasciarono anche in Italia, la successiva Restaurazione e il verificarsi dei primi moti rivoluzionari patriottici del 1821 e del 1831, che lasciavano intravedere più di una crepa sul placido orizzonte conservatore, e lo Stato della Chiesa, di cui Leopardi era cittadino, non ne rimase certamente immune. Ma la visione leopardiana non si limita ai confini papali, assume respiro europeo, partendo però da un assunto ben definito; come ebbe a scrivere nei Pensieri, «il mondo è una lega di birbanti contro gli uomini da bene, e di vili contro i generosi». Una frase purtroppo ancora attuale, e che chiarisce quella che è la disillusione del poeta nei confronti dell’essere umano, sovente incline a un utilizzo non virtuoso della propria razionalità. Inclinazione cui lo ha costretto la Natura matrigna.
I quattro saggi del volume ricercano le tracce del discorso leopardiano sul diritto all’interno di tutta la sua opera, dai Canti ai Pensieri, dalle pagine dello Zibaldone alle Operette morali, in tal modo ricostruendo una linea di pensiero che vi aggiunge profondità e ne amplia la portata. Laura Melosi, in apertura di volume, redige una panoramica generale sul dove e come Leopardi abbia affrontato l’argomento, con puntuali richiami alla sua opera e, specularmente, a quelle altrui, ad esempio La guerra del Peloponneso di Tucidide, ben conosciuta da Leopardi e che diviene oggetto di riflessione. Il pessimismo emerso nella frase di cui sopra, trova piena corrispondenza nei Paralipomeni della Batracomiomachia, dove la favola dal tema animalesco è occasione per discettare sulla lotta fra liberali (topi), i fedeli sudditi di Roma e del Papa (rane), e l’Austria (il granchio), che nel decennio dei primi moti patriottici si scontrarono aspramente fra loro. Questa feroce satira politica in forma di favola, se da una parte respinge l’assolutismo, dall’altra esprime scetticismo per gli ideali costituzionali dei liberali moderati. Pur riconoscendo il ruolo delle leggi, che anche nel caso di una riforma del sistema politico conserverebbero il loro primato civile, resta lo scetticismo sulla rettitudine di chi assumerà la guida del nuovo governo. Le vicende dei Paralipomeni dimostrano questo scetticismo, e citano fra le righe Tucidide, per il quale nessuna legge, per quanto perfetta, può raffrenare l’impeto umano.
Esiste però un diritto di natura, che precede gli ordinamenti ideati dal pensiero dell’uomo, e basato su una serie di precetti elaborati dall’etica; precetti che sin dal’antichità hanno avuto, nelle varie civiltà, numerose similitudini. Eppure, se il diritto naturale sembra assicurare alcuni punti assoluti di riferimento, lo stesso Leopardi chiarisce nello Zibaldone come l’unica verità assoluta sia che “tutto è relativo”. Pertanto, ogni civiltà ha comunque sue specifiche leggi naturali. I limiti, comunque, non stanno nelle leggi, ma nelle civiltà che le adottano, costellate come sono di «accidenti e sconvenienze», analoghi comunque a quanti ve ne sono nell’intero sistema della Natura.
A Francesco Adornato il compito di illustrare la condizione del diritto e delle istituzioni al tempo di Leopardi, con un puntuale saggio storico-politico nelle cui pagine sottolinea l’attenzione del poeta alla sua contemporaneità, a dispetto di chi lo ha sempre pensato capace solo di fantasticare dietro una siepe. Nel gennaio del 1821, registra nello Zibaldone la sterzata costituzionale della monarchia borbonica. Uno dei fulcri della riflessione leopardiana è il dualismo fra monarchia e democrazia; se la prima è necessaria perché consente di mantenere l’unità di un popolo e quindi il funzionamento dello Stato, la seconda è tuttavia necessaria perché in quanto garante dell’uguaglianza, è la base necessaria della libertà. Uguaglianza e bene comune sono però concetti che latitavano anche all’epoca di Leopardi, il quale, ancora nello Zibaldone così si espresse sull’Europa del primo Ottocento, descritta come «una nazione governata da una dieta assoluta; o se vogliamo dire comandata da una quasi perfetta oligarchia». Sull’attualità del giudizio è superfluo soffermarsi, qui è utile sottolineare come detto, l’attenzione del poeta per la situazione politica dei suoi tempi. In continuazione di saggio, anche un’approfondita panoramica sui sistemi giuridici in vigore nell’Italia dell’Ottocento, una frantumazione sulla quale Leopardi non si esprime, nonostante fosse un evidente impedimento all’Unità.
L’indagine leopardiana non è soltanto empirica, ma anche teorica: su questi aspetti si sono concentrati nei loro saggi Vittorio Capuzza e Marco D’Alberti, il primo muovendo un confronto con il contemporaneo Lamennais, Sull’indifferenza in materia di religione: dalla lettura di questo scritto, Leopardi trae la conclusione, in antitesi con il francese, che gli Stati nascano dall’errore e siano distrutti dalla verità: deviare dallo stato di natura, attraverso la ragione, comporta l’infelicità dell’uomo, il caos sociale, e la legge è quindi un estremo tentativo di arginare al caos creato. La legge è una manifestazione della ragione, così come è sua manifestazione l’antropocentrismo, che la natura non avrebbe contemplato. Marco D’Alberti, da parte sua, conclude il volume riportando lo scetticismo di Leopardi nei confronti del diritto scritto, che giudica meno puntuale di quello naturale; se questa non ammette la distrazione come alibi per la sua infrazione, la legge scritta ha una minor presa nella coscienza dell’individuo perché si radichi in profondità nella sua coscienza. E con moderna chiaroveggenza, il poeta scrive come la forza delle leggi nel combattere la corruzione e l’ingiustizia viene meno quando le stesse leggi sono troppe e poco chiare.
Definire civile l’Europa del suo tempo, è per Leopardi un errore, poiché vi dominano l’egoismo, l’interesse economico, la corruzione dei pubblici poteri. Arduo, quindi, trovare un sistema di governo migliore di un altro.
Questo bel volume, scritto con eleganza mai accademica, e che si avvale di una puntuale ricerca delle fonti, ha il pregio innegabile di tratteggiare un Leopardi che non è monarchico né liberale, né democratico né oligarchico: è un uomo libero, cosciente dei limiti delle capacità umane, anche e soprattutto in politica, ma di questi limiti non muove eccessiva colpa agli individui, comprendendo come questi debbano gestire loro malgrado un’indole che la natura matrigna ha loro “donato”.
Chissà se, oltre a scrivere le conclusioni in fin di volume, il guardasigilli Orlando ha tratto monito dalle analisi di Leopardi sull’inutilità delle leggi quando sono troppe e poco chiare. Se qualcosa cambierà nel nostro sistema legislativo, può darsi che l’auspicio espresso dal poeta nella Ginestra, di una società più giusta, possa lentamente realizzarsi.
Niccolò Lucarelli