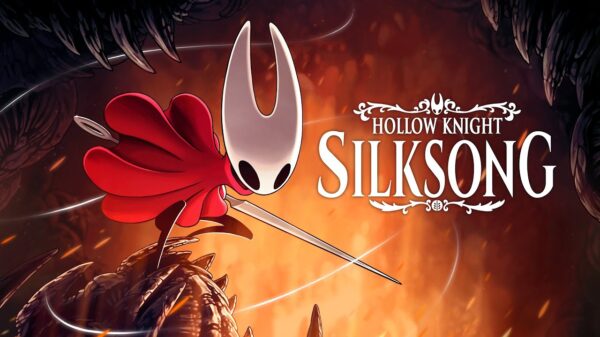Gamification ed Alfabetizzazione emotiva

Ai Game Awards del 2016, mentre Overwatch vinceva come Miglior Gioco dell’Anno e Kojima ritirava la sua statuetta industry icon, un occhialuto uomo con la barba saliva le scale del palco mestamente, visibilmente emozionato, portando con sè una delle reazioni più compunte che abbia mai visto in qualcuno che ha appena vinto un premio per la categoria Game for Impact. Nulla a che vedere con l’esuberanza del nostro Benigni quando vinse l’Oscar per La Vita è Bella, ma nemmeno con la sobria felicità dei creatori di Gris premiati l’anno scorso nella stessa categoria dei Game Awards.
No. La sua era una reazione strana, curiosa, a tratti incomprensibile. Non conoscevo il gioco che aveva creato, non sapevo di cosa parlasse e di cosa si occupasse, ma ricordo di aver cercato informazioni subito dopo aver ascoltato le sue parole:
“Spero che stiamo imparando a guardarci non solo per ciò che vogliamo essere, ma anche per chi siamo ora e per chi siamo destinati ad essere; è un atto d’amore e un favore che facciamo a noi stessi e può cambiare il mondo.”
Ryan Green, questo il suo nome, è lo sviluppatore di uno dei giochi più dolci e struggenti a cui abbia mai giocato. That Dragon, Cancer è il racconto di come lui e sua moglie abbiano affrontato il cancro che ha colpito uno dei loro figli a soli 12 mesi. Al bambino erano state date poche settimane di vita, ma è riuscito a vivere fino al compimento dei 4 anni.
Ciò che mi aveva sconvolto di quel gioco era il modo in cui Green era riuscito a raccontare il tutto. Non il gameplay, non le animazioni, non la resa grafica (per quanto apprezzata): il modo in cui era riuscito a raccontare una vicenda terribile e inspiegabile quale può essere un cancro al cervello diagnosticato in un neonato di 12 mesi.
Esistono molti videogiochi a grande impatto emotivo, che si propongono di raccontare situazioni difficili (Papo&Yo, 2012) o semplicemente di una delicatezza disarmante come nel caso di Unravel e del mio adoratissimo Yarny, di cui ho analizzato la soundtrack e la dolcezza in quest’articolo.
Dopo aver trattato la questione della violenza nei videogiochi nello scorso articolo, parlare dell’emozione e dell’empatia in maniera trasversale mi sembrava un buon punto di vista per completare il discorso.
Ma l’essere umano è altruista oppure no?
Credo che se avessimo davvero una risposta a questa domanda avremmo già risolto tutti i problemi sociali che ci affliggono da secoli e che, in alcuni casi, stanno nettamente peggiorando negli ultimi anni. Non ce l’abbiamo, ma possiamo sempre sollevare domande ed ipotesi.
Michael Tomasello è uno psicologo evoluzionista americano e si occupa di capire perché e come diventiamo esseri sociali. Nel suo libro, Altruisti Nati, propone diversi esperimenti condotti sia su bambini che su scimpanzè e, in conclusione, dimostra come sia i nostri cugini primati sia i nostri figli dimostrino una precoce propensione all’aiuto mediata dalla partecipazione empatica. L’empatia, e per estensione l’altruismo, quindi, non sono questioni apprese in culture e società specifiche, ma secondo Tomasello fanno parte del genoma umano, tanto quanto di quello delle scimmie.

Ma cosa succede in situazioni di pericolo? Dove finiscono altruismo ed empatia? Possiamo dire che in un certo qual modo si svuotino di senso proprio e diventino due semplici parole superflue, perché l’istinto di sopravvivenza e quello di conservazione attivano meccanismi di difesa non del tutto razionali. O, a volte, quasi affatto.
Il film Circle(2015) racconta particolarmente bene questa dinamica psicologica: in una situazione di pericolo e di ignoto, gli esseri umani sono disposti a tutto pur di salvarsi. Disposti a mentire, a soggiogare, a prendere in giro, a uccidere.
Immaginate di risvegliarvi con altre 50 persone sconosciute in una stanza. Non sapete come ci siete arrivati, non sapete perché. Tutto ciò che sapete è che potete votare per uccidere qualcuno, consapevoli che ciò vorrebbe dire arrivare ad essere l’ultimo sopravvissuto e, presumibilmente, a vincere il “gioco”. Come vi comportereste? Dareste priorità a qualcun altro o scegliereste voi stessi?
Io sono l’Altro: l’empatia e immedesimazione
Credo che la domanda alla risposta precedente sia molto semplice: non possiamo saperlo finché non accade. È ovvio che razionalmente non vorremmo mai uccidere qualcuno e non solo perché sia socialmente e moralmente inaccettabile, ma perché empaticamente riconosciamo nell’omicidio un abominio.
La capacità di mettersi nei panni dell’altro, di provare le sue emozioni, di comprenderne completamente lo stato d’animo è sostegno indispensabile delle relazioni umane. Per anni tale abilità è stata ritenuta ambito prettamente psicologico, fino a che tra gli anni ‘80 e ‘90 non sono stati scoperti da un’equipe medica di Parma, dei neuroni chiamati “neuroni-specchio”, che sono diventati la spiegazione dell’indole sociale umana. Questi neuroni si occupano del riconoscimento delle emozioni, ma si attivano anche per imitazione di un movimento e sono la base dello studio dell’intersoggettività.
Fu una scoperta eclatante: dei neuroni, soggetti fisici esistenti nel nostro cervello, che si occupano di riconoscere nell’altro una possibile “unità di accrescimento”, apprendendo per imitazione nuovi modelli comportamentali, esattamente come eterni bambini. Pensare e agire non sono quindi più due verbi separati, ma si intersecano inevitabilmente tra loro: io so quel che fai, ma soprattutto so quel che senti.
«Io sono l’altro/ quello che il tuo stesso mare/ lo vede dalla riva opposta» canta Niccolò Fabi in Io sono l’Altro (2019) descrivendone perfettamente il concetto psicologico. Posso mettermi nei panni dell’altro, di chi guarda il mio stesso mare dalla riva opposta; ma posso anche guardare l’altro, consapevole che il mare che vediamo è lo stesso. Per i meno avvezzi a metafore poetiche, traduco dicendo che posso sia immedesimarmi nell’altra persona, ma anche essere consapevole che le emozioni che provo potrebbero essere le stesse che prova anche lei.
Sei troppo sensibile! Non lo sei abbastanza!
“È solo sensibile”.
Quante volte avete sentito questa frase? Aldilà della presunta dilagante ipersensibilità che sembra colpire sempre più persone e che, invece, spesso è solo giustificazione per non assumersi responsabilità reali, la sindrome dell’iperempatia esiste e condanna la persona a un’esistenza davvero dura da sopportare. L’iperempatico è diverso dalla persona sensibile: non ha quasi mai una sua identità strutturata, ma è in balìa di ciò che le persone intorno a lui provano e di come queste si comportano.
L’iperempatico non si lascia solo coinvolgere dalle emozioni altrui, ma si lascia letteralmente travolgere e schiacciare da un peso che non gli spetta. Tale situazione non può che scatenare un disagio molto forte, generando una netta propensione all’isolamento e adottando misure cautelative antisociali e antirelazionali.

Al polo opposto, troviamo l’alessitimia, cioè l’incapacità di comprendere, elaborare e descrivere le proprie emozioni, tutte e solo una parte. Siccome questo è tassello fondamentale per la comprensione degli stati d’animo altrui, vien da sé che un alessitimico non è in grado di mettersi nei panni degli altri.
Non credo sia un caso che la maggior parte degli alessitimici siano di sesso maschile. Si parla, infatti, di “alessitimia normativa maschile” ed è importante prendere in considerazione questo aspetto. Culturalmente e socialmente, è sempre più difficile per un uomo dare voce alle proprie emozioni senza che subisca pressioni, prese in giro, insulti. Questa continua repressione dell’espressione emotiva (che è sempre sana e che va anzi incentivata nei bambini, di qualsiasi sesso, poiché indice di capacità di rielaborazione degli eventi) porta inevitabilmente a una repressione implicita della libertà di “provare ciò che è naturale provare in una determinata situazione”.
Gamification: l’importanza del videogioco nell’alfabetizzazione emotiva
Si possono ri-educare gli adulti alle emozioni?
È un tema difficile e non mi sento in grado di dare una risposta. Ciò di cui sono fermamente convinta è che si può lavorare facilmente sui più piccoli con un’alfabetizzazione emotiva mirata. Che è, volendo, anche la soluzione al problema già precedentemente affrontato della “violenza nei videogiochi”.
Tuttavia, siccome la vita è meravigliosamente ironica, come si può aiutare e supportare lo sviluppo emotivo? Come si può favorire l’alfabetizzazione emotiva? Semplice: giocando.
Come spiegato egregiamente in “Dungeons and Dragons tra empatia e assorbimento”, i giochi di ruolo (di carte o virtuali non ha, a quanto pare, molta importanza) permettono lo sviluppo delle capacità empatiche e di immedesimazione.
Come si legge nell’articolo:
«Spesso e volentieri si ha una visione del giocatore medio di D&D come di una persona “isolata nel suo mondo”, lontana da aspetti sociali ed emotivi della vita reale, forse senza nemmeno una grande comprensione delle dinamiche fra persone o della realtà che lo circonda.» In realtà «(…) i partecipanti hanno ottenuto una media superiore (nel questionario Davis IRI, usato nello studio n.d.r.) a quella della popolazione generale per quanto riguarda le sottoscale riguardanti l’empatia, senza che vi fosse alcuna differenza tra uomini e donne partecipanti allo studio».

Il videogame può quindi essere un valido alleato nello sviluppo e nella comprensione sana delle emozioni e dell’empatia e può esserlo in vari modi. All’inizio dell’articolo ho citato alcuni dei titoli che più hanno, a mio parere, una forte componente emotiva ed empatica, ma è ovvio che non siano adatti anche ai più piccoli.
Esiste però una simpatica app sviluppata con Unity, dalla grafica discutibile, ma dal contenuto decisamente azzeccato e dal gameplay “punta-clicca” estremamente semplice che si chiama Emodiscovery: ci si ritrova in diverse situazioni emotivamente particolari a dover interagire con un altro personaggio e a dover scegliere l’azione che secondo noi calza di più con lo stato d’animo del nostro interlocutore. Questo modus aiuta moltissimo i bambini a riconoscere le emozioni e a comportarsi empaticamente di conseguenza.
Condivido, in ultimo, questa riflessione da “Didattica, così i videogame aiutano l’apprendimento”:
«È nella possibilità di mettersi nei panni altrui che si estrinseca la possibilità di un videogiocare educativo; la possibilità di osservare il mondo attraverso segmenti di realtà altrimenti preclusi e capaci di coadiuvare la formazione di aspetti di empatia, cura, considerazione, supporto e lavoro di squadra.»