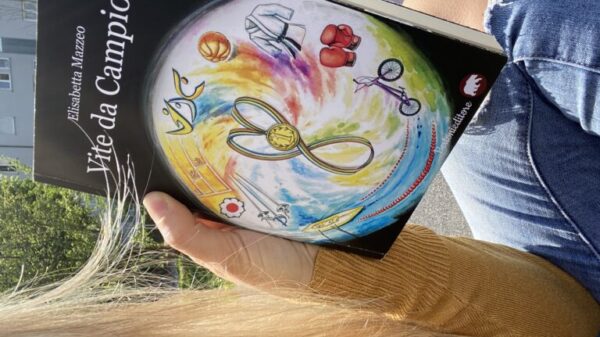Salone del Libro 2020: Dacia Maraini e il valore dei libri

“Stare in mezzo ai libri per me è una gioia. Il Salone è utile perché siamo un Paese dove si legge poco e le occasioni per rendere visibili i libri vanno incoraggiate. I libri dovrebbero circolare di più anche fuori dalle librerie”. Queste le parole di Dacia Maraini rilasciate nel corso dell’intervista per il Salone del Libro del 2014. Ancora oggi è lei uno degli ospiti più attesi del Salone, scrittrice prolifica di grande apertura intellettuale.

Note sull’autore
Dacia Maraini, candidata al Nobel per la Letteratura dal 2014, è una scrittrice apprezzata sia in Italia che all’estero per le sue opere di prosa, poesia, saggistica e drammaturgia, nelle quali affronta i temi dell’amore, della cultura, dell’identità e della società, visti attraverso gli occhi delle donne.
Nata a Fiesole nel 1936, la Maraini lascia l’Italia a soli due anni insieme alla famiglia per recarsi in Giappone, dove però, nel 1943, viene reclusa in un campo di concentramento a Tokyo per il rifiuto di riconoscere la Repubblica di Salò.
Al termine della guerra torna in Italia dove si stabilisce prima a Bagheria, presso i nonni materni, e poi a Roma. In questo luogo comincia a dedicarsi alla narrativa e incontra lo scrittore Alberto Moravia, suo partner dagli anni Sessanta fino all’inizio degli Ottanta.
Negli anni Sessanta la scrittrice pubblica il romanzo d’esordio La vacanza e si accosta anche alla drammaturgia, fondando nel 1973 il Teatro della Maddalena. Nella sua produzione si annoverano più di sessanta testi teatrali, tra i quali sono degni di nota Manifesto dal carcere e Dialogo di una prostituta con il suo cliente, che ebbero un forte impatto sociale.
Nella lunga carriera la Maraini ha ottenuto i più prestigiosi premi, medaglie e riconoscimenti: il Premio Campiello ricevuto nel 1990 per La lunga vita di Marianna Ucrìa (che ha anche venduto più di un milione di copie) e il Premio Strega nel 1999 per la raccolta di racconti, Buio.
Solitudine e Libertà al SalTo Extra
In collegamento con centinaia di persone la scrittrice esordisce manifestando il suo dispiacere per l’assenza del Salone fisico di quest’anno, poiché ne è una veterana.
Attiva all’interno delle scuole, spiega il perché sia importante leggere i libri, per lei equivale a riscriverli “mettere in moto l’immaginazione che è la cosa più viva, è il motore più potente del nostro corpo. Se non avessimo l’immaginazione saremmo morti, perché è la fonte della curiosità, dà il pensiero”, e l’immaginazione si sviluppa proprio con la lettura.
Secondo l’autrice leggere è anche viaggiare nel tempo e nello spazio, significa entrare in un luogo incantato diverso dal nostro, mediante i nostri sensi.
La Maraini ricorda agli studenti che esiste una differenza abissale tra formazione e informazione: l’informazione è moltiplicata dalla tecnologia e dalle forme digitali, la formazione invece è diversa, è una linea verticale che va in profondità. È qualità, non quantità, per tale motivo occorrono i libri.
Ribadisce anche di leggere i classici perché se un libro supera le generazioni vuol dire che va al di là e diventa universale, che insegna qualcosa e che funziona. Ciò non è detto per i libri moderni che invece funzionano nella contemporaneità, ma non si sa per il futuro.

Sceglie inoltre di affrontare due temi molto attuali durante la quarantena: la Solitudine e la Libertà.
Per la prima cita un libro di Joseph Conrad Il compagno segreto che si presta all’oggi perchè siamo soli con noi stessi a causa del coronavirus che ci ha isolati. Il racconto narra di un capitano che è solo su una nave e sente un rumore, va a vedere cosa succede e scorge un uomo, nudo e solo, che chiede asilo. Dopo averlo salvato il capitano lo guarda e si rende conto che è identico a sé stesso, è un doppio, e il protagonista ne è impressionato. Interrogandolo scopre che l’uomo si è macchiato di un crimine, e ciò allude al fatto che ognuno di noi possiede una parte sconosciuta, quasi violenta.
L’idea del doppio è particolarmente azzeccata in questo periodo di solitudine, soprattutto quando si interrompono i rapporti. Il nostro doppio è qualcosa che non vorremmo sapere ma che esiste e va affrontato.
L’altra parola analizzata dalla scrittrice è Libertà: cos’è? Non è facile spiegarla e non è semplicemente fare quello che si vuole perché la vera libertà vuole condizionamenti e leggi, deve confrontarsi con quella degli altri. A tal proposito la Maraini legge un brano estratto dal suo scritto La grande festa in cui ricorda la dura esperienza nel campo di concentramento giapponese, sottolineando anche il paradosso dell’essere in prigione per aver difeso la libertà di pensiero e di parola. Nonostante fosse ancora molto piccola, la scrittrice ricorda le parole del padre Fosco che le ripeteva spesso i versi danteschi messi in bocca a Virgilio nel I canto del Purgatorio:
« Or ti piaccia gradir la sua venuta:
libertà va cercando, ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta».