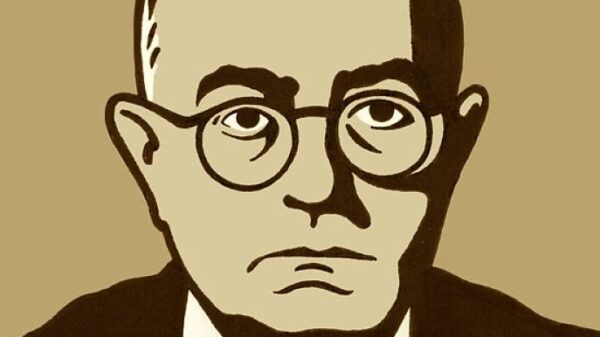Il potere dell’opposizione nella filosofia: frammenti di un rapporto illuminato

È dallo scontro creativo dell’Io che si auto-pone rispetto al resto – desideroso che il resto diventi estensione di sé e dunque non più forma estranea e respingente – che si manifesta il potere come decifrazione dell’esistente e azione. Il potere è lo spazio in cui adattamento e creazione si incontrano, rendendo la trasformazione atto. Dotato di una duplice natura, radice essenziale trascendente e espressione contestuale immanente, necessita di essere antropologicamente pensato come una delle parti più viscerali dell’umanità, anche al di fuori dei riverberi politici. La conoscenza – e dunque la filosofia – è la prima forma di azione consapevole sulla realtà. È la prima e più illuminata manifestazione del potere.
Dalla matrice oppositiva della vita alla microfisica del potere
Eraclito è il primo a riconoscere la potenza dell’opposizione e la forza creatrice dell’uomo nell’imprimere le sue condizioni nel circuito oppositivo della vita.
Panta réi, tutto scorre: realtà come eterno divenire di contrari, inesorabile avvicendarsi degli opposti. Il divenire di tutte le cose, essendo matrice di vita, non è caotico o disordinato, è al contrario regolato da leggi precise, racchiudibili in una legge fondamentale: la continua trasformazione di ogni contrario nell’altro. Lontano dalle asserzioni parmenidee per le quali il non essere – il vuoto, il nulla – non esiste, proprio perché non è, semplicemente perché sarebbe negazione dell’Essere. E lontano dall’inammissibilità della diversità dell’Essere, nell’Essere.
La realtà è costituita da coppie di forze oppositive e la vita non è garantita dalla conciliazione degli opposti, piuttosto necessita del mantenimento del conflitto. Perché nel conflitto e nella contraddizione ha modo di esprimersi il potere dell’uomo, la sua capacità di sfruttare la contraddizione non uscendone mai.
È in questa cornice che è possibile inquadrare la volontà di potenza, come necessità di attribuire forma individuale ad una realtà che esiste nostro malgrado. Nella volontà di potenza, Nietzsche rinviene quella capacità di compiere azioni creative e responsabili nelle quali il soggetto è in grado di riconoscersi. Superando il nichilismo, ossia l’atteggiamento di disorientamento nei confronti della realtà, e introducendo il concetto di oltreuomo – l’essere umano che accetta la vita come caos nell’eterno ritorno del suo scorrere – Nietzsche traccia le linee del potere inteso come forza creativa e dirompente dell’uomo capace di vivere la realtà accettandola e introiettandola senza rimanerne vittima passiva o indifferente, ma al contrario di divenire agente di cesura in grado di scrivere nuove reti valoriali e di significazione.
Se nell’incidere la realtà e nel modificarla l’uomo riesce a prendersene cura, nell’ambito della comprensione e della significazione è l’impronta decisionale del singolo a stabilire ciò che è.
La realtà rimane un connubio complesso ma di per sé equilibrato tra forze in opposizione anche quando viene ridotta ai paradigmi del non senso e della semplificazione. Ma è nell’opposto che conosco la misura della mia identità. E dall’opposto scaturisce il potere dirompente dell’affermazione di se stessi in una determinata porzione di tempo.
Nell’altro l’io riconosce e rispecchia se stesso. E Schmitt, convenendo con Protagora nella convinzione che l’uomo è misura di tutte le cose, introduce la categoria concettuale amico-nemico, individuandovi il grado massimo di unione e poi di separazione. Il nemico ci sfida e ci combatte. La distinzione amico-nemico è frutto di una decisione, è un atto politico e culturale: afferma la presenza di qualcuno riconoscendo e mettendo in discussione la presenza dell’altro, in virtù del proprio margine di potere.
Quello di Foucault è il pensiero della messa in discussione, del sovvertimento degli ordini precostituiti. Un pensiero che ruota attorno al potere, mai nella sua forma istituzionalizzata e manifesta, bensì nel suo farsi silenzioso, quotidiano e implicitamente agito. La microfisica del potere, dell’assoggettamento e del disciplinamento, delle dinamiche e dei ritmi lavorativi, delle cure mediche e psichiatriche, delle sanzioni e delle leggi penali, delle strategie carcerarie e dei tabù sessuali. È la fisica della pluralità dei poteri che entrano in contrasto tra loro.
Questo è il substrato della microfisica del potere, concentrata sulla micro-dimensionalità, del potere con la “p” minuscola. Ossia quel potere pervasivo, spicciolo e reale che riesce ad imprimere la fisionomia del reale. In Foucault il connubio tra sapere e potere si fa stringente e le sue estrinsecazioni concrete sono affette da una costante che è la tendenza all’omologazione del pensiero e all’univocità dei rapporti interpersonali.
È nelle vie che incontriamo ogni forma di potere. Sono le microforme del potere, le forme minuziose e trasversali che ci compongono. Sono i poteri di ogni attimo, dei ripostigli di tempo in cui dicendo si all’opposto che ci si palesa di fronte riscopriamo anche il potere di dire no a quanto non assume la nostra forma.