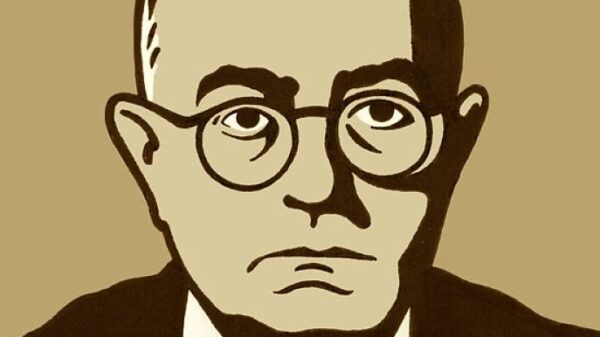La storia, la vita e la verità: John Stuart Mill
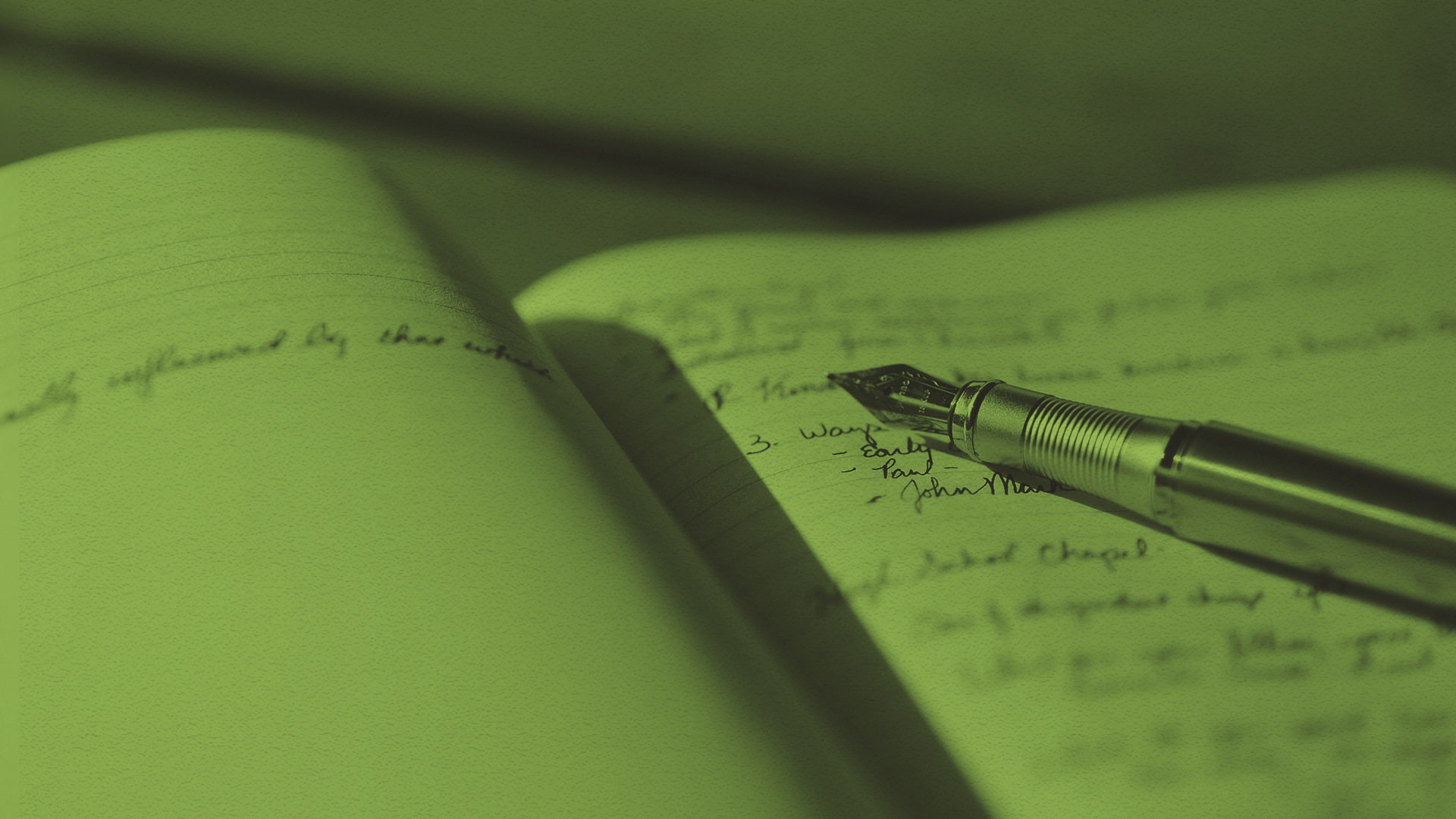
 In un celebre passo del ‘De Oratore’ Marco Tullio Cicerone attribuiva alla storia il titolo di maestra di vita (magistra vitae), di testimone dei tempi (vero testis temporum), di luce della verità (lux veritatis), di messaggera della verità e di vita della memoria (nuntia vetustatis e vita memoriae). Credo che Cicerone avesse ragione: non si può prescindere dalla storia in nessun ambito del sapere e dell’agire umano. La filosofia, e più esattamente la parte che si occupa dello studio del pensiero di autori passati, ne è un chiaro esempio. Non capiremmo la filosofia moderna occidentale (Cartesio, Hobbes) senza considerare le guerre di religione, gli scritti dell’ultimo Kant — che pochi si danno la briga di studiare, fermandosi alle tre Critiche — senza considerare la rivoluzione francese e il suo sviluppo o il dibattito filosofico-politico tra liberali e comunitaristi senza inserirlo nel quadro di una progressiva e inesorabile globalizzazione. Credo altresì che del passo da cui siamo partiti vada evidenziato un ulteriore elemento, unico oltre alla verità ad essere ripetuto due volte: la vita. In una suggestiva interpretazione possiamo immaginare la storia e la vita come i due poli che,secondo Cicerone, dobbiamo tenere insieme per arrivare alla verità. Ma cosa si intende per ‘vita’ e in che modo è collegata con la storia? I due concetti, infatti, sembrano sovrapporsi. In questa sede non pretendo di rispondere con un’argomentazione rigorosa ma voglio provare a spiegarmi con tramite un esempio, tratto ancora dalla storia del pensiero, nel quale i vaghi termini fino ad ora considerati potranno assumere una veste concreta.
In un celebre passo del ‘De Oratore’ Marco Tullio Cicerone attribuiva alla storia il titolo di maestra di vita (magistra vitae), di testimone dei tempi (vero testis temporum), di luce della verità (lux veritatis), di messaggera della verità e di vita della memoria (nuntia vetustatis e vita memoriae). Credo che Cicerone avesse ragione: non si può prescindere dalla storia in nessun ambito del sapere e dell’agire umano. La filosofia, e più esattamente la parte che si occupa dello studio del pensiero di autori passati, ne è un chiaro esempio. Non capiremmo la filosofia moderna occidentale (Cartesio, Hobbes) senza considerare le guerre di religione, gli scritti dell’ultimo Kant — che pochi si danno la briga di studiare, fermandosi alle tre Critiche — senza considerare la rivoluzione francese e il suo sviluppo o il dibattito filosofico-politico tra liberali e comunitaristi senza inserirlo nel quadro di una progressiva e inesorabile globalizzazione. Credo altresì che del passo da cui siamo partiti vada evidenziato un ulteriore elemento, unico oltre alla verità ad essere ripetuto due volte: la vita. In una suggestiva interpretazione possiamo immaginare la storia e la vita come i due poli che,secondo Cicerone, dobbiamo tenere insieme per arrivare alla verità. Ma cosa si intende per ‘vita’ e in che modo è collegata con la storia? I due concetti, infatti, sembrano sovrapporsi. In questa sede non pretendo di rispondere con un’argomentazione rigorosa ma voglio provare a spiegarmi con tramite un esempio, tratto ancora dalla storia del pensiero, nel quale i vaghi termini fino ad ora considerati potranno assumere una veste concreta.
Uno dei personaggi più discussi e studiati dai filosofi e dagli economisti — quei pochi, ahimè, che si assumono ancora l’onere di studiare il pensiero economico – è John Stuart Mill, figura di spicco del pensiero britannico del XIX secolo. Figlio d’arte, il padre James Mill era infatti un famoso filosofo scozzese, insieme a Jeremy Bentham uno dei maggiori esponenti della corrente dell’utilitarismo, Mill ebbe un’ampia formazione storico-filosofica, valorizzata da una insolita capacità di apprendimento. L’amicizia con il filosofo Bentham acuisce il contatto con la visione antropologica dell’utilitarismo secondo cui l’uomo sarebbe un agente individuale teso a massimizzare la propria utilità. Il concetto aristotelico di felicità come fine ultimo dell’azione umana viene ridotto dai primi filosofi utilitaristi all’utilità intesa come ricerca del piacere e, a livello della società, alla ricerca della massima felicità per il maggior numero. Ogni prospettiva sulla socialità, per cui le relazioni con altri individui vengono considerate come parti costitutive dell’essere umano e componenti fondamentali della felicità, viene abbandonata e inglobata in una ragione strumentale nella quale ciò che conta è il calcolo mezzi-fini per raggiungere il piacere.
Un’altra influenza importante nella formazione di Mill fu Adam Smith, padre dell’economia moderna, di cui all’incredibile età di 13 anni Mill aveva letto le opere maggiori. Smith, a sua volta influenzato dall’idea humeiana di cooperazione senza benevolenza, fondava la socialità nella sfera economica sul mutuo vantaggio, cioè sull’idea che perseguendo il proprio interesse i singoli individui, anche tramite l’azione di un meccanismo impersonale, promuovessero il bene della società. Le profonde relazioni interpersonali come l’amicizia e l’amore vengono distinte qualitativamente ed emarginate dall’economia dove, in ogni caso, sussistono virtù di fiducia e cooperazione fondate sul mutuo vantaggio. Considerata la comune matrice antropologica individualista non è difficile comprendere come l’utilitarismo, quasi un secolo dopo le idee di Smith, avrà una forte influenza sul pensiero economico.
Da questa breve ricostruzione emergono due punti rilevanti. Primo, per capire il pensiero di Mill non lo si può disgiungere dal pensiero dei suoi contemporanei e predecessori. La storia, anche considerando che Il filosofo inglese visse a cavallo tra la fine della Prima Rivoluzione Industriale e gli albori della Seconda, e che pertanto venne a contatto coi movimenti cooperativi e socialisti-utopisti, si rivela ancora una volta maestra e preziosa alleata. Secondo, date le premesse da Mill ci aspetteremmo una rivisitazione, anche in chiave critica, dei temi dell’economia moderna e dell’utilitarismo. Basta aprire un qualsiasi manuale di storia della filosofia per capire la fondatezza della nostra previsione. Mill rivisita in modo originale le tesi del padre e di Bentham e offre un contributo prezioso alla storia del pensiero economico e sociale. Ma studiando il pensiero di Mill, entrando letteralmente nel suo modo di pensare attraverso i testi, si evince la parzialità della spiegazione storico-concettuale e la presenza di qualcos’altro che deve aver influenzato il filosofo britannico. L’altro a cui mi riferisco è la vita e precisamente l’incontro con la moglie Harriet Hardy Taylor. Allineandomi con la tesi espressa dall’economista italiano Luigino Bruni ritengo che sia l’incontro con la Hardy, a sua volta filosofa, ad aver segnato profondamente Mill portandolo non soltanto ad una impensabile (per i tempi) apertura verso le tesi femministe ma anche verso una concezione relazionale della felicità e del suo ruolo all’interno dell’economia. Vediamo in che termini.
Anzitutto Mill critica l’amico Bentham per aver considerato l’utilità come unico movente delle azioni umane, quando nella realtà dei fatti troviamo piaceri di varia natura. Così il filosofo inglese in Utilitarismo: “Sarebbe assurdo supporre che la valutazione dei piaceri dipenda solo dalla quantità, quando invece per valutare tutte le altre cose si prende in considerazione anche la qualità, oltre la quantità”. Ma la critica è ancor più radicale, dato che Mill ritiene riduttivo considerare l’utilità come unico movente delle azioni e parte costitutiva della felicità. Poche pagine più avanti scrive: “E non c’è neanche alcuna intrinseca necessità che un essere umano debba essere un gretto egoista, privo di qualsiasi sentimento o di qualsiasi preoccupazione non incentrati sulla propria miserabile individualità. Persino oggigiorno, capita abbastanza spesso di imbattersi in qualcosa di enormemente superiore […] un affetto privato autentico e un sincero interesse per il bene pubblico sono entrambi possibili, anche se in gradi diversi, per qualunque essere umano cresciuto ed educato bene”. La felicità-utilità degli altri (o pubblica) non è semplicemente un mezzo per aumentare l’ utilità individuale, come diceva Bentham, ma qualcosa che ha valore di per sé e come tale merita di essere perseguita. In questo modo Mill di distacca anche da Smith, per il quale ricordiamo che erano meccanismi impersonali a favorire una positiva socialità, e si inserisce inconsapevolmente nel solco dell’economia civile, tradizione del settecento italiano, dove attraverso un particolare mix di aristotelismo, cristianesimo e illuminismo la relazionalità e le virtù civiche erano concepite come prerequisito della cooperazione nella sfera economica e parti integranti della felicità. Così Mill, in un passo che potrebbe benissimo essere stato scritto dall’economista ‘civile’ Genovesi: “Io non ho mai, infatti, vacillato nella convinzione che la felicità sia il test di tutte le regole di condotta, e lo scopo do tutta una vita. Ma ora credo che questo tipo di felicità possa essere ottenuto soltanto non facendone direttamente uno scopo. I soli che sono felici (credo) sono quelli che hanno le loro menti fissate su alcuni obiettivi altri rispetto alla loro propria felicità: sulla felicità degli altri, sul miglioramento dell’umanità […] perseguiti non come mezzi, ma come in se stessi dei fini ideali”.
Non c’e stato contatto diretto tra Mill e Genovesi e la frequentazione con i movimenti cooperativi di certo non è sufficiente a spiegare una visione antropologica così intima e profonda. È Mill stesso a rivelarci, nella sua Autobiografia, che è il rapporto con la Hardy ad averlo aveva portato a certe conclusioni: “ l’amicizia che è stata l’onore e la principale benedizione della mia esistenza, e allo stesso tempo la fonte di una gran parte di tutto quello che ho cercato di fare, o che spero di effettuare in futuro, per il miglioramento umano” (corsivo mio). Il rapporto di amicizia con la donna amata — non sembra casuale che un altro filosofo della socialità, Aristotele, avesse una considerazione altrettanto ampia dell’amicizia — è per Mill la relazionalità sperimentata nella vita personale, diventata poi paradigma per una concezione dell’umano basata sulla socialità. Così Bruni a riguardo: “Mill considerava l’idea della vita della coppia e, in generale, del matrimonio come ‘agape’, cioè, come un’unione fatta di reciprocità che, allo stesso tempo, esalta sia l’individualità di ogni partner che le loro complementarietà”. E sempre Bruni a riportare un passo simile di Genovesi, dove amicizia e amore trovano una collocazione insolita per i nostri tempi: “l’amore è una passione istintiva, che dura davvero poco nella coppia sposata. L’amicizia è invece un’affezione ragionevole, proveniente dalla considerazione e dalla scelta. Io non credo che due persone saranno sempre innamorare tra loro; è difficile, se non impossibile. Però possono essere amici.. Due persone sono amiche per natura e per scelta, e tra amici ogni bene e ogni male è messo in comune. Nulla accresce di più l’amicizia che condividere sinceramente con un amico ogni piacere e dispiacere, e in questo modo far diventare due cuori un cuore solo”.
Con poche citazioni non pretendo di aver dimostrato alcunché; lo spazio e la libertà concessi da un articolo di giornale mi hanno permesso soltanto di far fluire — sono sincero, neanche l’ho riletto in toto prima della pubblicazione — alcune suggestioni emerse da letture disparate. Probabilmente è questa la prova più evidente del legame tra vita e pensiero che oggi vi ho offerto.
Paolo Santori
14 febbraio 2016