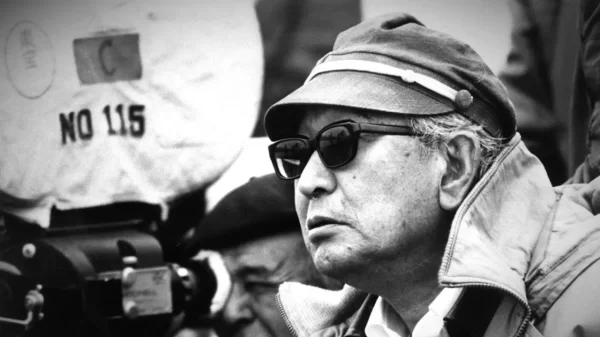Mondocane è un atto d’amore per Taranto. Parla Alessandro Celli

Intercettare Alessandro Celli in questi giorni non è affatto semplice. Dopo la presentazione al Festival di Venezia del suo film d’esordio, presentato durante la Settimana della Critica, il regista di Mondocane si è buttato di nuovo a capofitto sul set.
Eppure, Alessandro Celli, l’esperienza di Mondocane se la porterà addosso per molto, molto tempo ancora.
Lo raggiungiamo telefonicamente durante una pausa dal set e subito la nostra conversazione verte su quella che forse è la vera protagonista della storia: la città di Taranto.
Perché Mondocane è sì un film dalle molte chiavi di lettura, ma innanzi tutto è «un atto d’amore per Taranto».
Hai proposto una storia molto particolare. Lavorare con i film di genere in Italia oggi non è semplice, nonostante nell’ultimo periodo stiano uscendo lavori che ispirano molta fiducia. Com’è partita l’idea di un film distopico ambientato a Taranto?
Avevo nel cassetto l’idea di fare un film che fosse un racconto di formazione e che si potesse ambientare in un contesto visionario, dalle regole primordiali, semplici, che preparasse il terreno a una storia fatta di relazioni e sentimenti.
Allo stesso tempo, la miccia che ha fatto innescare il tutto è stata l’intuizione che questo mondo potesse nascere dalla cronaca, invece che dalla sola fantasia come avviene il più delle volte. Non solo come fantasia, quindi, ma un film quasi provocatorio.
Un po’ come accade in altre distopie. Se mi lasci ti cancello di Michel Gondry, per esempio, è una distopia a tutti gli effetti, anche se non viene raccontato come tale, e ho trovato che questo sia molto interessante.
Sono partito quindi dai fatti di cronaca e mi sono chiesto “che cosa accadrebbe se non ci fosse una soluzione al problema”, se — come nel caso di Taranto — la gente dovesse continuare a vivere un dilemma ingiusto come la scelta tra lavoro e salute, mentre intorno continui a perdere familiari.
C’è stata una gestazione per creare questo mondo, all’interno del quale incastrare il percorso di formazione dei ragazzi.

Oltre alla distopia, c’è tanto di sociale. Mi viene in mente La paranza dei Bambini di Saviano. Hai già citato Se mi lasci ti cancello, quali sono stati gli altri riferimenti, se ci sono stati, sia letterari che cinematografici?
Ho avuto tanti riferimenti, ma mai legati ai gangster movie italiani, perché volevo raccontare un mondo disperato ma solare. Forse c’è un’atmosfera quasi africana, un mondo in cui non c’è niente ma si può essere comunque felici. Non ho mai digerito i racconti criminali di baby gang in cui l’atmosfera è cupa e lugubre. Io voglio raccontare il sogno dei ragazzi, e quindi voglio farlo nella maniera più solare e colorata possibile. Io voglio stare con loro.
E questo esce fuori, anche nella scelta dei protagonisti. L’amicizia tra i due ragazzi è palpabile sin dalle prime scene del film. Mondocane è stato definito un “neorealismo punk”, che forse rievoca un certo discorso zavattiniano nel dirigere i bambini…
Un paragone super lusinghiero: il neorealismo è stato un momento ben definito, un momento davvero importante del nostro cinema che ha lasciato il segno. C’è chi dice che Mondocane sia un film orwelliano, ma stiamo scomodando personaggi davvero importanti. Io però non ho guardato in maniera specifica questi riferimenti, sono stato attratto più dal cinema sudamericano, ad esempio, perché lo trovavo più in linea con quello che volevo raccontare. Volevo recuperare suggestioni simili a quelle di Tropa de elite, quando la polizia specializzata entra nelle favelas…
Proporre una storia distopica a Taranto con protagonisti due bambini non credo sia stato semplice, com’è stato? Avete trovato accoglienza fin da subito?
La mia fortuna è Matteo Rovere. Ha voluto che io scrivessi una storia da cucirmi addosso, una storia nelle mie corde e che avesse gli ingredienti giusti per farmi esordire presentandomi al meglio. Io non potevo chiedere di più, perché questo film non è solo un racconto di formazione – che era il nostro punto di partenza -, ma è anche un film che può permettersi una star importante (Alessandro Borghi, ndr.), che ha dato tantissimo al film. Alessandro Borghi porta risorse, attenzione mediatica e, soprattutto, porta idee: sul set ha avuto spunti incredibili e ci tengo a ricordarlo e puntualizzarlo.
Quando si lavora bene con un attore, ti fai anche carico di tutta una serie di responsabilità che ti consentono anche di variare la sceneggiatura, di metterti in gioco su cose che pensavi fossero già scelte. Con lo scambio – quando funziona – tutto diventa più vivo. Io tante cose le ho adattate, perché se è una buona idea, il film si arricchisce. E anche Alessandro Borghi si è cucito addosso il progetto, il film, il personaggio.
Groenlandia, Minerva Pictures, Rai Cinema e 01 Distribution sono state fantastiche. È un esordio inedito per certi versi, sia per quello che abbiamo proposto, sia per il modo in cui abbiamo deciso di eseguirlo. Non credo sia stato facile per Matteo Rovere, anche se lui, lo sappiamo, è capace di cose straordinarie. Però è andata bene, si è innamorato della sceneggiatura, il che ha velocizzato parecchio lo sviluppo.

Groenlandia, tra l’altro, proprio per il cinema di genere, si sta impegnando molto. Mondocane, però, ha un qualcosa di più, non è solo un film di genere…
Sì, ha sullo sfondo un tema derivato dalla cronaca, ma questo film non è uno spot negativo sulla città di Taranto, assolutamente no. È anzi un atto d’amore! Una denuncia di uno stereotipo che si è ormai cristallizzato — erroneamente — nelle menti di molti, ovvero che Taranto è una città inquinata.
Ci sono posti ben più inquinati, ma non vengono comunicati come tali. Taranto invece è associata immediatamente alle acciaierie, alla raffineria…
Io, invece, che adoro tutto di quelle terre, ho fatto questo film con il cuore. Per questo ci ho tenuto tantissimo a coinvolgere sul set le persone di Taranto, che mi potessero aiutare nella ricerca dei luoghi veri e nella ricerca del linguaggio e delle espressioni dialettali. Avevo un dialogue coach, ruolo ricoperto da un attore tarantino bravissimo, (Pierfrancesco Nacca, ndr.) che mi ha aiutato con il dialetto.
In un momento storico in cui le persone guardano sempre meno i film in sala…
In effetti questo è un problema. Negli ultimi anni la maggior parte delle persone si è disabituata ad andare al cinema per via della pandemia. E in generale la narrazione da serialità televisiva trovo che abbia un linguaggio totalmente diverso, perché si può seguire la vicenda mentre si fa altro. Un po’ il contrario di ciò che accade quando ti immergi nel racconto cinematografico e per due ore resti totalmente rapito da una narrazione totalizzante.