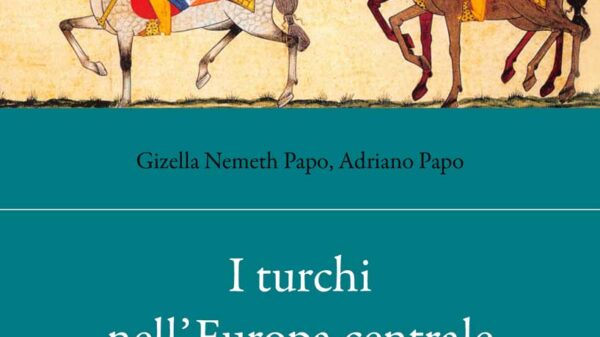Le confessioni di mezzanotte di Salavin

È mezzanotte e, in quella nebulosa atmosfera che pervade ciò che appare come un locale notturno, un uomo intavola una conversazione con un avventore. La sua identità e la posizione esatta rimangono ignote, tuttavia emerge chiaramente che l’uomo ha un bisogno impellente di sfogarsi, di aprire le porte della sua anima per purificarla da un dolore antico, sedimentato nell’abisso della sua essenza per troppo tempo. Inizia quindi un incessante flusso di coscienza, attraverso il quale il lettore della “Confessione di mezzanotte” (G. Duhamel, Ago Edizioni) viene a conoscenza che colui che parla è Louis Salavin, un modesto impiegato. Ci troviamo a Parigi, durante quel luminoso periodo che viene ricordato come la Belle Époque, un’epoca dorata che sembra però aver scelto di voltare le spalle a Salavin: l’uomo conduce infatti un’esistenza monotona, grigia e triste, incentrata sull’arida routine lavorativa presso l’azienda Socque et Sureau, dove svolge con riluttanza l’insignificante mansione di correttore testi riguardanti le mietitrebbie. Un ruolo che accetta a malincuore, costretto dalla sua precaria situazione economica.
Un giorno, Salavin viene chiamato dal dirigente per sbrigare alcune noiose pratiche burocratiche e, mentre attende di completare il suo compito, accade qualcosa di inatteso, straordinario, quasi surreale: l’attenzione di Salavin viene catturata da un particolare, il lobo dell’orecchio del signor Sureau. Quel minuscolo lembo di pelle esercita su Salavin un’attrazione magnetica, una sorta di ossessione feticista accompagnata da un irresistibile istinto di toccarlo, di percepirne la morbida consistenza; quel gesto ipotizzato è l’inconscia metafora della necessità del protagonista di rompere con le convenzioni sociali per trovare una forma di autenticità e di realizzazione personale sfiorando qualcosa di apparentemente irraggiungibile. La brama di sondare quell’angolo di cartilagine sfida persino la ragione stessa: Salavin perde il controllo, tocca il lobo di Sureau e scoppia un pandemonio che culmina con il suo fulmineo licenziamento.
Il protagonista si ritrova dunque costretto ad abbandonare il suo ufficio e inizia a vagare senza meta per la Ville Lumière con la mente in tumulto e il cuore in subbuglio, mentre riflette sul cammino che ha percorso fino a quel momento, facendo un bilancio della sua esistenza. Il lettore si trova di fronte a un uomo che, a soli trent’anni, sembra essere diventato l’epitome di tutte le miserie umane, oscillando tra la sensazione di essere il libero flâneur di Baudelaire, che vaga senza meta per le strade del quinto arrondissement di Parigi, e il nauseato e insofferente coetaneo Roquetin, vergato dalla penna di Sartre, convinto di essere oppresso dalle ingerenze dell’esistenza e incapace di nobilitare il suo passaggio sulla Terra. Inizia così un lungo monologo interiore, un eloquio imperioso spesso perentorio, durante il quale l’io narrante riavvolge il nastro dei ricordi e ripercorre la propria giovinezza borghese e gli anni della prima maturità.
Un elemento centrale di questa narrazione sono le relazioni familiari, segnate da una profonda ambivalenza: da un lato, l’affetto per una madre che ha sempre provveduto a lui, avviluppandolo in un amore morboso e soffocante, quasi tossico; dall’altro, il desiderio di emancipazione da quel rigido controllo. Anche i legami sentimentali e amicali vengono analizzati con attenzione, tra desideri, delusioni e rimpianti.
Emergono riflessioni sul senso del peccato e della colpa, sulla ricerca dell’affermazione personale in un mondo borghese i cui principi morali sono saldi; il bilancio dell’io diventa implacabile man mano che emergono i rimpianti per le opportunità perdute.
Con uno stile conciso e sobrio, attraverso brevi capitoli che seguono il flusso dei ricordi, Duhamel crea un raffinato affresco psicologico e una confessione intima dell’anima. Il tono adottato è quello di far i conti con sé stessi, di porre interrogativi fondamentali sull’esistenza stessa e di sondare le profondità dell’interiorità umana.