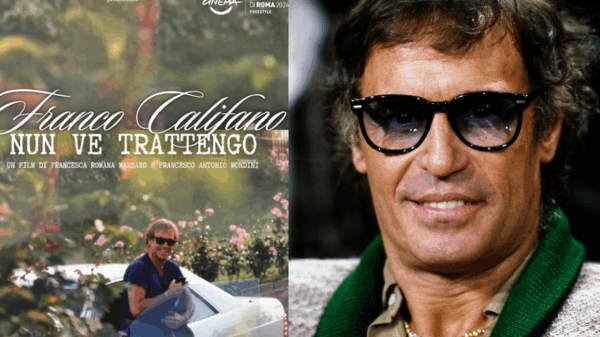In memoria di Franco Battiato: il centro di gravità si è solo spostato più in là

Ne ho lette e sentite già tante, da quando stamattina ho aperto i social. Talmente tante che ho pensato che l’ennesimo necrologio fosse inutile. Che si sarebbe perso, come sempre accade alla morte di un artista, nel marasma di titoloni e corsa agli armamenti che si smuove quando un pezzo di storia (musicale, in questo caso) ci viene tolto.
Ho pensato che Battiato avrebbe preferito il silenzio, niente sceneggiate, niente notizie urlate sui social, niente frasi ricordo. Ho pensato che avrebbe preferito andarsene così come si era defilato dalle scene negli ultimi tre, forse quasi quattro anni, senza troppi fronzoli, senza spiegazioni aggiuntive.
Un po’ lo sapevamo tutti che non stava bene, anche senza conferme. Perché uno come lui, sempre iper-creativo, sempre pieno di idee, quando si ferma è solamente per qualcosa di grave, difficile e faticoso. Come una malattia.
Ma se è pur vero che il silenzio è una forma di rispetto, dall’altra, da musicista, so anche che a volte la miglior cura è far casino. Non ce ne volere, Maestro, ma questo ci sembrava il miglior modo per ricordarti.
A nome di tutta la sezione di Musica.
«Non si può amare una “scienza” finché non si sa di cosa si tratta» (Il mondo nuovo)
In una vecchia intervista del 1976 di RaiTre, “Incontri con la musica elettronica”, la cronista sottolinea immediatamente una particolarità di Battiato che se oggi può sembrare scontata, 40 anni fa era stratosferica: «La musica elettronica è ancora poco popolare in Italia, tranne che nel caso di Franco Battiato (…).»
Mai frase fu più azzeccata.
Quando un anno prima la coppia Battisti-Mogol aveva tirato fuori una minimal e “acustica” Fiori rosa fiori di pesco, nel 1971 Battiato scrive Fetus, album tratto da Il mondo nuovo di Huxley (1932), utilizzando l’EM VCS3.
No, giuro, non sono lettere a caso.
L’EM VCS3 è il nome di uno dei primi sintetizzatori “portatili” mai inventati. Nato nel 1969 dalla testa di Zinovieff, dell’Electronic Music Studio, aveva un suono caldo, etereo, ma oscuro e inspiegabile, perfetto per il concept album di Battiato.
Se questo suono vi ricorda, giustamente, qualcosa è perché sì: The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd ne contiene a carrellate. Ma è uscito quasi quattro anni più tardi di Fetus.

Sul palco con lui, tuttavia, presto non portò solo sintetizzatori sempre diversi e musicisti incredibili, ma anche giradischi usati come scratch ben prima dell’hip-hop e radio sintonizzate su frequenze a onda corta come noise (l’onda corta è più o meno quando cercate una stazione radio e l’unica cosa che riuscite a sentire, invece, è un gran casino).
La sperimentazione, in quegli anni, era la sua unica regola; l’unica musa ispiratrice, invece, la tecnologia e l’elettronica. Delle recensioni o dei giudizi degli altri, a Battiato, è sempre importato molto poco. Per non dire quasi niente.
Cerco ancora il mio centro di gravità permanente
Arrivati a questo punto, ripercorrere le tappe della sua carriera sarebbe inutile e dannoso. Prima di tutto perché non basta un articolo (ma nemmeno tre o quattro), secondo poi perché esiste Wikipedia, esiste Youtube e non so essere né uno né l’altro.
Ciò che mi interessa, in questo piccolo paragrafo conclusivo, non è tanto la genialità indiscussa e indiscutibile di Franco Battiato, quanto più una piccola interpretazione, quasi un ringraziamento.
Conosciamo tutti, sicuramente, Centro di gravità permanente, del 1981.
Quando è uscita non ero nemmeno nata (probabilmente nemmeno stata pensata), eppure ho due ricordi molto chiari a riguardo.
Il primo è una vaga memoria, quasi un’impressione, di mia mamma che la canticchia mentre armeggia in cucina. Avrò avuto cinque o sei anni e ascoltavo rapita quelle parole, pur capendone meno della metà del significato, chiedendomi come fosse possibile che in casa mia si passasse dalla cupa voce di De Andrè a quella scanzonata e leggera di Battiato- cosa che effettivamente avrei capito solo molti anni dopo.
Il secondo ha a che fare con una me adulta che ha ri-approcciato questa canzone, per puro e fortuito caso, all’inizio dell’era Covid e si è resa magicamente conto che quel centro di gravità permanente esiste davvero, anche se a volte ce ne dimentichiamo.
Nell’interpretazione del Maestro, il “centro di gravità” è la definizione del sé reale, attorno al quale l’essere umano si può fare spettatore della vita, osservatore, mai interprete ma attivo custode e essere incoraggiante verso altri “sapienti”, come la vecchia bretone col cappello e l’ombrello di carta di riso o i capitani coraggiosi.

In un momento come quello in cui stiamo vivendo, nel quale ogni certezza viene meno e il futuro è tutt’altro che roseo, tornano forti i versi di questa canzone:
“Cerco un centro di gravità permanente/ che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.”
Certo, solo gli stolti non cambiano mai idea sulle cose, sulla gente o sulla vita. Ma sarebbe bello – e ne avremmo tutti un disperato bisogno di un quarto di quel centro che, con la stessa stoica certezza che aveva Battiato parlando delle sue opere, ci permetta di stare ancora saldi sulle nostre gambe, nonostante tutto.
Che sia l’inizio di un lungo viaggio, Maestro. Noi continueremo a cercare il nostro centro di gravità permanente.