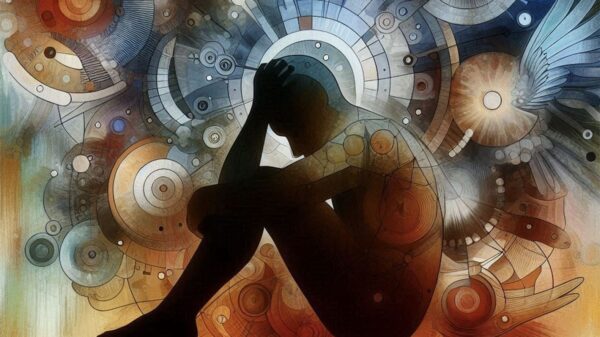Poliferie. Orientamento post diploma nelle periferie, «le aree con più risorsa e talento»

Dopo aver parlato del Laboratorio Zen Insieme dello Zen di Palermo, ci siamo dedicati ad un’altra iniziativa, quella di Poliferie, un’organizzazione senza scopo di lucro che si occupa di fare orientamento post diploma agli studenti delle scuole superiori delle varie periferie italiane. Ne abbiamo parlato con Alessandra Ausanio, volontaria di Poliferie e coordinatrice del team Napoli, cercando di arrivare al cuore del progetto che ha come finalità la riduzione «di ogni tipo di disuguaglianza, da quelle sociali a quelle economiche, intervenendo nelle periferie che – a nostro giudizio – sono le aree in cui possiamo riscoprire più risorsa e talento ma meno possibilità di svilupparlo». A riprova del fatto che possiamo ciò che sappiamo, abbiamo raccontato un progetto la cui ricchezza fondamentale è il saper mostrare l’alternativa per far comprendere che le possibilità esistono, il vero problema è non conoscerle.
Presentiamo Poliferie. Quando nasce? Quali sono le attività che svolgete?
Poliferie è un’organizzazione senza scopo di lucro, nata il 2 novembre 2017, che si occupa di preparare gli studenti al futuro, quindi alla formazione e al lavoro. Ci concentriamo sulle scuole superiori tecnico-professionali delle periferie delle principali città italiane, dove cerchiamo di offrire un servizio di orientamento post diploma, organizzando degli incontri preformativi con degli esperti di settore che praticano la loro opera volontariamente, senza alcuna forma di retribuzione o simile. Stiamo sviluppando anche una piattaforma da scaricare sul cellulare, ai fini dell’orientamento, per poter accompagnare gli studenti che rientrano nei nostri progetti, così da garantire un percorso continuo.
Qual è l’idea che ha dato vita a Poliferie?
L’idea è scaturita da un’esperienza diretta di Andrea Zorzetto, il fondatore, che appena terminato il liceo da Casale Monferrato si è trasferito a Londra ed ha subito il forte impatto del passaggio dal piccolo centro alle grandi periferie londinesi. Da qui l’idea di incidere nello spazio che intercorre tra centro e periferia. E poi ha trovato in noi volontari facili sostenitori del progetto. Ci siamo conosciuti attraverso un corso di formazione.
Su quali zone vi state concentrando?
Il progetto pilota del 2017 si è svolto a Frascati. Nel 2018/2019 ci siamo espansi a Milano e a Torino e tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020 ci siamo portati anche su altre città. In questo momento copriamo anche Genova, Pisa, Napoli, Bari, Vibo Valentia e Palermo.

Per ora abbiamo una scuola per ogni città, in ragione al numero di volontari che, pur aggirandosi sui 70, sono distribuiti sulle varie zone di lavoro. Ogni città ha un team che si occupa della logistica degli incontri nelle scuole. Su Milano e Torino, che sono state le nostre prime città, stiamo cercando di avere la seconda scuola.
Prima parlavi di esperti di settore, come si strutturano i vostri incontri nelle scuole?
Organizziamo cinque incontri durante l’anno scolastico focalizzati su specifiche tematiche. Il primo e l’ultimo vengono svolti dai volontari di Poliferie, perché sono gli incontri che introducono e che tirano le fila del progetto, mentre gli incontri più specifici si concentrano su tre macroaree, Tecnologie, Relazioni ed Idee, e sono organizzate soltanto logisticamente dai volontari perché ad intervenire sono gli esperti dei relativi settori. Tra questi esperti di public speaking per quanto riguarda le Relazioni, come Alberto Castelvecchi, oppure ingegneri informatici per le Tecnologie o specialisti nelle risorse umane per le Idee.
Riscontrate differenze tra le varie città in cui lavorate? Ci sono periferie che rispondono meglio e periferie che mostrano più problematiche?
Questa era una delle nostre principali preoccupazioni soprattutto all’inizio quando siamo partiti con Milano e Torino, ma ci tenevamo a spostarci anche al sud proprio per evitare un disequilibrio. Io posso parlare di Napoli, in quanto coordinatrice del team Napoli, e la mia è stata un’esperienza positiva: ho incontrato una vicepreside molto proattiva, che non ha mai fatto mancare il suo supporto all’iniziativa. Al tempo stesso gli studenti sono sempre stati molto partecipativi ed entusiasti nei confronti del progetto. Posso sicuramente dire, pur non potendo parlare per gli altri, che non ci sono state grandi differenze tra gli studenti del nord e del sud, se abbiamo rilevato delle differenze, queste sono dovute a questioni di coordinamento didattico. Per esempio a Vibo Valentia abbiamo riscontrato maggiori difficoltà proprio nell’organizzazione di partenza.
Quindi è un lavoro che porta dei risultati. Riuscite a far iscrivere gli studenti delle scuole superiori all’università?
Monitoriamo attentamente il percorso degli studenti che rientrano nel nostro progetto, abbiamo un team di ricerca e sviluppo che si occupa esattamente di questo: sottoponiamo dei questionari all’inizio del progetto e alla fine per vedere proprio in quale misura riusciamo ad incidere. La valutazione dell’impatto è senz’altro positiva, se non altro ci sono dei margini di miglioramento nella conoscenza delle opportunità, che prima degli incontri con Poliferie erano più ridotte. Non possiamo garantire che effettivamente si iscrivano ma sicuramente sono interessati a conoscere le varie realtà.
Quali sono i problemi principali che incontrano i ragazzi delle scuole periferiche e allo stesso tempo quali sono i loro sogni e le loro aspettative?
Ripeto, parlo più specificamente della realtà di Napoli, ma quella che sto per fare è una considerazione piuttosto condivisa. Sicuramente il problema principale è la mancanza di informazione. Il motivo per cui noi ci inseriamo in questi contesti è l’asimmetria informativa: i ragazzi di questi istituiti hanno un accesso limitato a quella che può essere la realtà post diploma.

La maggior parte di loro, anche semplicemente per la tradizione dei contesti familiari di provenienza, si orienta immediatamente alla scelta lavorativa o comunque cerca di approcciare immediatamente il mondo del lavoro. Questo ovviamente non è un demerito ma va ad accrescere la categoria dei cosiddetti NEET, ossia coloro che non hanno né un percorso lavorativo in atto né uno scolastico/universitario. Il loro problema principale è questo, la mancanza di un collegamento tra il momento storico che vivono e le possibilità post liceo. E i loro sogni sono in questo senso condizionati, perché la maggior parte di loro, soprattutto all’inizio del percorso di Poliferie, non ha intenzione di intraprendere il percorso dell’università.
La vostra ricchezza principale quindi è quella di mostrare l’alternativa, di far comprendere che le possibilità ci sono, il problema è non conoscerle.
Esattamente e in questo senso cerchiamo anche, attraverso dati e statistiche in ambito europeo, di mostrare quali possano essere le possibilità anche al di fuori dell’Italia.
Salutiamoci con delle pillole che facciano “conoscere” un po’ i ragazzi delle periferie che avete incontrato.
Non ho storie specifiche da raccontare perché per scelta instauriamo rapporti equi con tutti i ragazzi per garantire la parità di trattamento. Li conosciamo ma non nelle loro storie più intime e difficili. A Napoli ho sempre incontrato storie di vita eterogenee: chi ha uno dei genitori lavoratore e l’altro no, oppure chi ha genitori separati e chi no. Ci sono stati anche un paio di casi di non attitudine al progetto, dall’altra parte, sia a Napoli che a Vibo Valentia, c’è chi non prevede un percorso in Italia, molti di loro hanno intenzione di evadere dalla Calabria e non tornare più.
Cosa ti sta lasciando questa esperienza nelle scuole delle periferie?
Mi sta lascando la concretezza, la soddisfazione di fare qualcosa di concreto e di avere un impatto abbastanza consistente. C’è la possibilità di incontrare, sviluppare e coltivare il talento.