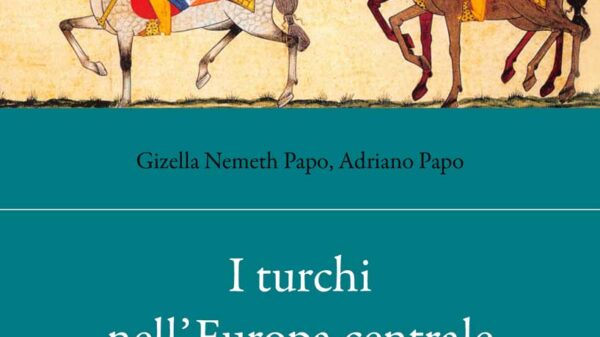“Merci senza frontiere”: un’alternativa eterodossa agli errori del mercato globale

Container traboccanti di merci solcano incessantemente le onde dei mari. Dall’Asia all’Occidente, l’acciaio che puntella gli Oceani non dorme mai, così come il mercato globale. Oltre il 90% degli scambi di prodotti nel mondo segue lo sciabordare dell’onda marina, infranta dalle nere scie di carburante.
Il sistema del commercio internazionale e delle merci senza frontiere è centro pulsante del cuore del postfordismo, la forma del capitalismo finanziario e trans-nazionale globale. Finito il trentennio glorioso dell’Europa, la stagflazione degli anni settanta incrinò il paradigma keynesiano e il pragmatismo del protezionismo temperato post-bellico. Non era più il tempo del Piano Beveridge e del Piano Monnet, ma la nuova era della signora d’acciaio e della Reaganeconomics.
Finanziarizzazione, deregolamentazione e privatizzazione: questi i tra passaggi cruciali del nuovo corso dell’economia internazionale. La ricetta del vantaggio competitivo basato sull’iperspecializzazione diveniva la formula per competere nel mondo senza barriere doganali, aperto alla libera concorrenza. Importare ciò che non si è in grado di produrre a bassi costi ed puntare alla produzione di singoli settori merceologici a prezzi altamente concorrenziali.
Gli Stati Uniti, forti del nuovo sistema post Bretton-Woods dollaro-centrico, e l’Europa puntarono sulla delocalizzazione di parte delle catene produttive manifatturiere nei paesi con bassi salari e scarse norme di controllo su ambiente e diritti. Il fenomeno del decoupling spostava lavorazioni inquinanti lontano dall’occhio Occidentale, allungando la supply chain di semilavorati e componentistica.
Il mercato globale cresceva, le zone in via di sviluppo cercavano la fuga della povertà in cambio di inquinamento e sfruttamento della manodopera. Nel frattempo, interi settori produttivi USA e UE venivano archiviati in favore di un futuro basato sui servizi mentre le rust belt iniziavano a puntellare il Nuovo e il Vecchio Continente. Le fabbriche cominciavano a chiudere, le acciaierie limitavano la produzione, la piena occupazione cedeva il passo alle ristrutturazioni aziendali e il futuro dei colletti blu diveniva opaco.
In tale quadro, la crescita delle importazioni di beni diveniva elemento sempre più preponderante limitando di fatto l’impiego di tutta la forza produttiva in grado di essere dispiegata dai principali sistemi produttivi occidentali in nome del vantaggio competitivo. La pressione sui salari del mondo sviluppato cresceva, mentre la precarizzazione del lavoro assumeva forme sempre più aggressive, minando le conquiste sociali raggiunte.
Una possibile alternativa alle “merci senza frontiere”?
Un’alternativa all’ipertrofia del commercio globale è possibile? Come spiegano i professori di economia politica Aldo Barba e Massimo Pivetti nel loro nuovo libro “Merci senza frontiere”, edito da Rogas, una risposta concreta non può essere affidata a teorie della decrescita felice o ad un impostazione di carattere marginalista.

Come la cronaca economica evidenzia nel caso Usa degli alti investimenti per l’Inflaction Reaction Act, per i due accademici la soluzione in grado di permettere la conquista di una piena occupazione appare quella di mettere in campo tutte le risorse della produzione attraverso un processo di limitazione e sostituzione delle importazioni in favore dello sviluppo di settori produttivi specifici mediante barriere tariffarie, la crescita della domanda interna e il ruolo dello Stato come innovatore.
Per i due accademici il ritorno ad una politica industriale da parte dello Stato-nazione è un tassello fondamentale per contrastare la disoccupazione e i processi di deindustrializzazione, limitando allo stesso tempo le alte emissioni di CO2 emesse per lo spostamento delle merci. L’ambito nazionale appare in tal senso l’unico reale scenario all’interno del quale lavoratori e parti sociali possano recuperare un reale ruolo nei processi economici.