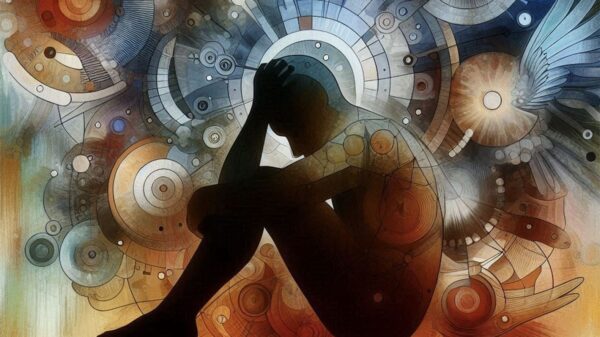Una guerra che sembra un vecchio film

Se c’è un film che potrebbe suggerirci che tipo di atteggiamento avere nei confronti del conflitto russo-ucraino, quel film dovrebbe essere Tiro al piccione, esordio alla regia di Giuliano Montaldo nel lontano 1961.
La storia non ci dirà nulla in merito alle vicende che stanno accadendo in queste ore alle porte di Kiev, essendo ambientata in Italia, nei giorni successivi all’armistizio dell’8 settembre del ’43, eppure, la tesi portata avanti da Montaldo nei 114 minuti della sua prima pellicola appare oggi come un preziosissimo alleato per non lasciarsi trascinare dagli isterismi di una guerra esplosa sul pianerottolo di casa nostra.
Nel raccontare le vicende di Marco Laudato, un giovane repubblichino fedelissimo al Duce, le cui certezze vengono gradualmente riscritte dagli attimi finali della guerra, la sceneggiatura firmata da Ennio De Concini, Luciano Martino, Fabrizio Onofri e lo stesso Montaldo lanciava un messaggio decisamente anticonformista per i tempi, ossia quello di porre l’altra guancia nei confronti del nemico ormai sconfitto. A un certo punto del film, Marco si ritrova completamente isolato, non sa più distinguere quali sono gli alleati e quali i nemici.

Ciò che come cittadini europei dovremmo evitare — e che invece si sta puntualmente verificando — è quella tempesta emotiva che induce necessariamente a schierarsi per una o l’altra fazione in questo momento interessate nel conflitto, tradendo quell’obiettività necessaria per giudicare i fatti che ci avvengono intorno.
È chiaro, non si possono certo giustificare le azioni di Putin, nel momento in cui le sue politiche aggressive mettono in discussione la libertà e l’autodeterminazione di un popolo che si emancipa entro i confini nazionali.
Ma è altrettanto vero che l’espansionismo russo non nasce oggi, così come non nasce oggi un regime di cui soltanto adesso mettiamo in discussione la democraticità.
È di pochi giorni fa una legge della Duma che punisce con la detenzione fino a 15 anni chi divulga fake news nei confronti dell’armata russa, ed ancora più recente è la decisione di non utilizzare più la rete internet globale per gestire una struttura indipendente su cui veicolare propaganda e messaggi interni.
Dovremo avere il coraggio di perdonare i nostri e i loro atteggiamenti, equanimemente compromessi. Perché le intenzioni russe erano manifeste sin dalla fine degli anni ’90, con la firma del Trattato di unione tra Russia e Bielorussia e poi con un la Guerra in Georgia, l’occupazione della Crimea e l’appoggio dei separatisti del Donbass.
Allo stesso modo, era difficile non aspettarsi delle reazioni al progressivo spostamento dei confini NATO verso Est (dal 1999 ad oggi hanno aderito al trattato Atlantico nell’ordine: Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Repubbliche Baltiche, Romania, Slovacchia, Slovenia, Albania, Croazia, Montenegro e Macedonia del Nord).

Nel corso degli anni la globalizzazione ha intensificato i rapporti commerciali tra Russia ed Europa, rendendo il Vecchio Continente sostanzialmente dipendente dagli approvvigionamenti di gas provenienti dall’ex Unione Sovietica. La propaganda di Mosca ha avuto addirittura degli incoraggiamenti, grazie ad eventi sportivi quali le Olimpiadi invernali di Soči nel 2014 e i Mondiali di calcio svoltisi quattro anni più tardi.
L’Unione Europea in questo momento si trova a pagare a caro prezzo la sua mancanza di identità e sembra essere la parte più cagionevole tra quelle coinvolte nel conflitto: gli USA riescono a indebolire i rapporti tra UE e Russia senza ricorrere all’impegno militare in Ucraina; la Russia già si muove per aggirare le sanzioni occidentali intensificando i rapporti con tutti quei paesi attualmente neutrali (un mercato di almeno 2 miliardi e mezzo di persone, se si considerano paesi come Cina, India e stati africani).

Come suggeriva Montaldo nel suo film, dovremo saper andare oltre. Andare oltre i capovolgimenti di fronte tutti italiani di quelle forze politiche che tutt’oggi appartengono alla maggioranza di governo e che fino all’altro ieri affermavano con convinzione di voler intensificare le sinergie tra il nostro paese e il Cremlino (e contestualmente con la Cina, attraverso la Via della Seta).
Dovremo fare un passo indietro per provare ad avere una panoramica a volo d’uccello sulle tante implicazioni geo-politiche del conflitto.
Dovremo recuperare quella lungimiranza che Bruxelles sembra aver perduto nel corso degli anni e definire una agenda con parole chiave precise, che evitino di far pagare la guerra a cittadini e imprese. Una su tutte? Sostenibilità.
Se la transizione ecologica e l’utilizzo di energie rinnovabili fossero iniziati già dopo l’invasione russa della Crimea, forse oggi non ci troveremmo nella annosa posizione di chi, indirettamente, finanzia la guerra in Ucraina perché dipendente dalle risorse di Mosca.
Ma la storia non si scrive né con i “se”, né con i “ma”. E ancor meno la si interpreta senza considerare lucidamente cause ed effetti. Quello, semmai, è il modo migliore per fare la fine del piccione…