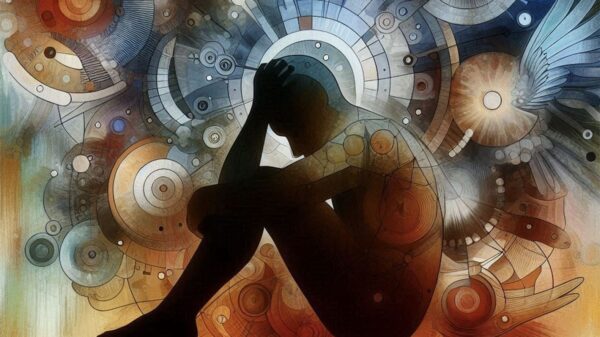Tutti i mondi possibili della libertà di espressione: croce e delizia di un diritto inalienabile

Oggi parliamo della libertà di espressione, un diritto incontestato, su cui siamo tutti d’accordo. Partiamo dalle sue formulazioni che lo pongono a pieno titolo tra i diritti fondamentali dell’uomo.
Abbiamo, innanzitutto, la prima proposizione dell’articolo 21 della Costituzione italiana.
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
E poi abbiamo l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Si parla in questi giorni della libertà di espressione, di manifestazione e riunione dei cittadini, a seguito di recenti vicende che hanno avuto grande risonanza nel dibattito tra i media e nell’opinione pubblica. Partiamo dal caso molto discusso del rave party di Modena, che ha dato il via ad uno dei primi provvedimenti del Governo Meloni nella forma di un decreto legge.
Consultando direttamente il sito del Governo, si legge che «Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta dei ministri Nordio e Piantedosi, un decreto-legge che introduce il reato di invasione di terreni o edifici allo scopo di organizzare raduni, di oltre 50 persone, pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica. La nuova fattispecie prevede la reclusione da 3 a 6 anni, una multa da 1.000 a 10.000 euro e la sanzione accessoria della confisca degli strumenti e dei mezzi utilizzati per organizzare il raduno illegale».
Una tale formulazione ha scatenato l’opinione pubblica e risvegliato l’opposizione ancora scossa dalla sconfitta elettorale, ma ha generato qualche perplessità anche nella maggioranza, con una richiesta da parte di Forza Italia di modificare la lettera del decreto. Qual è il problema? Innanzitutto la norma, non menzionando esplicitamente il caso dei rave-party, rimane troppo generica e rischia di poter essere applicata a qualsiasi raduno o riunione di varia natura di 50 persone o più. L’unico criterio che sembra discriminare cosa vada fermato è la “pericolosità”. Un criterio tutt’altro che univoco.
Connesso alla formulazione per così dire larga del decreto, c’è l’ulteriore questione, che ha sollevato aspre critiche, della sua contrarietà rispetto a ben due articoli della Costituzione, l’articolo 21 che abbiamo appena menzionato sulla libertà di espressione, e l’articolo 17.
Articolo 17 della Costituzione
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
L’articolo 17, tra l’altro, mostra come “comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica” fossero già previsti a motivare un’eventuale interruzione o il divieto di riunione di cittadini in luogo pubblico. Va precisato, per l’appunto, che spesso i cosiddetti rave party sono non autorizzati o prevedono l’occupazione di luoghi dismessi, abbondati, anche proprietà private. Dunque al netto della formulazione del decreto o della sua effettiva (e contestata) urgenza, possiamo dire che si è introdotta una “nuova” fattispecie di reato punibile con pene severe.
Ma… che ne è dei reati già esistenti? In particolare uno, di cui si è parlato durante la campagna elettorale, di cui si parla ad ogni 25 Aprile, di cui si parla da anni più o meno strumentalmente, più o meno convintamente dalle diverse parti della politica e dell’opinione pubblica. Continuiamo a farci guidare ancora dalla Costituzione. L’apologia di fascismo è regolamentata dalla legge del 20 giugno 1952, n. 645, nota anche come Legge Scelba.
Articolo 1
Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.
Articolo 4
Chiunque, fuori del caso preveduto dall’art. 1, pubblicamente esalta esponenti, principii, fatti o metodi del fascismo oppure le finalità antidemocratiche proprie del partito fascista è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 500.000.
Articolo 5
Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire cinquantamila.
A parte la romantica menzione del vecchio conio, le lire, c’è stato un altro evento che ha fatto molto discutere insieme al caso del rave di Modena, che si è svolto il 30 ottobre in occasione e in memoria del centenario della Marcia su Roma del 28 ottobre del 1922. Predappio, comune romagnolo della provincia di Forlì-Cesena, che ha dato i natali a Benito Mussolini. Ma questa è naturalmente storia nota.
Quanto accaduto lo scorso weekend a Predappio come si deve valutare? È o non è apologia di fascismo? È o non è definibile come manifestazione fascista? Al giorno d’oggi che cos’è che si può o si deve considerare apologetico o nostalgico del disciolto partito fascista?
Due alternative sono possibili, tertium non datur (forse?).
Prima alternativa. Il corteo di Predappio del 30 ottobre NON è manifestazione fascista. Rientra nella libertà di espressione, libertà di manifestare e riunirsi. Non c’è il rischio, a pensarla così, di porre sullo stesso piano un omaggio alla tomba di Mussolini e, per esempio, una manifestazione sul clima, in quanto entrambe espressioni della libertà di manifestazione o riunione? Si tratta della stessa libertà di manifestare? Ha ragione il Presidente del Senato La Russa, quando dice che ogni volta che cerchiamo di insabbiare il nostro passato, che annovera anche il ventennio fascista, stiamo facendo della cancel culture? (ammesso che condannare un evento per apologia di fascismo sia insabbiare il passato e non intervenire su un reato).
Seconda alternativa. Il corteo di Predappio del 30 ottobre È manifestazione fascista. Se fosse così, perché nessuno è intervenuto, perché le Forze dell’Ordine non sono intervenute? Tra l’altro, il corteo di Predappio presta il fianco ad essere considerato un caso specifico da regolamentare secondo il nuovo decreto appena introdotto (il limite di 50 persone a Predappio è stato ampiamente superato). Se il criterio dirimente del nuovo decreto legge anti-rave è la pericolosità, cosa definisce un evento pericoloso? Riunirsi per manifestare in nome di un’ideologia antidemocratica come quella fascista non è considerato sufficientemente pericoloso, solo perché de facto non cadrà addosso a nessuno un tetto come nel caso del rave di Modena, dal momento che i ragazzi sono stati fatti sgomberare, sembrerebbe, per la pericolosità della struttura? Se così fosse, urge chiarirci sul concetto di “pericolo” per la società!
Il corto circuito non sta nel continuare a parlare di rischio del fascismo come l’incombente pericolo di finire sotto dittatura. Il punto è: quando si parla di apologia di fascismo, quando siamo di fronte ad una manifestazione fascista e quando si deve intervenire per fermarla? Non basta fare il saluto romano (ricordiamo la partecipazione del fratello di La Russa al funerale di Alberto Stabilini, un militante dell’estrema destra milanese, quando si è omaggiato il camerata defunto con il saluto romano)? Non bastano i saluti romani fatti dalle persone a Predappio? Non basta la commemorazione della marcia su Roma o il discorso della pronipote di Mussolini?
Quando siamo di fronte ad un caso di apologia di fascismo così eclatante da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, esattamente come è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine nel caso del rave party di Modena? Cosa si deve considerare un conclamato caso di apologia di fascismo o una manifestazione dichiaratamente fascista? Che criterio ha in mente lo Stato per discriminare un’azione passibile di costituire apologia di fascismo o di essere una manifestazione fascista, da azioni che non lo sono nella loro sostanza? Tra l’altro, è notizia di pochi giorni fa che si stanno svolgendo accertamenti e che sarebbero otto le persone tra i partecipanti del corteo di Predappio, indagate, per l’appunto, per aver effettuato il saluto romano e per ostentazione di simboli fascisti.
Il corteo di Predappio è un appuntamento che si ripete da anni, tanto che viene considerato come un fenomeno quasi folkloristico, di costume. E pensare che ci sono persone che considerano la pizzica salentina o la tarantella napoletana come fenomeni di folklore! A parte le battute, è evidente che in qualche forma o in qualche misura un problema c’è. Che cos’è che non stiamo capendo o non stiamo cogliendo? C’è qualcosa che va preso sul serio di queste vicende?
Luca Bizzarri nel suo podcast Non hanno un amico, nella puntata Que viva el Duce del 3 novembre, parlando della vicenda Predappio, ci stuzzica con un pensiero. «I nostalgici sono loro o siamo noi? – cosa accadrebbe – Se la nostalgia della sinistra fosse più forte di quella della destra». Forse è la sinistra che è davvero l’unica nostalgica e legata mani e piedi ad una narrazione che si svolge secondo la dicotomia fascismo/antifascismo? Senza il fascismo, è la sinistra di oggi che perde la sua identità?
Su una vicenda come quella di Predappio, che è poi solo l’ultimo esempio di una serie ben lunga di casi simili di cui spesso si torna a parlare, stiamo forse commettendo un errore di valutazione per eccesso o difetto? Stiamo sottovalutando simili fenomeni? O, al contrario, stiamo sovrastimando quello che, nel concreto, è un piccolo manipolo di persone attaccate a eventi che sanno di storia o di passato glorioso, folkloristico, più che di concreto pericolo antidemocratico? C’è un problema di istruzione e educazione? C’è un problema di ignoranza della nostra storia italiana e di cosa è stato il fascismo? Dovremmo puntare di più sull’insegnamento nelle scuole della nostra storia dall’Impero Romano ai giorni nostri?
O invece dobbiamo riconoscere che esiste una libertà di dirsi fascisti oggi? Dovremmo davvero essere tutti d’accordo sul dirci antifascisti o no? Dobbiamo concedere spazio al dissenso, finché questo dissenso non diventa pericoloso? Qual è la soglia di pericolo che possiamo permetterci prima di vedere la nostra Costituzione e la nostra società seriamente minacciate?
Sono solo domande queste, ma domande su cui, in ogni caso, vale ben la pena di riflettere, senza sensazionalismi, senza essere necessariamente faziosi da un lato e dall’altro, ma con spirito critico. È lo spirito critico che ci salverà, sempre.