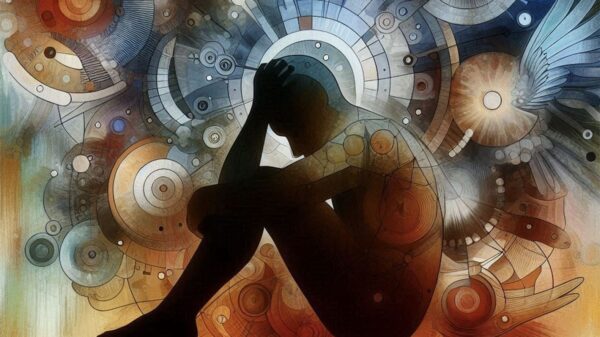La scomparsa della politica cattolica

Tra i numerosi commenti che sono stati fatti riguardo alle recenti elezioni presidenziali in Francia, ce n’è uno che merita qualche considerazione in più. Queste elezioni, è stato detto, hanno rappresentato anche la disfatta dei cattolici. Il candidato che sicuramente ne rappresentava di più le posizioni ed era cattolico lui stesso, François Fillon, non è riuscito neppure ad arrivare al ballottaggio, lasciando lo spazio ad un candidato laico sostanzialmente in continuità ideologica con il Partito Socialista e una candidata altrettanto laica che al massimo poteva aspirare a rappresentare alcune posizioni «societali» dei cattolici. Ma siamo sicuri che sia proprio una disfatta per i cattolici della figlia primogenita della Chiesa, come un tempo si diceva? È vero che il candidato cattolico non è arrivato al ballottaggio, ma ci è andato vicinissimo con un accettabile 20%, di gran lunga superiore al disastroso 6% del Partito Socialista (e con il sospetto che abbia perso la partita solo per lo scandaletto famigliare in cui è stato invischiato). La campagna elettorale è stata dignitosa, ricca di temi seri, e comunque ha visto ben presenti e riconoscibili le voci cattoliche. Una volta decisi i candidati per il ballottaggio, un’attesa non piccola riguardava la posizione che sarebbe stata presa dalla Chiesa (che comunque si è prevedibilmente astenuta da indicazioni di voto). Insomma, la parola «disfatta» sembra esagerata.
Ma il problema è soprattutto che, se usiamo questa parola per la Francia, per l’Italia dobbiamo inventarne una nuova. Da un punto di vista sociologico, la presenza cattolica in Italia è di gran lunga maggiore che in Francia, si potrebbe pensare che il bacino elettorale sia ghiotto. Eppure, ancora una volta ci stiamo incamminando verso elezioni politiche in cui una sensibilità cattolica non sarà rappresentata da nessuno dei grandi partiti e nessuno dei loro leader. Non è ovviamente in questione la loro fede personale e quella di numerosi politici: ma il fatto che nessuno dei temi che potrebbero essere caratteristici di una visione cristiana del bene comune sarà, che piaccia o no, minimamente presente. Una visione diversa dell’economia? Non pervenuta (benché eccellenti economisti che hanno idee diverse e cristiane ci siano eccome). Il ripudio della guerra se non come estrema legittima difesa? Non pervenuta anch’essa (in fondo, se uno Stato senza alcun diritto comincia a bombardarne un altro per «punirlo» è una giusta e proporzionata reazione, no?). Difesa della vita più debole? Eutanasia alla svizzera no, ma insomma andiamoci vicino e lasciamo la responsabilità ai giudici che daranno le loro interpretazioni. Un’idea della scuola e dell’Università come luoghi di formazione umana e civile e non come allevamenti per futura manodopera? Meglio adeguarsi, in fondo siamo nell’era della Quality Assurance. E così via. Su queste cose si può avere una posizione o un’altra, siamo in democrazia, alla fine vince la maggioranza: ma chi volesse che su questi temi, e altri, fosse almeno contata la propria sensibilità cristiana, o comunque ispirata alla cultura cristiana, per che cosa o chi dovrebbe votare?
In altri anni sarebbe stato normale replicare: per fortuna non c’è nessuno che in politica porta avanti una prospettiva religiosa, le sfere debbono essere tenute distinte. Oggi questa risposta non convince più. Un motivo è di metodo, ed è il fatto che il rapporto tra sfera secolare e sfera religiosa appare oggi cento volte più complesso che in passato. E come la mettiamo se perfino la secolarizzazione dell’Occidente appare figlia del cristianesimo, che ha messo in circolazione il principio mai prima d’allora concepito secondo cui bisogna «dare a Cesare quel che è di Cesare»? interdire qualsiasi influenza religiosa non significherebbe paradossalmente riaprire la strada ad una confusione in cui peraltro tante altre entità sono pronte a reclamare un posto assoluto? Il Mercato, per esempio, come oggi tanti enfaticamente denunciano.
Ma, anche lasciando queste discussioni là dove devono stare, cioè nelle aule universitarie e sulla scena culturale, c’è un motivo di merito più semplice e forse più solido: il fatto cioè che una politica senz’anima alla fine dura poco. Un tempo le anime erano fin troppe: durante il Novecento grosso modo l’anima socialista, l’anima liberale, l’anima cristiana. Tutti grandi ideali, forse grande utopie, che però appassionavano, facevano sentire la voglia di lottare per qualcosa di grande. È questo che ha dato vita al sogno della Comunità Europea, talvolta con accordi, talaltra con compromessi, ma generando alla fine un’idea composita di umanesimo che ha dato buone prove di sé. Che cosa è ne rimasto ora, in condizioni profondamente mutate? La crisi dei partiti socialisti sembra purtroppo inarrestabile: in tutta l’Europa è grande la perdita di credito di una sinistra che pare appiattita su diritti individuali che un tempo si sarebbero sprezzantemente qualificati «borghesi». L’anima liberale sembra essere esaurita, priva di quel comunismo che per decenni è stato il suo mortale nemico, e pure le rivendicazioni in sé ragionevoli dei valori etici implicati nella libertà di impresa paiono fuori luogo in molti casi, per esempio di fronte alla dilagante precarizzazione del lavoro o alla crescita di potere di multinazionali con bilanci ben superiori a quelli di molti Stati. Sembrerebbero le circostanze giuste perché il cristianesimo si senta ancor più impegnato a proporre un’anima alla politica: di anima dovrebbe essere esperto, in fondo. Priva di anima la politica rischia altrimenti di apparire sempre più come una burocratica gestione dell’esistente, o un enorme gioco pubblicitario, una battaglia tra strategie di comunicazione in cui ciò che dovrebbe essere più importante, cioè la felicità delle persone, in fin dei conti è irrilevante come appunto in qualsiasi campagna pubblicitaria. Questa non è la fine delle ideologie, come spesso si ripete: è la fine degli ideali e delle idee.
Sembrerebbero le circostanze giuste, insomma, ci si potrebbe aspettare almeno la voce originale di una minoranza creativa, si fa politica pure quando si è certi di essere all’opposizione: come in Francia, appunto. In Italia non è così. Sarebbe importante interrogarsi sulle cause di questa completa disfatta: qui sì che la parola è giusta.