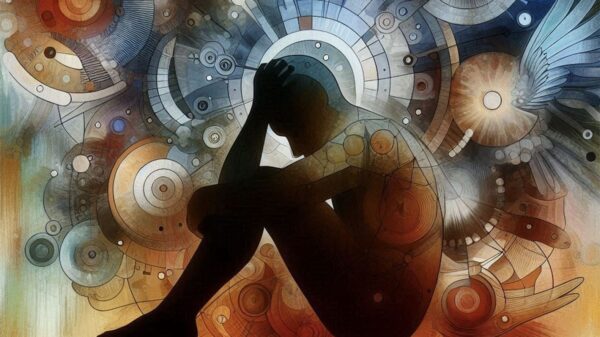Schiavitù: una certezza. Dal XIII emendamento alle moderne tratte di schiavi
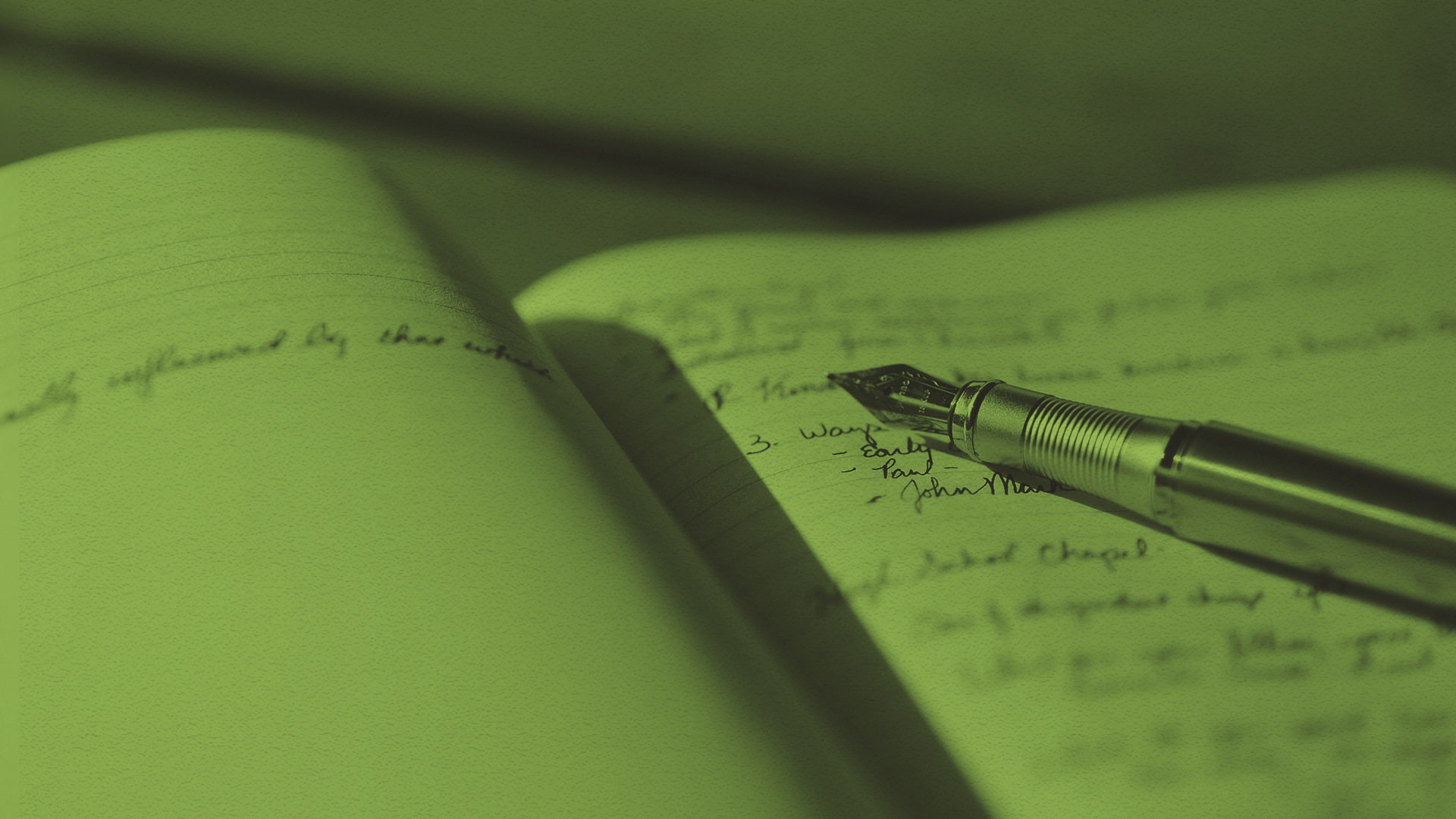
L’uomo è ambizioso, vendicativo e rapace. La formula della schiavitù in una semplice frase.
Scriveva così Hamilton nel 6° saggio del Federalista (1787-1788), documento volto alla difesa della nuova Carta Costituzionale degli Stati Uniti d’America (17 settembre 1787).
«I. La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura.
II. Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo».
Così il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti aboliva l’istituzione della schiavitù. Ieri, 18 dicembre, ricorreva l’anniversario dell’entrata in vigore dell’emendamento.
Iter dell’emendamento
La liberazione degli schiavi negli Stati Uniti era avvenuta già qualche anno prima, nel 1822, grazie all’azione dei governi e al Proclama di emancipazione. Questo comprendeva due provvedimenti esecutivi promulgati dal presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, durante la guerra civile americana. Il primo ordine esecutivo, emanato il 22 settembre 1862, decretava la liberazione di tutti gli schiavi dai territori degli Stati Uniti a partire dal 1 gennaio 1863. Il secondo ordine elencava formalmente una lista di dieci stati nei quali il primo ordine doveva essere attuato. Quindi rimasero esclusi dal provvedimento i cosiddetti border states: Deleware, Kentucky, Missouri e Maryland, dove continuava ad essere considerata legale e legittima l’istituzione della schiavitù.
Lincoln continuò ad intendere e a sostenere l’abolizione dello schiavismo come una misura permanente, una necessità socio-politica e giuridica, a prescindere dallo stato di guerra.
L’emendamento che riguardava l’abolizione permanente su tutto il territorio degli Stati Uniti fu approvato al Senato l’8 aprile 1864, ma subì una brusca frenata presso la Camera dei Rappresentanti che, in un primo momento, lo respinse, per poi approvarlo nel gennaio 1865 con 119 voti favorevoli, 56 contrari e 8 astenuti. La proposta definitiva venne inviata ai singoli Stati per la ratifica e formalizzata dal segretario di Stato, William Henry Seward, il 18 dicembre 1865.
Un’abolizione di forma
Lo schiavismo proseguì indisturbato grazie ad un passaggio dell’emendamento stesso, nel quale veniva riconosciuta la schiavitù come «punizione di un reato per il quale l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura». Dunque nessun nero poteva essere considerato uno schiavo a meno che non fosse un criminale. La conseguenza di tale distinzione antropologica – non soltanto razziale – fu uno smisurato ricorso alla carcerazione, durante la quale i detenuti diventavano schiavi di Stato, costretti ai lavori forzati.
Media e giornali erano intenti nel far passare presso l’opinione pubblica un chiaro messaggio: popolazione nera = criminalità = legittima schiavitù. I neri venivano costantemente dipinti come stupratori di bambine bianche, ladri, malfattori e molestatori seriali. Erano sostanzialmente divisi in due gruppi: i neri carcerati e i neri senza un posto di lavoro fisso. Da qui, la segregazione razziale.
Il razzismo diventò un fenomeno legale, un sentimento comune e condiviso, tanto che il Ku Klux Klan (nato proprio intorno al 1866) riuscì a seminare terrore e accumulare morti con linciaggi e impiccagioni di uomini neri, sospettati anche solamente di aver guardato una donna bianca.
I neri erano severamente puniti ogni volta che trasgredivano le leggi razziali: quando in autobus occupavano posti riservati ai bianchi, quando usavano bagni riservati ai bianchi, quando entravano nei bar riservati ai bianchi, quando volevano andare nelle scuole riservate ai bianchi.
Nixon inaugurò la stagione della guerra alla droga per incarcerare quanta più gente possibile nera, omosessuale, militante per i diritti civili, pacifista e femminista facendola passare per drogata. Il tema dell’ordine e della sicurezza pubblica divenne il cavallo di battaglia anche nel governo Reagan e Clinton. Il carcere toglieva il diritto di voto, il diritto all’istruzione nei colleges e alle borse di studio, il diritto al lavoro. Insomma il diritto ad un futuro dignitoso.
La schiavitù contemporanea
La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), all’articolo 4, stabilisce che «nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma». Nonostante ciò il Global Slavery Index quantifica il numero degli schiavi odierni in 45,8 milioni di persone. Nel mondo, su mille persone, tre sono sono schiave. Di cui tre quinti donne, due quinti uomini e più di un quarto minorenni.
Dalle catene di lavoro forzato di donne e bambini, ai flussi migratori, dalla tratta mondiale della prostituzione, alla vendita delle mogli, dal reclutamento di bambini soldato al commercio di organi per il mercato nero.
L’International Labour Organization ha calcolato che i lavori forzati riescono a produrre guadagni vicini ai 150 miliardi di dollari ogni anno. La schiavitù è considerata una fra le principali fonti di profitto per la criminalità organizzata, seconda soltanto al narcotraffico.
Circa il 58 per cento delle persone schiave nel mondo vive principalmente in 5 Paesi: India, Cina, Pakistan, Bangladesh e Uzbekistan. In Europa, 1,2 milioni di persone possono essere considerate schiave: Turchia e Macedonia raggiungono lo 0,6 per cento della popolazione in stato di schiavitù.
Lo schiavismo sessuale
L’International Labour Organization ha stimato che le schiave sessuali, nel mondo, sono 12 milioni e 300 mila, per affari che ammontano a 32 miliardi di dollari all’anno.
Soltanto in Italia la prostituzione ha un giro di affari di 90 milioni di euro al mese, che vanno ad arricchire le frange della criminalità organizzata. Solo sul territorio italiano sono presenti tra le 75 mila e le 120 mila prostitute sfruttate, vittime di sequestri, abusi, minacce e violenze. Il 65 per cento è in strada, mentre il 37 per cento di queste ragazze ha un’età compresa tra i 13 e i 17 anni. La maggior parte di queste donne viene dalla Nigeria (36 per cento), dalla Romania (22 per cento), e poi Albania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina, Cina e altri Paesi dell’Est.
La schiavitù agricola
Da questa forma di schiavismo derivano, sempre secondo le stime dell’Ilo, circa 9 miliardi di dollari annui. Su 1,3 miliardi di lavoratori agricoli nel mondo, quasi 3,5 milioni si trovano in condizioni di schiavitù.
Amnesty International è intervenuta a riguardo della produzione di olio di palma, dietro la quale si nasconde lo sfruttamento del lavoro minorile.
Lo stesso accade nel Michigan, il più grande produttore di mirtilli degli Stati Uniti, che sfrutta bambini immigrati dal Messico nella raccolta dei frutti.
I raccoglitori di pomodori in Florida sono costretti a lavorare in turni di dieci ore giornaliere per ricevere un compenso di circa 40 dollari alla settimana. Lavorano a ritmi velocissimi e serratissimi che li portano a raccogliere fino a 480 chili di pomodori ogni giorno.
Anche in Italia, dal 2010 è scoppiato il caso di Rosarno, titolato “Una stagione d’inferno”, dove i migranti sono impiegati nella raccolta degli agrumi, nella Piana di Gioia Tauro, e vivono in condizioni disumane di sfruttamento, costretti a vivere in baracche fatiscenti, prive di qualunque norma igenico-sanitaria. La clinica mobile di Medici per i Diritti Umani ha operato nella Piana di Gioia Tauro da metà novembre 2015 a marzo 2016, prestando assistenza sanitaria ai lavoratori stranieri stagionali. Dei 471 pazienti visitati l’86 per cento ha meno di 35 anni. Provengono principalmente da Mali, Senegal, Gambia, Costa d’Avorio e Burkina Faso. Il 42 per cento dei pazienti ha dichiarato di essere analfabeta: la maggior parte dei lavoratori è sprovvista di informazioni socio-legali, di tessere sanitarie e, quasi per il 90 per cento dei casi, di contratti di lavoro regolari.
Bambini soldato
Attualmente più di 300 mila minori sono impegnati nelle guerre. La gran parte ha un’età compresa fra i 15 e i 18 anni, ma sono presenti anche bambini/reclute di 10 anni. Alcuni di loro sono regolarmente reclutati negli eserciti dei loro paesi, mentre altri fanno parte delle armate irregolari di opposizione ai governi. Fra questi anche “volontari”, mossi dalla fame, dal bisogno di protezione e dal sostrato culturale fortemente impregnato di violenza e di desiderio di vendetta.
Il fenomeno dei bambini soldato è maggiormente radicato in Africa, dove sono presenti circa 120 mila soldati minori di 18 anni, e in Asia.