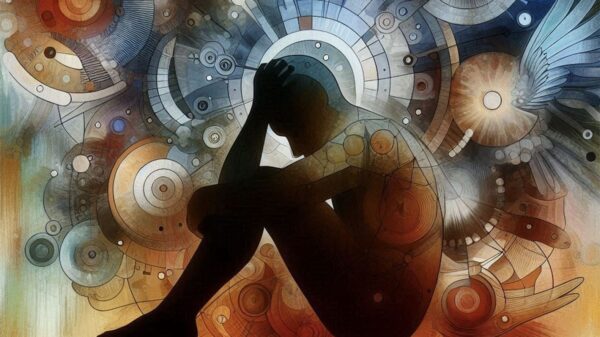Molestie sessuali: fra coazione e accondiscendenza
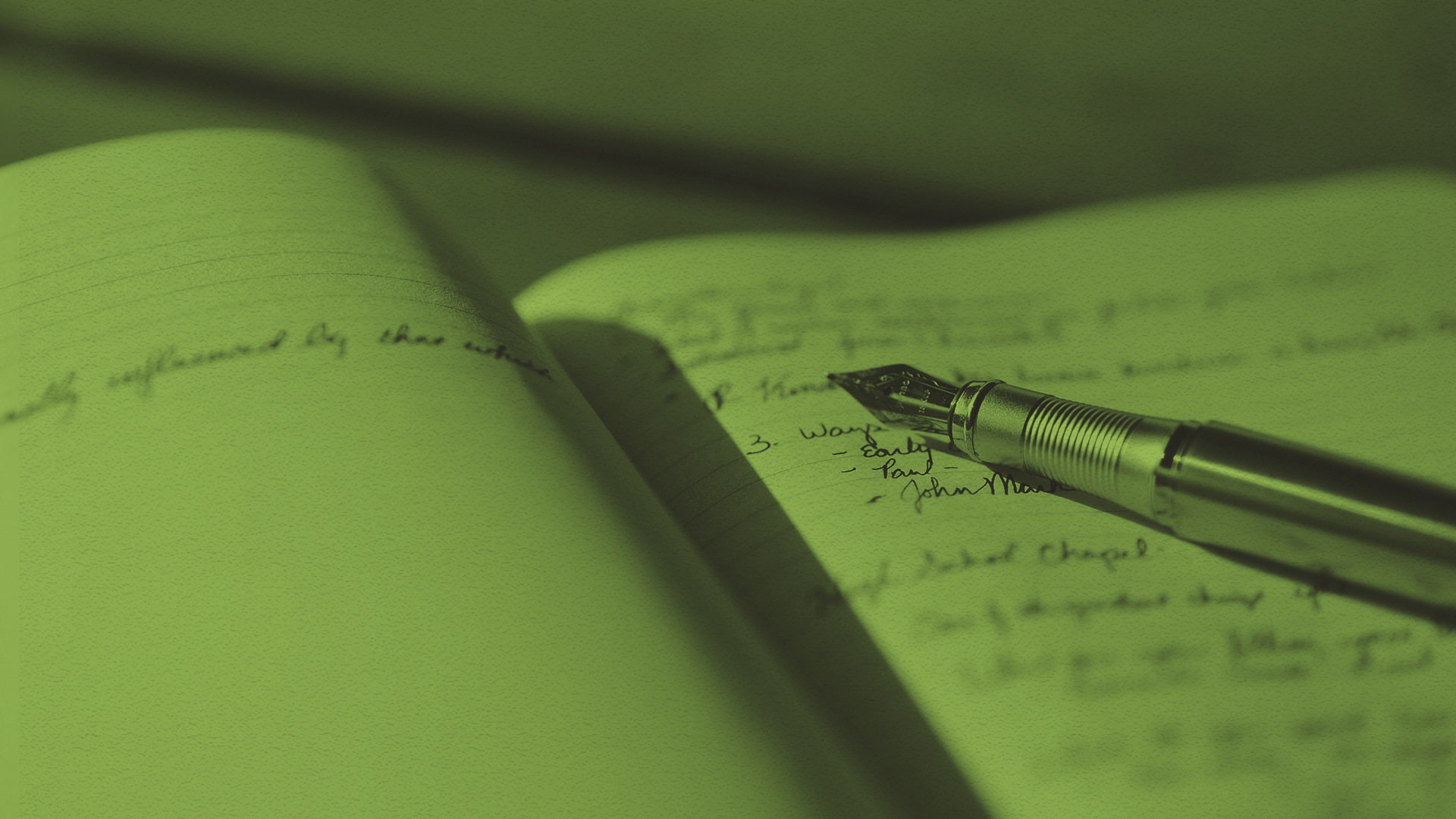
Le vicende dell’ultimo mese, riguardanti le molestie sessuali, dimostrano una strutturale incapacità di estraniarsi dalle influenze autoritarie di chi sta commettendo un abuso di potere.
Il problema degli abusi e delle molestie fisiche e sessuali è molto più dei numeri, dei dati e delle notizie allarmistiche e strillate delle ultime settimane. Vince sulle campagne di sensibilizzazione e di falso buonismo. Accomuna trasversalmente culture e tradizioni diverse, è la predisposizione apolide dell’umano. È un fenomeno culturale, è il prodotto della socialità, ovvero della modalità umana di essere e convivere. È l’espressione più estrema di una società misogina e maschilista, di una mentalità che confonde il potere con il possesso e il dominio, o peggio ancora la risultante di una volontà di potenza totalizzante che percorre un vicolo morto, senza uscita. Non è necessariamente il risultato di una provenienza sociale scomoda e abietta: gli scandali del cinema e della televisione susseguitesi nelle ultime settimane lo dimostrano emblematicamente. È violento qualunque tipo di prevaricazione, fisica o mentale, che umilia e mortifica. È violento l’annichilimento della donna, la sua riduzione a merce di scambio.
È profondamente discriminatoria e violenta quella matrice storico-culturale che fa della donna un contenitore di sopportazione e raccoglitore di scarti altrui.
La misoginia nasce con l’uomo e dall’uomo si manifesta in molteplici forme: dalla vessazione verbale allo sminuimento intellettivo e personale, dalla costrizione fisica all’obbligazione sessuale. L’umiliazione è la più viscerale e latente fra le forme di violenza, perché ha il potere di trasformarsi in auto-violenza, diventa una forma privata di autolesionismo, dal quale è difficile uscire. Soprattutto se nell’opinione comune e pubblica sopravvive quel sottile stillicidio che, nel profondo, riconosce delle colpe anche alla vittima.
A partire dai numeri
I dati sono importanti non tanto per capire l’estensione del fenomeno, quanto per comprenderne l’intensità e l’infiltrazione subdola e morbosa. A settembre infatti l’Istat ha dichiarato che solo il 7 per cento delle donne abusate denuncia il fatto. Questa percentuale così bassa si spiega perché la maggior parte delle molestie avviene in ambiente domestico o lavorativo. Quindi le donne si ritrovano nella condizione di dover denunciare il loro partner, padre, figlio o datore di lavoro. Nei casi di violenze o molestie la denuncia, purtroppo, non è una reazione così prevedibile e scontata. Per una donna denunciare un abuso significa un po’ denunciare anche se stessa: fra lei e il suo aguzzino è nato coattivamente ed involontariamente un legame intimo e viscerale, che mette a nudo per prima la vittima e il suo senso del pudore, inevitabilmente offeso. Stando semplicemente a questo 7 per cento, sono circa 11 gli abusi commessi in Italia ogni giorno. Più di 4mila ogni anno. Dal Viminale si apprende che nel primo semestre del 2017 sono avvenute 2.333 violenze fisiche; le persone denunciate 2.438, fra queste 1.534 italiani e 904 stranieri.
Fra mito e autorità
Dal caso del produttore americano Weinstein, risalente al mese scorso e trattato dal New Yorker e dal New York Times, è insorta un’ondata di confessioni liberatorie e denunce tardive, che ha lievemente smosso il torpore morale dei più. Da Asia Argento a Gwyneth Paltrow e Angelina Jolie, ma anche Lucia Evans, Mira Sorvino, Ambra Battilana Gutierrez e Rosanna Arquette. Le violenze raccontate risalgono a più di venti anni fa e riguardano giovani donne che stavano affacciandosi ad un nuovo mondo cariche di speranze, ambizioni e ingenuità. Hanno vissuto più o meno consapevolmente delle molestie sessuali per partecipare ad alcuni film.
Si passa poi a Sylvester Stallone, accusato di una violenza sessuale avvenuta nel 1986 ai danni di una ragazza all’epoca sedicenne, costretta ad avere un rapporto a tre insieme alla guardia del corpo di Stallone, Michael De Luca.
A Londra è invece Kevin Spacey ad essere denunciato per molestie sessuali da parte di 20 uomini, quasi tutti provenienti dallo staff dell’Old Vic Theatre di Londra, di cui è stato direttore dal 2004 al 2015, e per questo terrorizzati a sporgere denuncia o a chiedere semplicemente aiuto. A Londra è accusato di molestie anche Damien Green, Primo segretario di Stato del governo May.
In Italia è emerso il nome del famoso regista romano Fausto Brizzi, in seguito ad un’inchiesta avviata da Dino Giarrusso, giornalista de Le Iene. È al momento accusato da una decina di ragazze giovani e alle prime armi per averle adescate all’interno di uno studio/appartamento, nel quale dopo un falso provino le ha molestate fisicamente o sessualmente.
Dalle loro testimonianze emerge una duplice violenza: la molestia sessuale vera e propria da parte del regista e l’auto-violenza prodotta dall’incapacità a reagire. In queste storie a giocare un ruolo chiave è l’autorità del presunto colpevole, che intimorisce, sconvolge e confonde.
Per lo stesso motivo anche il giornalismo e l’opinione pubblica si posizionano su fronti opposti, disorientati dal do ut des più antico e promiscuo del mondo, che strizza l’occhio ad una sorta di accondiscendenza da parte delle vittime. La “gogna mediatica” di cui ha parlato la moglie di Brizzi, Claudia Zanella, rimarca innanzitutto la necessità di distinguere fra giustizia processuale e giustizia mediatica/popolare, così da poter salvaguardare la vita di chi è costretto a subire indirettamente le conseguenze degli errori altrui, nel caso specifico lei e la loro figlia di un anno e mezzo. Da una parte chi condanna nettamente la totalità dei fatti e il suo artefice, dall’altra chi contesta la modalità dell’inchiesta e la sua verosimiglianza alla realtà dei fatti, dall’altra ancora chi incrimina le colpe di tale mercimonio ad entrambe le parti in questione, come se chi abusa e chi è abusato costituissero due parti della stessa medaglia. La reticenza a condannare perentoriamente questi avvenimenti aumenta, però, la paura delle vittime ad esporsi e condannare. Quando la giornalista Selvaggia Lucarelli definisce questo polverone mediatico una ‘falsa rivoluzione culturale’ è proprio a causa della latente ostilità e palese timore di gran parte del mondo dello spettacolo a stigmatizzare pubblicamente le molestie. Il problema di fondo è che buona parte della società continua a confondere questa tipologia di abusi con la prostituzione e con lo scambio di favori e lavori, non dando la giusta importanza all’afflizione morale e lo spaesamento psicologico di cui rimane vittima la donna.