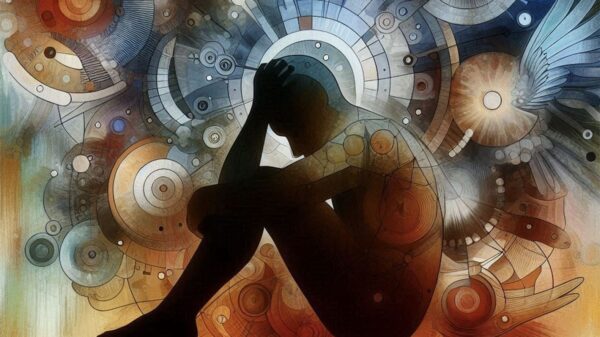La società italiana dal ‘900 ad oggi
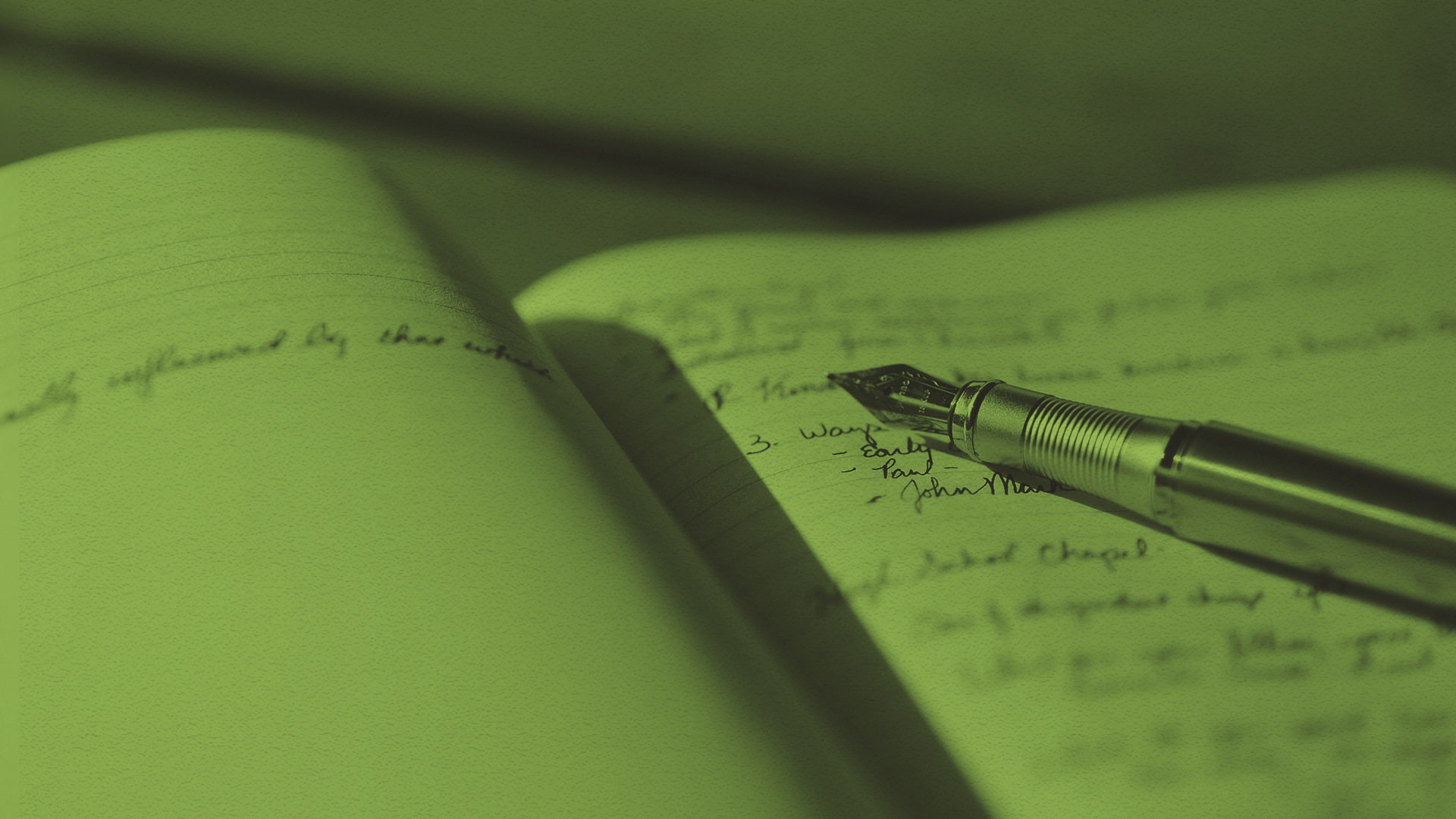
Dai primi del ‘900 all’avvento del fascismo

Nei primi anni del ‘900 la neonata Italia è un Paese ancora lontano dal potersi definire tale a tutti gli effetti. Le nette divisioni tra i ceti sociali, culminate in numerosi scontri e repressioni da nord a sud durante la fine dell’800, ci restituiscono oggi la fotografia di una nazione pressoché inesistente, composta da una società profondamente divisa al proprio interno e governata – oltre che dalla corona sabauda – da élites e grandi proprietari terrieri.
Nonostante la situazione precaria, l’emigrazione e il diffuso malcontento, dal 1901 al 1914 la politica italiana riuscì comunque a dare risposte più o meno tangibili al popolo, attraverso i governi guidati da Giovanni Giolitti. Lo sviluppo della rete stradale e ferroviaria, l’aumento del numero d’insegnanti, la diminuzione della mortalità, la fine delle repressioni autoritarie e una nuova legislazione sociale e sul lavoro consentirono al Paese – assieme al suffragio universale maschile – di creare le prime basi per costituire una vera a propria nazione, attaccando anche il profondo divario sociale presente da nord a sud.
Con la prima guerra mondiale, l’Italia subì una battuta d’arresto nel suo già lento processo evolutivo. La società civile pagò un pesante dazio in termini di vite umane e d’inflazione a fronte di una vittoria che in molti, da subito, definirono ‘mutilata’. Lo scarso peso politico dell’Italia al tavolo della pace ebbe contraccolpi notevoli anche in patria e fu proprio da questo senso d’insoddisfazione – diffuso soprattutto tra ex soldati – che Benito Mussolini poté dare forma al suo progetto e fondare, nel 1919, il primo fascio di combattimento. In pochi mesi le squadre di fascisti crebbero, così come le violenze e gli scontri interni alla nazione, che ebbero come conseguenza l’indebolimento delle rappresentanze sindacali e di tutte le forze contrarie all’autoritarismo.
Il ventennio
Nel 1921 il movimento guidato da Mussolini assunse il nome di Partito nazionale fascista. Il debole governo italiano – a cui il Re Vittorio Emanuele III girò praticamente le spalle – non poté far altro che dimettersi quando, il 28 ottobre 1922, 50mila camice nere marciarono su Roma consentendo a Mussolini – appoggiato dal Re – di prendere il potere in soli due giorni e riconfermarlo nelle elezioni del 1924, note anche per essersi svolte dopo il varo della ‘Legge Acerbo’.
Il fascismo, per risollevare le sorti di una lira molto inflazionata, aumentò la pressione fiscale e diede il via alla produzione autarchica (necessaria anche per ovviare alle sanzioni imposte dalla Società delle Nazioni), soppiantando i generi d’importazione con altri prodotti in territorio italiano. La società, che già pativa il peso di politiche repressive e di varie forme di privazione delle libertà, si trovò così costretta a bere carcadè e a coltivare grano nelle aiuole. La propaganda era incessante e volta a modificare le abitudini e le idee della società stessa la quale, nonostante tutto, in larga parte riponeva fiducia nel proprio Duce e nelle promesse di un domani migliore.

Quel domani, tuttavia, non arrivò mai sotto l’era fascista. Mussolini, forse ingolosito dai grandiosi progetti dell’alleato tedesco, spinse il proprio popolo in una guerra che fin da subito si rivelò essere un confronto impari. Il coraggio ammirevole dei soldati infatti era poca cosa contro le potenti e numerose armi dei nemici; gli aerei italiani – perlopiù di legno e tela – erano spesso facile preda della caccia avversaria mentre a terra – per citare un esempio eloquente – i carri armati della 132ª Divisione corazzata ‘Ariete’ – forse i migliori che l’Italia aveva a disposizione – finirono annientati durante la seconda battaglia di El-Alamein.
La stessa sorte fu riservata alla Regia Marina, che pur essendo considerata tra le flotte migliori al mondo, terminò il conflitto con sonore sconfitte e – si usa dire – ‘senza aver mai sparato un solo colpo’. Gli sforzi bellici costarono anni di privazioni agli italiani che, dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia, si trovarono addirittura a combattere una guerra civile contro i fedeli al Duce e alla neonata RSI. L’epilogo – piazzale Loreto – è noto a tutti. Il Paese era di nuovo tornato nel baratro, forse più povero di prima. Le città e le industrie erano rase al suolo, L’Italia – e con essa la società – rischiavano di non riemergere più.
Gli anni della rinascita
 Dopo la cessazione delle ostilità, la proclamazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione, per la politica arrivò il momento di scegliere se dirigere il Paese verso l’influenza statunitense o se entrare in orbita sovietica. La tendenza centrista dei governi di quel tempo fece sì che l’Italia si avvicinasse agli americani, i quali intervennero attraverso i cospicui finanziamenti previsti dal Piano Marshall. Le nuove entrate economiche diedero i frutti sperati e sia l’industria che il Paese tutto cominciarono a risollevarsi da ogni punto di vista.
Dopo la cessazione delle ostilità, la proclamazione della Repubblica e l’entrata in vigore della Costituzione, per la politica arrivò il momento di scegliere se dirigere il Paese verso l’influenza statunitense o se entrare in orbita sovietica. La tendenza centrista dei governi di quel tempo fece sì che l’Italia si avvicinasse agli americani, i quali intervennero attraverso i cospicui finanziamenti previsti dal Piano Marshall. Le nuove entrate economiche diedero i frutti sperati e sia l’industria che il Paese tutto cominciarono a risollevarsi da ogni punto di vista.

Cominciò così quello che fu definito ‘miracolo economico’; l’Italia cresceva a vista d’occhio e con essa anche la società, che mai aveva conosciuto un simile livello medio di benessere, ben simboleggiato dalla Vespa Piaggio e dalla Fiat 500. Si costruirono le prime autostrade moderne – favorendo vacanze e turismo, altro simbolo del boom – mentre Mike Bongiorno intratteneva gli italiani con i primi quiz televisivi. Tuttavia nel Paese – e nella società – permanevano profonde spaccature, il clientelismo era una costante e i crescenti malumori della classe operaia – culminati nell’ ‘autunno caldo’ – alimentarono un clima di tensione che proseguì, acuendosi, negli anni successivi.
Gli anni ‘70, Br e NAR

Gli scioperi e le ripetute manifestazioni di piazza da parte di operai studenti ebbero i loro effetti; oltre al riconoscimento delle Regioni quali enti dotati di autonomie, nel 1970 venne infatti approvato lo Statuto dei lavoratori e fu approvata la legge sul divorzio: provvedimenti che riguardavano larghi strati della società e che oggi ritroviamo come eredità nella nostra quotidianità.
Assieme all’acquisizione di nuovi diritti, la società italiana degli anni ’70 dovette fare i conti con l’estremismo politico, idealmente sintetizzato nella polarità tra Brigate Rosse e Nuclei Armati Rivoluzionari. Il periodo viene anche tristemente ricordato come ‘anni di piombo’, in cui la continua tensione sociale, i sequestri – su tutti quello di Aldo Moro – e gli attentati, gettavano pesanti ombre sul futuro degli italiani e disgregavano il tessuto sociale emerso durante il boom. L’anno che fece registrare più vittime fu il 1980, con 125 morti; 85 dei quali nella strage alla stazione centrale di Bologna.
Anni ‘80

Nel corso degli anni ’80 il numero di attentati, così come la tensione sociale, diminuì. L’approvazione della Legge 304 – prevedeva sconti di pena per chi avesse contribuito alla lotta contro l’eversione – diede i frutti sperati e per le organizzazioni terroristiche fu un duro colpo da incassare, dato l’alto numero di militanti che iniziarono a collaborare con i giudici. Con il terrorismo interno praticamente alle spalle (eccezion fatta per le morti dovute alla sempiterna presenza della malavita organizzata), la società italiana conosce una nuova fase di relativo benessere.
Le aziende mettono in commercio i primi computer, nascono i compact disc e aumenta notevolmente la competizione tra i media televisivi. La neonata Canale5 – già Tele Milano – fu la madre delle TV commerciali e tracciò la via per un nuovo modo di fare intrattenimento, che ancora oggi attrae larghe fette di pubblico e che costrinse la Rai a rivedere profondamente la propria offerta televisiva. La crescente competitività sui media si rifletteva anche nel mondo del lavoro, l’ ‘apparire’ e l’ostentazione divennero predominanti in ogni contesto, dando così largo spazio al consumismo.
Anni ‘90

Se negli anni ’80 si è assistito all’avvio di un processo di modernizzazione, tra il 1990 e il 2000 tale processo è cresciuto a dismisura; ogni famiglia che non sia al di sotto della soglia di povertà ha almeno un televisore, numerosi elettrodomestici, un computer, un telefono cellulare. Il benessere è palpabile (questo purtroppo solo col senno di poi), gli italiani spendono in vacanze, teatri, cinema, divertimenti. L’informazione aumenta, s’ingrossa e corre: adesso le notizie arrivano direttamente dal campo di battaglia e in men che non si dica sono soppiantate da altri fatti in altre parti del globo. Il mondo diventa più piccolo con la diffusione della Rete ma se da un lato la società ora può dirsi più coesa e cosmopolita, dall’altro si è innescato un pericoloso processo d’isolamento dell’individuo, navigante sempre più solitario nel mare magnum dell’informazione.
Dal 2000 ai giorni nostri
 I primi anni del nuovo millennio si caratterizzarono per l’entrata in scena dell’Euro, oggetto allora sconosciuto e che – parole di un certo Romano Prodi – «farà lavorare un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più». Ottimista. Fin troppo. Un po’ come la società del tempo, catapultata nel nuovo millennio alla velocità della luce senza alcuna protezione per eventuali contraccolpi improvvisi. Ma allora non ci si poneva il problema; c’erano i matinée a Ibiza, l’aperitivo, le prime edizioni del ‘Grande Fratello’ e la sensazione di un benessere diffuso che offuscavano in qualche modo il senso comune presente nella società, che forse superò fin troppo agilmente anche i tragici fatti dell’11 settembre 2001.
I primi anni del nuovo millennio si caratterizzarono per l’entrata in scena dell’Euro, oggetto allora sconosciuto e che – parole di un certo Romano Prodi – «farà lavorare un giorno di meno guadagnando come se lavorassimo un giorno di più». Ottimista. Fin troppo. Un po’ come la società del tempo, catapultata nel nuovo millennio alla velocità della luce senza alcuna protezione per eventuali contraccolpi improvvisi. Ma allora non ci si poneva il problema; c’erano i matinée a Ibiza, l’aperitivo, le prime edizioni del ‘Grande Fratello’ e la sensazione di un benessere diffuso che offuscavano in qualche modo il senso comune presente nella società, che forse superò fin troppo agilmente anche i tragici fatti dell’11 settembre 2001.
Sul finire degli anni zero del nuovo millennio, l’incantesimo si ruppe; il denaro virtuale scambiato giornalmente nelle borse di tutto il mondo, si trasformò improvvisamente in crack finanziari e pesanti debiti da sanare in concreto. In Italia la crisi cominciò a farsi sentire sul serio intorno al 2011, con l’ormai famigerato spread a oltre 500 punti e un Berlusconi dimissionario che – nonostante il Duomo ricevuto in faccia nel 2009 – continuava a sostenere come «in Italia non ci sia una forte crisi. La vita in Italia è la vita di un Paese benestante, i consumi non sono diminuiti, per gli aerei si riesce a fatica a prenotare un posto, i ristoranti sono pieni».

Con la caduta di Berlusconi e l’Italia di fatto commissariata dall’Ue, attraverso la formazione di un governo tecnico a guida Mario Monti, d’improvviso la società si trovò di fronte a tutta una serie di falle e guai finanziari che portarono al varo di manovre ‘lacrime e sangue’ per riallineare il Paese agli altri Stati membri. In breve tempo gli italiani tornarono con i piedi per terra.
La crisi, presente ancora oggi, ha modificato nuovamente la società stessa, che rivive oggi gli spettri del passato, acuiti dagli attacchi terroristici e da una tendenza alla chiusura che sfilaccia, ancora una volta, il tessuto sociale ricostruito con non poca fatica. La società, iperavanzata, ipertecnologica e iperveloce si ritrova oggi a dover ricostruire daccapo la propria identità, con una classe media praticamente estinta e il pericolo costante dell’esplosione di violenza nelle periferie nei confronti dei tanti immigrati che continuano a sbarcare senza sosta e a cui il governo non è in grado di far fronte.