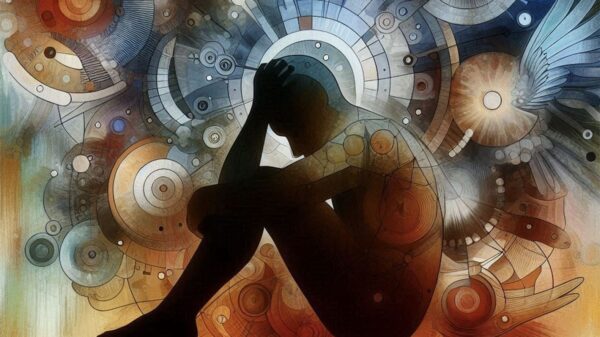Vicende costituzionali dello Stato italiano
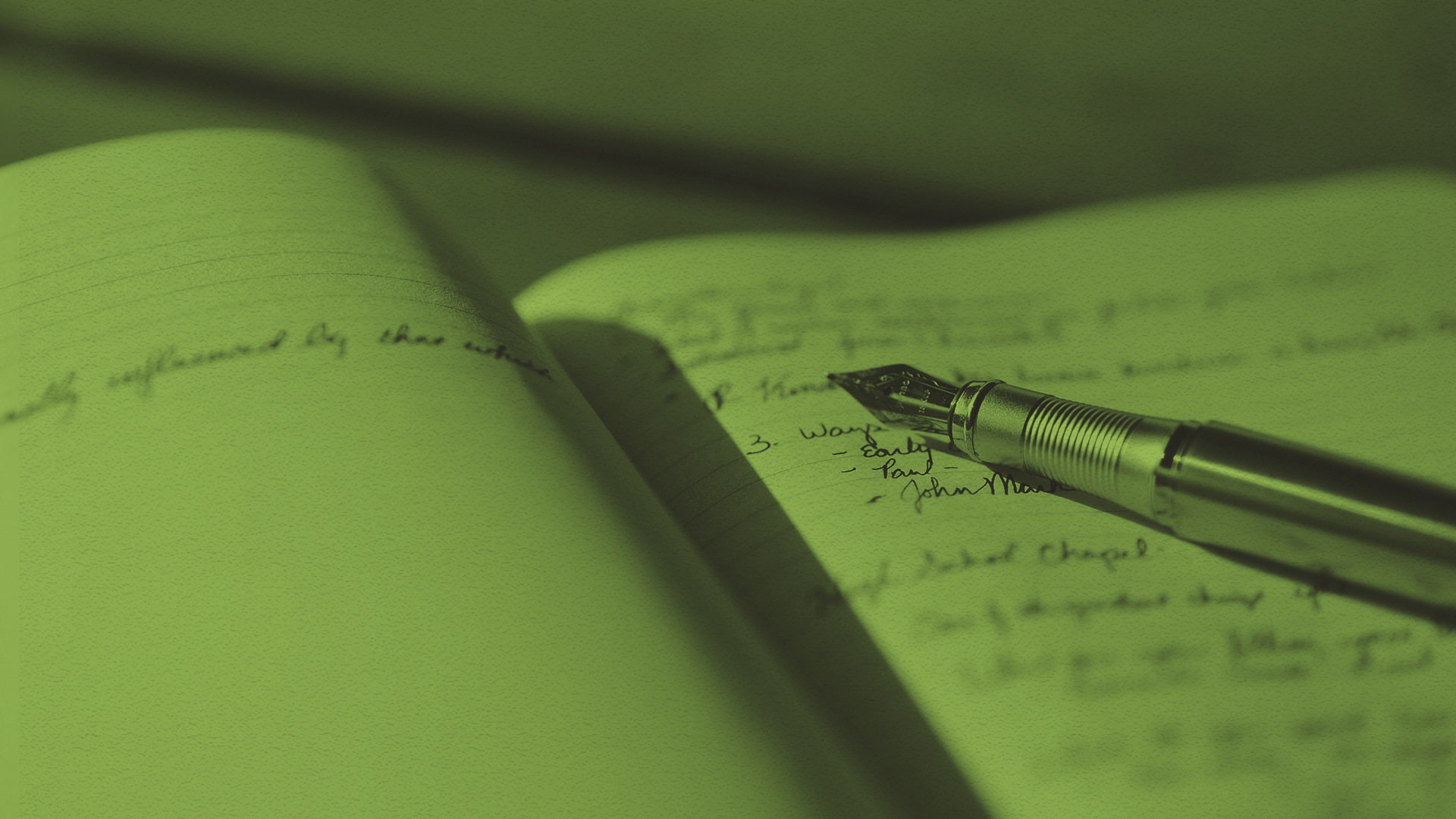
Lungo e tortuoso è il cammino che uno Stato intraprende per il riconoscimento di diritti che, proprio perché nati con l’uomo, dovrebbero essere catalogati come naturali e non essere frutto di (sudate) concessioni. La storia della nostra Costituzione, in primis, ci parla di un secolo di lotte per l’affermazione dei diritti fondamentali della persona, di impegno per una politica a favore delle classi più deboli e di identificazione del più importante compito dello Stato, quello di operare per la giustizia sociale, intervenendo nella società e riconoscendo l’importanza delle organizzazioni in cui i singoli sviluppano la propria personalità. È così che, mentre la rivoluzione ha il compito di rovesciare un determinato ordine politico e sociale, ogni costituzione pone nuove basi da cui partire per fondare un nuovo ordinamento, rappresentando essa il mito fondatìvo di ogni nuovo ordine. Questo è quanto successo con la Costituzione repubblicana che sotterrò lo Statuto Albertino, il quale affondava le sue radici in una democrazia liberale, per costituire una democrazia sociale volta alla tutela della dignità e della libertà dell’individuo. Ma occorre fare un piccolo passo indietro.
STATUTO ALBERTINO
Lo Statuto Albertino nacque come risposta ad un anno di grandi rivoluzioni europee diffuse su tutto il territorio del vecchio continente. Concesso da Carlo Alberto nel 1848, lo Statuto rappresentò il tipico esempio di costituzione “flessibile” (le costituzioni flessibili possono essere modificate in ogni momento dal Parlamento con il procedimento di approvazione usato per le leggi ordinarie); con la concessione dello Statuto, motivo per cui questa Costituzione venne definita “ottriata”, cioè concessa, il Re sabaudo rinunciava, con “decisione perpetua e irrevocabile”, ad essere un sovrano assoluto. Non c’era norma specifica che prevedesse modifiche, né erano menzionati procedimenti che descrivessero la sua revisione; tuttavia, era chiaro a tutti che lo Statuto potesse essere modificato in quanto la modificabilità costituiva la forza delle costituzioni “flessibili”, al contrario di quelle “rigide”.
REFERENDUM ISTITUZIONALE
Le premesse per il cambiamento furono gettate nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in seguito alla caduta del Fascismo e con la lotta per la liberazione del centro-nord dove Mussolini aveva instaurato la Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò) con l’appoggio dell’esercito tedesco. Con la liberazione (25 aprile 1945) le forze politiche antifasciste rappresentate nel Comitato di Liberazione Nazionale, che aveva organizzato la Resistenza, furono concordi nell’affidare al popolo le scelte sul futuro. Il 2 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a decidere se mantenere la monarchia o dar vita ad una repubblica e ad eleggere i membri dell’Assemblea Costituente, assemblea che avrebbe dovuto redigere una nuova costituzione. La data è da ricordare anche per un’altra ragione, per la prima volta in Italia fu concesso di votare anche alle donne e quindi venne attuato pienamente il principio del suffragio universale.
La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, dopo l’approvazione dell’Assemblea Costituente e la promulgazione da parte di Enrico De Nicola, rappresentò per l’Italia un radicale cambiamento politico e istituzionale rispetto al passato. Secondo quanto affermano Bin e Pitruzzella, docenti di diritto e autori di un prezioso manuale di diritto pubblico, il fatto che il testo finale della Costituzione sia stato approvato da quasi il 90% di un’assemblea politicamente divisa, spiega alcune caratteristiche della nostra Costituzione. Una Costituzione “lunga”, perché un consenso così vasto si è potuto realizzare soltanto sommando gli interessi e i valori delle diverse componenti; una Costituzione “aperta”, aspetto molto spesso criticato, nel senso che non pretende di individuare il punto di equilibrio tra i diversi interessi, ma si limita ad elencarli, lasciando alla legislazione successiva di individuare il punto di bilanciamento. C’è da dire che tutte le costituzioni, nascendo dalla crisi del regime precedente, guardano al loro passato prossimo e cercano di evitare che si riproducano cause che hanno provocato quella crisi. E tutte le costituzioni hanno l’obiettivo di introdurre dei limiti e delle regole all’esercizio del potere. Purtroppo, però, sotto questo aspetto, qualche errore il costituente l’ha fatto. Il più grave, molto probabilmente, è stato il modo in cui ha progettato i “contropoteri”, ossia quei tipici meccanismi costituzionali che servono ad evitare che il potere si concentri nelle mani di poche persone e che operano nel rafforzare controlli politici e giuridici. Il funzionamento di questi organi è stato per troppo tempo rinviato e il risultato è stato una lunga fase di inattuazione della Costituzione. Ad esempio, la Corte Costituzionale ha potuto iniziare a funzionare solo nel 1956, otto anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione che doveva custodire, e solo nel 1958 è stato varato l’ordinamento del Consiglio superiore della magistratura. Alcune leggi di attuazione della Costituzione non sono state mai emanate: come, per esempio, la legge che prevede la registrazione dei sindacati (art. 39 comma 2).