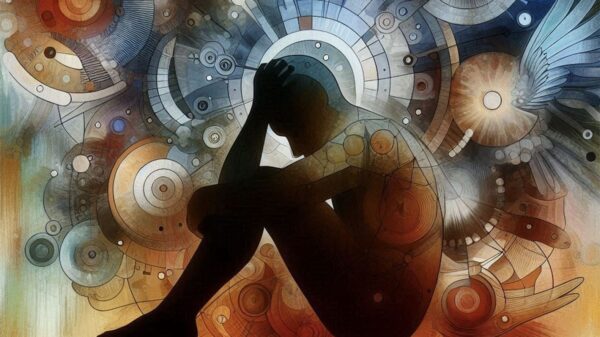Lo Stato tutto d’un pezzo che tratta di nascosto coi rapitori
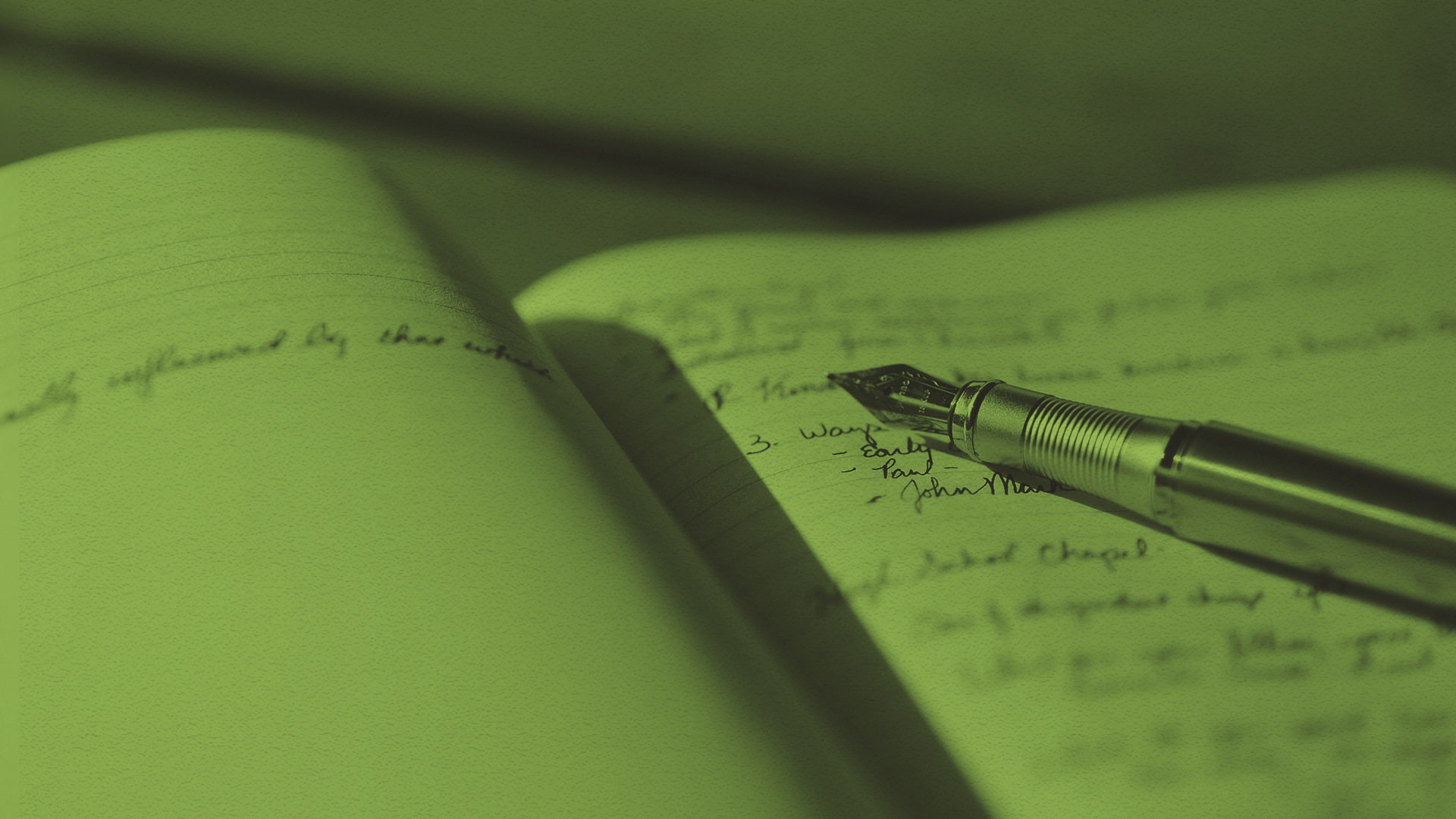
Ci risiamo. Anche stavolta lo Stato italiano si è fatto beffa dei propri cittadini negando – finché ha potuto – di aver pagato un cospicuo riscatto per liberare le due cooperanti (Greta Ravelli e Vanessa Marzullo) rapite nel luglio 2014 in Siria. Già dopo il loro rientro in Italia cominciarono a sorgere seri dubbi sulle modalità di rilascio ma il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni smentì categoricamente una liberazione dietro compenso bollando le ‘malelingue’ (poi rivelatesi veritiere) come “prive di reale fondamento”. Il ministro aggiunse inoltre una dichiarazione perentoria: “siamo contrari al pagamento di riscatti nei confronti degli italiani presi in ostaggio”.
Ad oggi, con la notizia del pagamento di 11 milioni di euro per liberare le due cooperanti, emerge la poca coerenza dello Stato e la scarsa trasparenza nei confronti dei contribuenti, affogati a suo tempo in narcotizzanti storie strappalacrime che distolgono l’attenzione dalle reali criticità presenti in questa e in altre vicende simili, tra le quali ricordiamo quelle di Simona Pari e Simona Torretta (2004), Giuliana Sgrena (2005), Clementina Cantoni (2005), Rossella Urru (2011) e Mariasandra Mariani (2011).
Chiarito il fatto che lo Stato italiano sia tutto d’un pezzo soltanto di facciata, procediamo con l’analizzare la posizione delle cooperanti: persone che scelgono di recarsi in aree calde per aiutare il prossimo senza considerare l’ipotesi di aiutare persone in difficoltà nel proprio Paese d’origine. E’ vero che in Italia non cadono bombe e non ci sono guerre ma è altrettanto vero che se si sceglie di operare in zone pericolose si deve accettare anche il rischio di non tornare più a casa, specie se il Paese d’origine dichiara – petto in fuori – di non trattare con il nemico. La domanda è: si va a fare volontariato in zone a rischio per mero spirito di solidarietà, oppure si pensa – una volta rientrati – di diventare ‘eroi’ e trovare in tal modo un posto di lavoro fisso corredato magari da apparizioni televisive e simili? le buone azioni, in effetti, si possono compiere pure in Italia, ad esempio nelle Caritas o alle mense dei poveri: tutti luoghi in cui il personale spesso è carente e le file per un pasto caldo crescono di giorno in giorno. Perché allora non pensare prima di tutto a collaborare in queste realtà se davvero lo spirito è quello di aiutare il prossimo in modo disinteressato?
A queste domande non è semplice rispondere, anche perché le reali intenzioni di ognuno sono difficili da decifrare e soprattutto sono libere e personali, ma sulla scorta di quanto accaduto qualche dubbio è lecito porselo.
Detto questo rimane però la questione fondante: la coerenza dello Stato italiano. Se l’Istituzione si pone fin da subito come Ente intransigente, che non tratta col nemico, deve mantenere la sua linea fino in fondo, costi quel che costi. Se, invece, lo Stato mente ai cittadini e paga profumatamente i rapitori s’innesca un circolo che risulta molto più deleterio della perdita (che è un’ipotesi reale che va sempre tenuta presente in certe situazioni) di qualche soggetto caduto in mano nemica. Pagare significa inoltre creare un precedente e quindi un’aspettativa nei rapitori, che saranno spinti a mettere a segno azioni di sequestro, certi che da esse ricaveranno facilmente ingenti somme che possono venir reinvestite per acquisire armi e addestrare nuove leve.