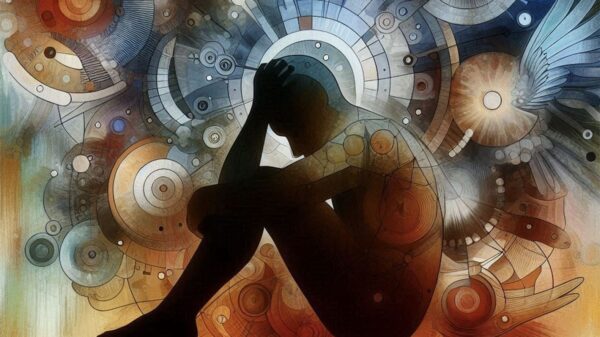11 settembre 1973, il golpe cileno e la morte di Allende
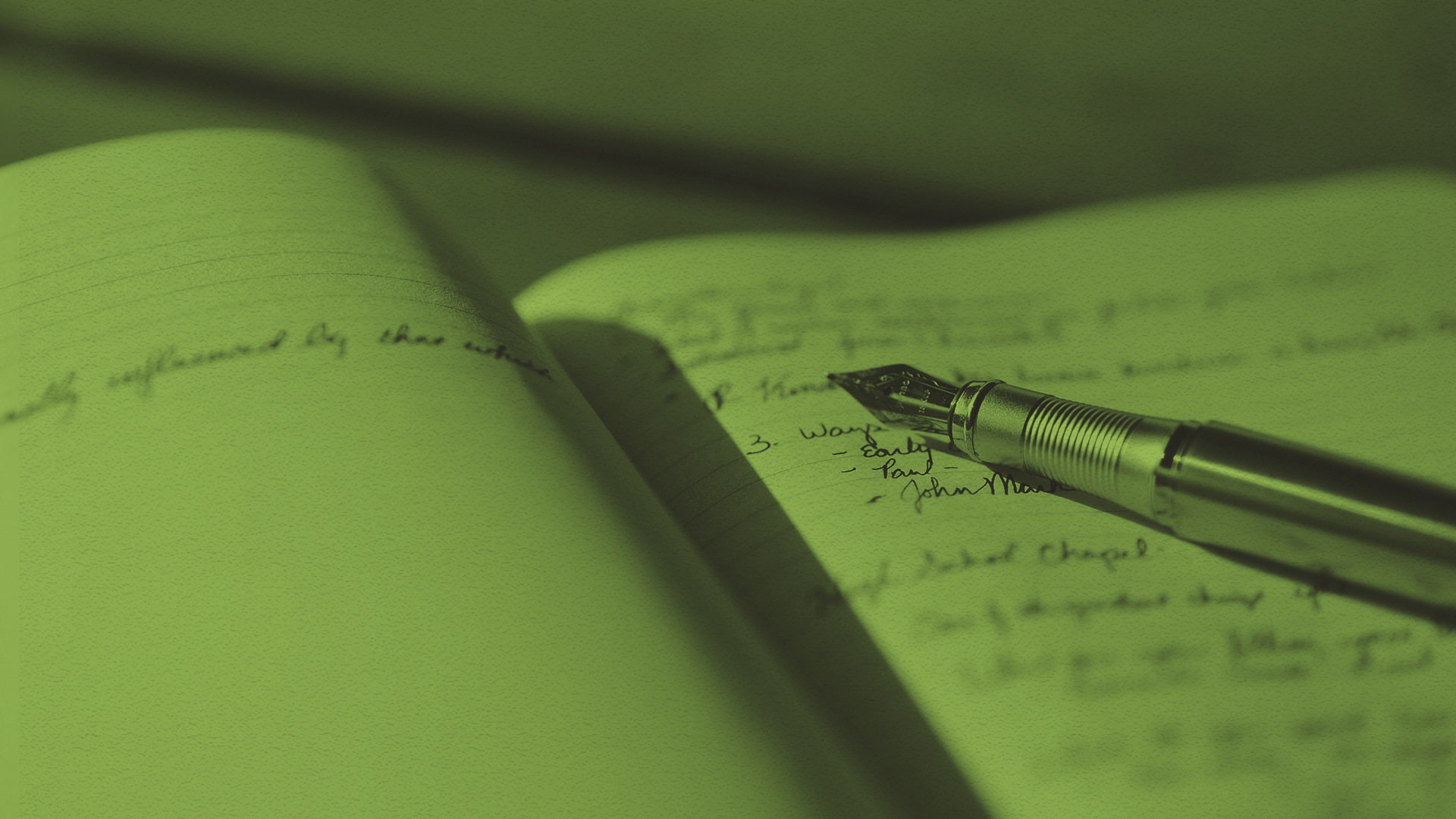
L’11 settembre 1973 il comandante delle forze armate cilene Auguste Pinochet diede il via al golpe che destituì il governo di Unidad Popular soppiantandolo con una dittatura militare. Durante le fasi di assedio al Palazzo della Moneda – in cui alle forze di terra si aggiunsero anche attacchi aerei (mezzi di fabbricazione britannica) – perse la vita Salvador Allende, capo del governo socialista salito al potere nonostante le numerose pressioni interne – ed esterne – al Paese.
Secondo le ipotesi più recenti, il presidente cileno morì suicida sparandosi con un Ak-47 ricevuto in dono da Castro ma ciò che più importa sono le ragioni che hanno provocato quella morte. Fermo sostenitore di una ‘via cilena al socialismo’, Allende incentrò il suo programma politico sulla nazionalizzazione delle imprese straniere e dell’industria del rame, andando ad intaccare gli interessi americani in territorio cileno. Questo fu sufficiente per avviare la macchina dei servizi segreti, che operarono nell’ombra – favorendo anche Pinochet – pur di impedire a Unidad Popular di vincere le elezioni e mettere in atto politiche di nazionalizzazione ed emancipazione dalla dominazione economica estera.
Le notizie del golpe e della morte di Allende ebbero risonanza mondiale; in piena guerra fredda un governo socialista veniva sostituito da una dittatura militare sostenuta dagli americani, una mossa che – considerato il reale rischio di guerra atomica – provocò reazioni nel panorama politico internazionale e deflagrò tra le masse come una sconfitta dal pesante valore emotivo.
In Italia il Pci si mosse immediatamente: unitario fu l’invito alla mobilitazione, con manifestazioni e cortei in tutto il Paese. Berlinguer, segretario del Partito, produsse – assieme a Marchais, vertice del Pcf – un appello in cui venivano invitate le “autorità politiche e morali di ogni parte del mondo” a intervenire per fermare Pinochet. Berlinguer analizzò a fondo la questione cilena attraverso alcuni scritti su ‘Rinascita’, tre interventi dai quali trae origine la proposta di ‘compromesso storico’, volta anche ad arrestare in modo organico sia l’imperialismo che la reazione. Nel primo intervento, pubblicato il 28 settembre 1973, Berlinguer comincia richiamando subito l’attenzione sugli “avvenimenti cileni” che “sono stati e sono vissuti come un dramma da milioni di uomini sparsi in tutti i continenti. (…) Si tratta di un fatto di portata mondiale, che (…) suscita sentimenti di esecrazione verso i responsabili del golpe reazionario e dei massacri di massa. (…) Il colpo gravissimo inferto alla democrazia cilena (…) si ripercuote sul movimento di liberazione e di emancipazione dei popoli latino-americani e sull’intero movimento operaio e democratico mondiale”. Berlinguer non ebbe dubbi sulle responsabilità statunitensi e osservò: “Gli eventi cileni estendono la consapevolezza, contro ogni illusione, che i caratteri dell’imperialismo, e di quello nord-americano (…) restano la sopraffazione e la jugulazione economica e politica (…) la tendenza a opprimere i popoli e a privarli della loro indipendenza, libertà e unità ogni qualvolta le circostanze concrete e i rapporti di forza lo consentano. (…) I gruppi monopolistici nordamericani presenti nell’economia cilena (…) hanno intrapreso una sistematica azione su tutti i terreni per provocare il fallimento del governo Allende e rovesciarlo”, questi avvenimenti – proseguì il segretario, “devono suscitare (…) un risveglio delle coscienze democratiche e un’azione per l’entrata in campo di nuove forze disposte a lottare concretamente contro l’imperialismo e contro la reazione”. L’appello non ebbe gli esiti sperati e poco a poco l’egemonia statunitense pervase il globo e contribuì in modo significativo a renderlo così come appare oggi.