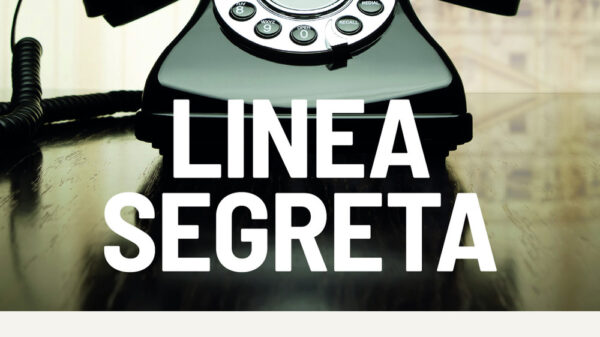Come Noam Chomsky ci ha avvisato del legame perverso tra media e potere
La raccolta di saggi edita da Bepress con titolo Media e potere analizza il rapporto tra transmedialità e forme di potere per definire a tutto tondo le nuove fabbriche che costruiscono il consenso delle folle.

C’è una tesi di fondo dietro molta della saggistica di Noam Chomsky, irraggiungibile linguista, filosofo, sociologo che negli anni ha saputo come pochi raccontare la società nostra contemporanea. Il sogno americano è morto. E in uno dei suoi ultimi libri, titolato Le dieci leggi del potere (Ponte alle Grazie), si era addirittura spinto a parlare di vero e proprio requiem dell’American Dream: l’America è uno dei paesi del mondo in cui si registra la più bassa mobilità sociale e il capitalismo, con le sue favole di riscatto, non è più disposto a premiare davvero i self-made-men.
Per dimostrare ciò, Chomsky riprendeva la definizione di plutonomia così come era stata coniata da Citigroup, uno dei più grossi istituti bancari americani il quale, già nell’ottobre del 2005, registrava una divisione della società in blocchi sempre più distanti tra loro. Da un lato, appunto, le plutonomie, la cui crescita economica è alimentata e perlopiù consumata da pochi ricchi; dall’altra parte, in un rapporto di proporzione tutt’altro che equo, tutti gli altri.
La condizione dei cittadini, ancor prima della crisi dei mutui che travolgerà l’Occidente a partire dal 2008, ancor prima della pandemia da Covid-19 del 2020 era sostanzialmente questa. Eppure, nonostante gli evidenti limiti strutturali, il post-fordismo non è stato ancora messo in discussione, ed anzi i nuovi media, con la loro capacità di connettersi in maniera interstiziale nella vita delle persone, sembrano voler raccontare un sogno molto lontano dalla realtà.
A proposito di ciò, vale la pena recuperare la raccolta di saggi edita da Bepress con titolo Media e potere, una ottantina di pagine in cui il rapporto tra transmedialità e forme di potere viene affrontato da Chomsky per definire a tutto tondo le nuove fabbriche che costruiscono il consenso delle folle.
Così come la progressiva e inarrestabile messa in discussione del welfare state non è un fatto contemporaneo — le origini, è lo stesso Chomsky a ribadirlo, sono da rintracciare nel tatcherismo e nelle politiche economiche di Ronald Regan — anche nel sistema d’informazione coevo si possono recuperare dei fattori originari di almeno un secolo fa.
In particolar modo, Chomsky fa riferimento alla democrazia degli spettatori, una vera e propria «rivoluzione nell’arte della democrazia» teorizzata dal decano dei giornalisti statunitensi Walter Lippman durante la Prima Guerra Mondiale.
Per Lippman, gli interessi della società sfuggono completamente all’opinione pubblica e quindi è necessario costruire un sistema in cui una «classe specializzata di uomini responsabili» sappia amministrare il bene comune tenendo fuori dalle decisioni che contano il resto dei cittadini, lasciandoli appunto a guardare.
Alla base di ogni democrazia sorta nel secolo della società di massa esistono regole solide per il controllo sociale. Chomsky ne ha individuate 10 e rileggendole si corre a più riprese la tentazione di volerle attuare alla nostra contemporaneità. Ma tra tutti i punti squadernati da Chomsky, quello su cui vale la pena riflettere è il numero 6: «Usare l’aspetto emozionale molto più che la riflessione».
Una delle regole principali dello storytelling legato alla comunicazione di marca è quella di vendere al consumatore un’emozione.
Allora, nella società dei consumi, cittadino e consumatore tendono ad avere confini sovrapponibili, quindi la reazione del cittadino ad un fatto sarà la stessa reazione che avrebbe avuto come consumatore. Un esempio plastico di questo cortocircuito è dato dai talk show televisivi che raccontano l’attualità in Italia. Ogni proposta di lettura di realtà presentate come complesse viene destrutturata, semplificata e contrapposta a tesi che fanno leva su emozioni di pancia, facilmente introiettabili.
Il caso più recente è chiaramente quello relativo alla Guerra in Ucraina, le cui posizioni nel dibattito pubblico vengono spesso appiattite al limite del banalismo. Allora, una analisi delle dinamiche geo-politiche che hanno portato al conflitto può essere facilmente scardinata ribadendo che «milioni di persone stanno perdendo la vita», ma ciò non favorirà certo la generazione di nuovi interrogativi da parte dello spettatore/consumatore.
Anche questo conflitto è la sirena che segnala un sistema ormai sul viale del tramonto. Un sistema in cui rischiamo di fare la fine della rana, nel paradosso presentato da Chomsky in Media e potere: bolliti da chi è pronto a cuocerci a fuoco lento, accecati da sogni ormai impossibili da sostenere.