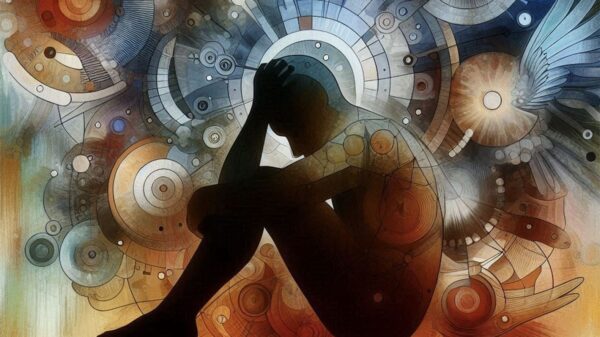Unione europea. Dalla solidarietà delle origini all’economia di oggi

L’idea di una federazione di Stati, capace di imporsi all’interno di scenari politici mondiali, ha attraversato le epoche, ha cambiato i suoi tratti e le sue fisionomie, ma non l’intenzione: essere solidali per essere più forti.
Si parlava di Europa già nella mitologia classica, gli albori dell’identità europea compaiono nella Grecia antica: Europa era una ninfa, rapita da Giove e trasportata fino alla Terra dalla quale prese il nome. Ma, uscendo dalla mitologia, l’intuizione greca fu quella di comprendere l’indispensabilità di una coscienza collettiva che prevaricasse l’identità nazionalista dei singoli popoli. Si faceva necessaria un’unità di popoli legati per cultura, costumi e istituzioni.
Prima di arrivare al 1951, anno in cui Francia, Italia, Germania federale, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi davano vita al primo Trattato europeo con il quale nasceva la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio), molteplici sono stati i tentativi verso la costruzione di un’Europa unita e solidale.

A partire dalla fondazione della Giovine Europa a Berna nel 1834, tra i cui principi ispiratori la costituzione degli Stati Uniti d’Europa, l’idea di Giuseppe Mazzini era quella di creare un’organizzazione democratica a carattere sopranazionale. Fino al primo Congresso Paneuropeo di Vienna del 4 ottobre 1926, al quale parteciparono 2mila membri provenienti da 24 nazioni. In questa occasione non veniva soltanto scelto l’Inno alla gioia di Beethoven come inno ufficiale dell’Unione europea, ma si stabiliva l’impegno dell’Unione «al patriottismo europeo, a coronamento dell’identità nazionale di tutti gli europei. Nel momento dell’interdipendenza e delle sfide globali, solo una forte Europa unita politicamente è in grado di garantire il futuro dei suoi popoli ed entità etniche».
Quando l’Unione europea non poteva più essere rimandata
Sono le due guerre mondiali a rendere vivo il desiderio dell’Europa unita. Il primo dopoguerra prepara il terreno per accogliere la strada che, nel secondo dopoguerra, sarebbe stato improcrastinabile percorrere: l’unità europea.
Perché? L’Europa usciva distrutta dal secondo conflitto mondiale, nessuna differenza tra vincitori e vinti e soprattutto le grandi potenze, Stati Uniti, Giappone e Cina, avevano dimostrato ciò di cui erano già capaci.
I campi di concentramento e di sterminio, la bomba atomica erano il segno della portata autodistruttiva del genere umano. Gli ultimi anni ’40 e tutti gli anni ’50 rimasero offuscati dalla polvere delle rovine, dalla nebbia delle macerie e ad essere brandelli non erano soltanto Paesi e città. La caduta della casa degli Usher di Edgar Allan Poe sembrava la prefigurazione della condizione umana di coloro che avrebbero abitato il mondo circa un secolo più tardi.
I più grandi pensatori del tempo abbandonarono la speranza nei confronti del genere umano, videro nelle barbarie della guerra il volto più infimo e vero dell’uomo. Theodor Adorno sostenne che «dopo Auschwitz non sarebbe più stato possibile fare poesia», la filosofia dell’assurdo di Camus acquisì il valore pieno che meritava, surrealismo e cubismo divennero gli strumenti per scomporre la tragedia del mondo e ridestarne lo spirito.

Un’idea piuttosto romantica della storiografia della Resistenza racconta la rinascita del sentimento di unità europea all’interno dei campi di concentramento: uomini e donne di nazionalità diverse riscoprivano ideali e aspirazioni comuni per cui unirsi con l’obiettivo di realizzare ordini democratici e pacifici. I due conflitti mondiali impoverirono sia sul fronte economico che su quello politico tutte le nazioni europee che vi presero parte, rendendoli eccessivamente dipendenti dai paesi americani ed asiatici.
La Resistenza e l’Europa
La volontà di realizzare l’unione fra gli Stati – che sarebbero diventati europei – si manifestò soprattutto nei paesi sconfitti della Seconda guerra mondiale.
La cosiddetta Resistenza Spirituale in Germania, infatti, si fece portavoce dell’idea della formazione degli Stati Uniti d’Europa, superando la sovranità nazionale attraverso 4 principi fondamentali: lo sviluppo dell’industria pesante europea, la moneta comune, l’abbattimento delle barriere doganali, l’armonizzazione delle politiche fiscali.
In Francia i socialisti erano i più propensi all’unità, mentre Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi intesero fin dall’inizio le politiche europeiste in senso strettamente economico e commerciale.
Tra tutti i movimenti di Resistenza quello italiano fu il più favorevole all’unità. La volontà europeista, seppur confinata alle élite, esplose soprattutto durante il ventennio fascista in opposizione alla politica nazionalistica del regime mussoliniano.

Già nel 1918 Luigi Einaudi propose una “seconda specie di Società delle Nazioni”, una sorta di Stato allargato basato su una sovranità diretta sui cittadini dei vari stati, in grado di stabilire imposte proprie, mantenendo un esercito e una propria amministrazione. Sostenitori di questo progetto anche Giovanni Agnelli e Filippo Turati.
Nel 1935 Carlo Rosselli – teorico del socialismo liberale e anticipatore del Partito d’Azione, il partito più attivo nella causa dell’unità europea – avanzò due progetti: un’assemblea costituente per l’elaborazione di una costituzione europea e la necessità di portare l’idea del federalismo europeo a contatto con le masse popolari. Entrambe le proposte furono accolte dal Movimento federalista europeo (MFE), fondato in Italia nel 1943.
L’obiettivo del Partito d’Azione era la formazione di una “coscienza europea” come condizione essenziale per la realizzazione della federazione. Il Federalismo italiano rimase un fenomeno più unico che raro, poiché non ebbe eguali nel panorama della Resistenza europea.

Con il Manifesto di Ventotene (1944), Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni si facevano promotori di un’Unione europea che avrebbe rivoluzionato gli assesti politici. Spinelli, tra i padri fondatori dell’Unione europea, considerava l’Europa federata non semplicemente la fine dello Stato-Nazione, ma la conditio sine qua non per la nascita di una nuova democrazia, di una nuova cultura politica, insomma la condizione per la Rivoluzione.
La Federazione europea
Dalle idee federaliste e rivoluzionarie del 1944 dovettero passare quasi 50 anni affinché l’Unione europea cessasse di essere considerata un’unione esclusivamente economica. Nel 1992, infatti, con il Trattato di Maastricht nacque l’UE, che andava a sostituirsi alla CECA, CEE e Euratom e soprattutto dopo la sua riformulazione del 1997, i principi fondamentali diventavano l’occupazione e i diritti dei cittadini dell’UE, l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e il conferimento di maggior potere all’Unione nelle politiche mondiali.

«Nei tempi difficili è la forza delle cose a far avvertire come bisogno ineliminabile il riferimento a principi che consentono di sottrarsi alla contingenza e alla nuda logica del potere, riscoprendo una radice profonda di solidarietà “come segnale di non aggressione tra gli uomini”». In questi termini Stefano Rodotà, uno degli autori della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, faceva dalla solidarietà un principio indispensabile e universale per la costruzione di un’Europa unita.
Quando e perché l’Unione europea si riduce a interessi economici
E se, la necessità di costruire un’Europa unita fu maggiormente avvertita nei periodi di profondo spaesamento economico ed esistenziale, al tempo stesso è nei momenti di crisi che i sentimenti nazionalisti ebbero e hanno la meglio. Non a caso, la prima forte battuta di arresto nella costruzione dell’unione fu la crisi del ’29: ciascun paese cercò una soluzione autonoma e quindi conflittuale rispetto alle politiche economiche degli altri paesi.
Alla crisi del 1929 è stata paragonata la crisi del 2008 e, malauguratamente, anche l’odierna crisi provocata dal covid-19. Questi tre momenti sono accumunati dal vacillamento della volontà di essere un’unione europea sotto la morsa del nazionalismo e del protezionismo.
L’UE, nel fronteggiare le ultime due crisi, ha mostrato maggior interesse per i patti di stabilità economica, anziché per la salvaguardia dei Paesi in crisi. Attualmente a creare squilibri sono due temi fondamentali, di natura economico-finanziaria, il Mes e i cosiddetti Corona Bond.
Se per il primo, il premier Conte non ha lasciato dubbi nella conferenza stampa di venerdì 10 aprile, dichiarando apertamente che il Mes non soddisfa le richieste dell’Italia e che quindi non verrà firmato, riguardo ai Corona Bond o Euro Bond la questione è più articolata.

Innanzitutto sono strumenti di debito che nascono dalla richiesta da parte di 9 Paesi (Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Belgio, Grecia, Portogallo, Irlanda e Slovenia) alla UE: «abbiamo bisogno di uno strumento di debito comune emesso da un’Istituzione Europea per raccogliere fondi sul mercato sulla stessa base e a beneficio di tutti gli Stati Membri, assicurando così un finanziamento stabile e di lungo temine per le politiche richieste per il contrasto dei danni causati da questa pandemia».
Si tratta dunque di un debito garantito da tutti gli Stati membri, ma a costi e rendimento uguali per tutti coloro che lo richiedono. Di fronte a questa richiesta si sono formati due schieramenti opposti: da un lato Italia e Spagna, dall’altro Germania e Olanda.
A fare da mediazione la proposta veicolata dal commissario UE all’Economia, Paolo Gentiloni, ossia l’ancoraggio di risorse comuni e obiettivi condivisi, come ad esempio finanziamenti comuni dell’emergenza sanitaria, garanzie UE per la disoccupazione o il sostegno alle imprese.
A tal proposito è stato predisposto un pacchetto di aiuti di 1.000 miliardi per tutta l’Unione, denominato Sure, che Gentiloni ha così definito: «un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità delle imprese».
Le altre misure, oltre al Sure, messe in campo dall’UE sono il potenziamento della dotazione della Bei per le PMI e le imprese fino a 200 mld e il MES a condizioni più morbide: come requisito si chiede solo che sia diretto a coprire le spese sanitarie collegate al covid-19, ma anche esplicitamente vincolato alla supervisione economica e monetaria della Troika e a un ammontare del 2% del Pil 2019 del Paese richiedente.
Secondo il ministro delle Finanze del Lussemburgo Pierre Gramegna «l’Europa è andata avanti a grandi passi e velocemente. Tutti i Paesi europei hanno adottato misure a livello nazionale. Il nostro pacchetto di aiuti in Lussemburgo è enorme, pari a 8,8 miliardi che è il 14,5% del nostro Pil. E l’Italia ha varato grandi interventi. Se sommiamo le misure prese a livello nazionale a quelle europee e al programma pandemico della Bce da 750 miliardi, abbiamo di sicuro uno scudo europeo almeno alla stessa altezza degli Stati Uniti, se non superiore. Non abbiamo la garanzia che andrà tutto bene: non conosciamo tutti i risvolti di questa pandemia. Quando potremo ritrovare la velocità di crociera di prima, nessuno lo sa: ma almeno gli Stati europei si sono dotati di strumenti e volontà politica per uscire da questa crisi il più rapidamente possibile».