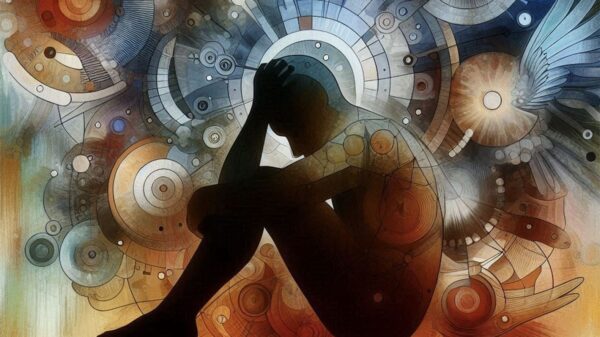Coronavirus e violenza domestica: dati e strumenti operativi per gestire l’emergenza

L’essere umano, secondo Lévinas, si rivela attraverso il volto. Quel volto che si impone come presenza fisica diventando al contempo simbolo di trascendenza, di una dimensione ulteriore e inafferrabile. Guardandoti scopro che esisti proprio in quanto altro da me, ma la scoperta della tua esistenza mi svela la dimensione universale della nostra condizione: la comune umanità che ci appartiene.
Riconoscimento e straniamento, questo è ciò che provoca l’esperienza dell’incontro con l’Altro.
Deformare il volto – attraverso la rabbia, la sofferenza, le botte – deformare il volto attraverso un atto di forza sembra quindi un tentativo di incidere tracce di sé su chi ci è più prossimo, ché quando non si riesce a trovare una chiave di accesso all’anima si tenta di forzare il corpo.
Vera Cuzzocrea, psicologa giuridica e psicoterapeuta, mette al nostro servizio la sua esperienza nell’ambito dei fenomeni di maltrattamento e abuso, aiutandoci a comprendere come superare questo momento emergenziale se si sperimenta una tale condizione di disagio.
Nel corso di questo periodo emergenziale affiora la preoccupazione per tutte quelle persone che potrebbero vivere situazioni di rischio. Si sta verificando un aumento di segnalazioni di violenza domestica in Europa?
Per quanto sia possibile oggi avere piena contezza dell’impatto di questa emergenza epidemiologica e dell’isolamento sociale verso i nuclei familiari violenti alcuni dati, non solo europei, ci suggeriscono che la percezione di rischio è effettiva ed anche emergenziale: Francia e Spagna riportano un aumento di segnalazioni del 30%; la Cina, in particolare la provincia dell’Hubei, registra un aumento del 50%; Austria e Germania, invece, si stanno organizzando per offrire posti nei rifugi alle vittime di violenza o ai familiari violenti delle famiglie in quarantena, come peraltro anche altri Stati e regioni italiane.
Qual è la situazione in Italia?
In Italia è stata registrata una diminuzione di chiamate al 1522 – Numero Anti Violenza e Stalking. Confrontando i dati della settimana che va dall’8 al 15 marzo 2019 con l’attuale è possibile attestare una riduzione di circa il 55% delle chiamate generali: il totale dei casi è sceso da 1104 a 196, con una percentuale di discesa molto più alta per lo stalking (da 33 a 7 casi) rispetto ai casi di violenza. I CAV (centri Antiviolenza) riportano un calo di richieste dell’80 %, al contrario la Procura di Roma riferisce stabilità – la riduzione risulta essere lieve – per quanto concerne i reati previsti dal Codice Rosso: violenza sessuale, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia. Aumenterebbero poi i casi di povertà assoluta per molte famiglie e bambini, con ridotte disponibilità economiche per l’acquisto di beni alimentari e senza gli strumenti tecnologici necessari per rimanere in contatto con le modalità scolastiche a distanza, come segnala Save The Children Italia in una recente ricerca. Aspetto questo che potrebbe far emergere situazioni varie di trascuratezza infantile.
Pensi che le misure restrittive cui siamo sottoposti potrebbero sollecitare l’emergere di comportamenti aggressivi?
La chiusura delle scuole, come dei centri diurni e delle attività ludico-sportive, certamente desta apprensione. Il rapporto fiduciario che spesso si instaura tra insegnanti e allievi permette di intercettare eventuali forme di malessere, quindi di intervenire. In assenza di spazi fisici fondati sulla relazione la sentinella sociale si abbassa e aumenta la preoccupazione per il sommerso, per tutto ciò che in assenza di un veicolo attraverso il quale manifestarsi resta sotterraneo.
I fattori di rischio – che non rappresentano la causa di comportamenti violenti ma possono acuire un malessere – hanno la capacità di agire anche sulla persona maltrattante: pensiamo allo stress prodotto dalla mancanza di relazioni sociali o da eventuali problemi economici causati dall’assenza di lavoro che, in alcuni casi, potrebbero rinforzare o condurre all’abuso di alcool o sostanze stupefacenti. Ad esempio, in Groenlandia, in cui è già un problema serio l’abuso sessuale (un adulto su tre ne sarebbe stato vittima durante l’infanzia), per contrastarne l’incremento, il Capo del Governo ha disposto il divieto della vendita di alcool fino al 15 aprile. Di contro consideriamo l’aumento di mansioni domestiche e di cura, soprattutto per chi ha dei figli.
Segnalo, tra l’altro, un dato interessante: ad essere impegnate nelle professioni di natura sociale o sanitarie è il 70% delle donne, questo potrebbe provocare uno stato di ansia relativo alla gestione del rischio di contagio e in generale della quotidianità familiare, non potendo in generale contare su aiuti esterni.
Sono stati varati dei provvedimenti volti alla tutela delle vittime di abuso?
La nostra Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha emanato una circolare che ha per oggetto la violenza di genere e domestica attraverso la quale si invitano le Case Rifugio e i Centri Antiviolenza a rimanere attivi. Viene garantito, quindi, l’ingresso e l’accoglienza delle vittime di violenza all’interno delle Case Rifugio e incentivato il lavoro da remoto dei Centri Antiviolenza, questo al fine di garantire una rete di supporto efficace a tutte le vittime di abusi e maltrattamenti, assicurando la riduzione del rischio di contagio durante il periodo di emergenza epidemiologica.
Puoi aiutarci a fare chiarezza rispetto agli strumenti operativi – servizi telefonici e applicazioni – da poter utilizzare in caso di emergenza?
Oltre al 1522 esiste un’altra linea telefonica: il 114 – Emergenza Infanzia. Entrambe sono gratuite, raggiungibili sia da linea fissa che da linea mobile e attive tutti i giorni dell’anno 24h su 24.
Nello specifico il 114 è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo in cui sono coinvolti bambini e adolescenti; il 1522 – Numero Anti Violenza e Stalking – è attivo per segnalare situazione ambigue che non comprendiamo o riguardanti persone che non parlano bene la nostra lingua: l’accoglienza è disponibile in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo; inoltre viene fornito un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Oltre a queste linee è importante ricordare anche il NUE ovvero il Numero Unico Europeo 112 per la gestione delle emergenze, ormai attivo in molte regioni italiane. È importante conoscere anche l’esistenza di applicazioni, strumenti più agevoli in un momento in cui la convivenza forzata rendere difficile allontanarsi per effettuare chiamate. YouPol è un’applicazione della Polizia di Stato che permette di geo localizzare l’autore della telefonata nel momento stesso in cui chiama e mette in connessione la persona richiedente aiuto con la Centrale operativa della Questura competente del territorio. Anche chi è stato testimone diretto e indiretto, come i vicini di casa, ha la possibilità di segnalare il fatto all’autorità di Polizia, inviando un messaggio con foto, audio e/o video.
Infine, l’applicazione Mytutela consente la raccolta di elementi – prove di stalking, minacce e violenza – a fini probatori sul proprio cellulare. Il procedimento è il seguente: si inserisce il numero della persona dalla quale ci si vuole tutelare, si validano i dati raccolti attraverso il pulsante “salva e certifica dati” e, una volta certificati, si accede alla possibilità di scaricarli e di consultarli dalla propria area riservata.
Ferma restando la necessità di allertare le autorità competenti in caso di emergenza, pensi che la psicoterapia possa essere un percorso utile per le vittime di violenza domestica che si trovano nella fase di ricerca della consapevolezza rispetto alla propria condizione di vulnerabilità?
La psicoterapia e in generale il supporto psicologico forniscono un importante supporto alla vittima, per questo sarebbe necessario continuare a garantire la nostra disponibilità anche a distanza e nel caso di eventuali nuovi contatti. Con le vittime di maltrattamenti in famiglia il percorso però presuppone anche una conoscenza mirata del fenomeno e dei meccanismi relazionali disfunzionali di cui si caratterizza. È ad esempio fondamentale quando veniamo a conoscenza di una possibile condotta violenta comprendere se la vittima ne ha piena o parziale consapevolezza e non stupirsi se emergono atteggiamenti tendenti alla minimizzazione o negazione dell’offensività del maltrattamento subito. Sappiamo infatti che nella violenza domestica possono ciclicamente alternarsi varie fasi. La fase della tensione, la prima, è un momento esplosivo caratterizzato dai continui litigi, grida, atteggiamenti violenti e può durare giorni come anni. La vittima percepisce questi eventi come sporadici, spesso ha l’illusione che possano attenuarsi e tende a mitigare l’impatto degli episodi che subisce.
La seconda è la fase dell’esplosione della violenza vera e propria, momento in cui si verifica un vissuto di ansia costante e si sperimentano un senso di autostima e di auto efficacia ridotti. La vittima, vulnerabile e in preda ad emozioni di impotenza, tende ad isolarsi nel proprio malessere.
Arriviamo poi al periodo più temibile: la fase della calma e della riconciliazione. La persona maltrattante mette in atto una vera e propria azione manipolatoria a danno della vittima, si lancia in false promesse, giura di cambiare. La vittima si disimpegna dal proprio ruolo e tende a convincersi che le cose cambieranno. Spesso in questa fase accade che le donne decidano di rimanere con i mariti violenti per il bene dei figli, nella convinzione che sia più produttivo restituire loro la garanzia della presenza della figura paterna non rendendosi conto delle ripercussioni psicologiche causate dalla violenza a cui assistono.
Con quali strumenti lo psicoterapeuta interviene per orientare questo percorso di liberazione?
Noi psicoterapeuti tentiamo di offrire la possibilità di un percorso volto al graduale riconoscimento della propria vulnerabilità, che sappia seguire i tempi della vittima e rispettarne i bisogni. È parallelamente necessario attivare una serie di abilità che permettano di fronteggiare la condotta maltrattante e in generale restituire consapevolezza circa i rischi legati alla situazione ma anche i propri punti di forza. Ho constatato personalmente, nel mio studio e sul territorio in un servizio di accoglienza che ho coordinato, come le vittime subiscano spesso gli effetti del totale controllo da parte del maltrattante, non solo psicologico e relazionale ma anche economico, lavorativo e sociale. Ecco perché l’intervento deve in generale prevedere anche la messa in rete di più livelli di interventi orientati a promuovere occasioni di benessere e risorse.
Se ne discute ancora troppo poco in un sistema come quello italiano caratterizzato dalla concezione retributiva della pena, ma iniziamo a sentir parlare della giustizia riparativa intesa come un percorso che coinvolge sia l’autore del reato che la vittima di violenza. Puoi spiegarci meglio di cosa si tratta?
Il modello della giustizia riparativa permette di agire su e con tutte le persone coinvolte, non solo vittima e reo ma anche familiari e il sistema della comunità di cui fanno parte, ogni qual volta vi sia un’azione, non necessariamente un reato, che ha prodotto un danno. Le pratiche che si utilizzano attivano occasioni di comprensione delle ragioni legate ad una determinata condotta, rendono tutti i/le partecipanti corresponsabili di un percorso mirato a sanare una relazione compromessa dal danno (nel caso di un conflitto) e/o a restituire benessere in risposta alla sofferenza provocata da un reato, ovviamente quando non sussistano più altre esigenze di protezione (come ad esempio nella fase iniziale dell’iter giudiziario) e che, per essere comprese, necessitano dell’assenza di ragionamenti stereotipati.
In questo modo, abbandonando il meccanismo retributivo che per essere soddisfatto attende la sofferenza del reo, ci si avvicina a dare senso all’indicibile e si prova a suggerire una risposta a quel bisogno di sentirsi meno vittime. Le ricerche internazionali suggeriscono che l’incontro tra la vittima e il reo, all’interno di un processo riparativo, influisce sul processo di “guarigione” delle vittime, riducendo livelli di ansia e depressione ma anche restituendo loro una percezione di autoefficacia e di controllo, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di recidiva per chi agisce la violenza, sempre che vi sia anche un percorso trattamentale mirato, che in Italia ancora aspettiamo. Così come siamo in speranzosa attesa di uno sguardo attento alla giustizia riparativa, come occasione virtuosa di benessere individuale e collettivo.