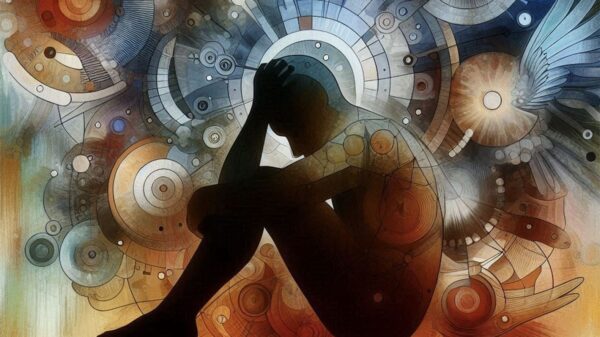I media ci influenzano: basta con la cronaca nera

Chi scrive non segue molto la tv, anzi, quasi per niente se non per i telegiornali durante i pasti, probabilmente come la maggior parte delle persone che non hanno superato la soglia dei trent’anni. Chiunque butti un occhio alla televisione, anche di tanto in tanto, sa comunque che il tema preferito dei telegiornali italiani rimane sempre lo stesso: la cronaca nera. Ma perché?
Tg e programmi
Nel nostro caso prendiamo come punto di riferimento ovviamente la televisione nazionale, in particolare il canale principale, Rai 1. Lo strumento principale della cara e vecchia mamma Rai è senza dubbio il telegiornale. La struttura gerarchica delle notizie è abbastanza emblematica e rappresentativa di quello su cui la linea editoriale si concentra maggiormente. Dopo questa gerarchia dell’importanza vi è una struttura ben definita che mira a puntare maggiormente sulla tensione dello spettatore, secondo un ben preciso ordine mai casuale. È proprio per questo motivo che l’ordine dei servizi contrappone prima una notizia di cronaca nera con una di politica nazionale, aumentando e diminuendo il livello di tensione, al fine di avere più o meno un ritmo medio costante, concludendosi con le notizie relative allo sport o alla cultura per concludere con una sorta di lieto fine. L’ordine ovviamente è variabile da tg a tg e soprattutto da canale a canele, ma il meccanismo rimane più o meno lo stesso. Ciò che interessa maggiormente è però perché mai tanta attenzione sui fatti di cronaca nera, ovvero, perché mai un omicidio deve avere risonanza mediatica nazionale allo stesso livello di una dichiarazione del Presidente del Consiglio? Dopo la notizia, poi, nei giorni successivi all’accaduto vi sono numerosi servizi che forniscono ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi delle indagini con le interviste ai legali dei protagonisti.
Tutto questo però non basta. Vi sono infatti altri programmi che si concentrano quasi interamente sulle vicende di cui sopra. Il primo che mi viene in mente è La vita in diretta, non di certo un programma marginale dato che occupa per ben due ore il palinsesto di Rai 1 dalle 16.45 alle 18.50. Nella maggior parte dei casi l’argomento principale è l’omicidio “del momento” commentato da opinionisti di dubbia autorevolezza in studio accompagnati però dal collegamento in diretta con un inviato accorso sul posto del fattaccio dove magari riesce anche ad intervistare qualche vicino o passante. Precisamente in questo momento scattano le fatidiche parole «Non ci credo, era una così brava persona!». Da qui in poi il tono in studio, fino a poco prima gioioso ed euforico nel trattare argomenti di certo più piacevoli, diventa improvvisamente tetro e cupo, così come le facce di chi parla e si va avanti per un bel po’ ad esprimere commenti e pareri sui motivi che potrebbero aver portato l’omicida a compiere il gesto estremo. Ovviamente non se ne ricava nulla, non sono indagini né perizie psicologiche o simili, semplicemente chiacchiere da bar che sfruttano la morte di una o più persone per attirare audience, perché si sa: in Italia siamo fissati con gli omicidi, tanto meglio se sono stragi famigliari apparentemente compiute senza motivo.
Come è già stato ampiamento studiato e spiegato in ambienti accademici e non, il rapporto tra fornitori e fruitori della comunicazione è biunivoco. Pertanto gli spettatori influenzano i media e, a loro volta, ne sono influenzati. Questo spiega come mai vi sia tanta attenzione da parte dei mezzi di comunicazione sui fatti di cronaca nera. Quello delle informazioni è un mercato, ad oggi uno dei più importanti e prolifici, per cui si deve puntare a fare maggiore profitto nel fornirle. Se alla base del nostro ragionamento poniamo tale principio, non sarà difficile comprendere come mai in prima pagina o in apertura di tg ci troviamo sbattuti in faccia continui servizi e reportage sull’ultima uccisione: «Il pubblico vuole sentire i più raccapriccianti dettagli dell’accoltellamento? Eccolo servito!».
Agenda setting e coltivazione: gli effetti sul pubblico
Nelle televisioni nostrane ci sono casi di cronaca nera ormai divenuti veri e propri fenomeni entrati nell’immaginario e nella memoria nazionalpopolare. Basta citarne i nomi perché a chi legga sovvengano velocemente i volti, le voci, i titoli dei giornali: Avetrana, Yara, Garlasco, Meredith Kercher e molti altri, purtroppo.
I mezzi di comunicazione (e di informazione in questo caso) di massa influiscono fortemente sulla percezione che i fruitori hanno poi della realtà. Tale ipotesi è alla base della teoria elaborata da George Gerbner negli anni 70 e che prende il nome di “teoria della coltivazione”. L’obiettivo dello studioso ungherese era infatti quello di analizzare le dinamiche attraverso le quali la tv, allora principale mezzo di comunicazione di massa, tuttora al primo posto in realtà specialmente per le fasce più anziane della società, influenzasse la concezione della realtà degli spettatori. Gerbner decise di concentrarsi su alcuni aspetti specifici, tra questi la violenza, e somministrare dei sondaggi a dei campioni di fruitori della tv: forti, medi e deboli. Alla fine della raccolta dei dati emerse come i fruitori maggiori elaborassero una sovrarappresentazione della realtà fortemente influenzata da ciò che la tv trasmetteva. Pertanto quelli che maggiormente subivano la comunicazione di fenomeni di violenza non diventavano violenti, bensì tendevano ad avere un’idea di realtà violenta, dunque insicura. Le immagini quindi del mondo esterno, ovvero le nostre percezioni e rappresentazioni, dipendono tanto dalla personale esperienza reale, quanto dalla nostra esperienza mediale, in base ovviamente a quanto fruiamo delle informazioni forniteci dalla televisione.
Altra teoria affascinante è quella che prende il nome di “Agenda Setting”, elaborata anch’essa negli anni 70 dagli studiosi McCombs e Shaw. Secondo loro i media di massa stabiliscono una gerarchia delle notizie che influenza poi in modo diretto anche il pubblico. Ciò fa sì che l’argomento di cui si parla maggiormente o ci si interessa sia lo stesso che viene messo al primo posto dai media. Di conseguenza anche i rappresentanti politici trattano gli argomenti e le notizie che hanno i ruoli primari nell’agenda pubblica stabilita dai media.
Qualche dato a supporto
Il rapporto effettuato da Demos evidenzia le impressioni fino a qui descritte. Il periodo di tempo analizzato va dal 2007 al 2017 e mostra un’immagine di per sé ansiosa dei telegiornali italiani. Le notizie ansiogene calano lievemente, restando comunque al 20%. Nella gerarchia delle fonti di insicurezza sociale troviamo rispettivamente al primo ed al terzo posto, la criminalità in generale ed il pericolo connesso all’immigrazione. Dato estremamente particolare riguarda la specificità tutta italiana: i tg nostrani infatti mediamente hanno il triplo delle notizie relative alla cronaca nera rispetto alla media dei tg britannici o spagnoli. La cosa ancora più interessante riguarda però gli effetti prodotti sulla popolazione: secondo l’ISTAT gli omicidi sono, nello stesso periodo preso in esame dall’analisi, in netto calo, tuttavia l’andamento pare diametralmente opposto se si guarda tali mezzi di informazione e non è un caso che gran parte della campagna elettorale dei vincitori alle ultime elezioni nazionali sia fondata proprio sul concetto di sicurezza personale.