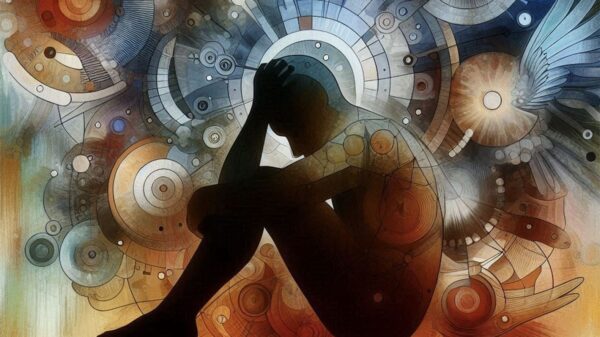I politici non pubblicano post come i nostri

Oltre a scrivere su 2duerighe, sono uno studente universitario e per meriti scolastici sono stato inserito in un percorso avanzato, il quale richiedeva la presentazione di una tesina. La scelta dell’argomento su cui costruire il lavoro di ricerca è ricaduta su un’analisi linguistica rivolta alla comunicazione di tre esponenti politici nel social network Twitter. L’obiettivo dello studio è di indagare le strategie comunicative messe in atto attraverso tweets dai leader delle tre maggiori forze politiche italiane, dunque, Di Maio, Renzi e Salvini.
Per conferire alla ricerca un carattere che possa avvicinarsi a più alti livelli di oggettività, si è pensato di non fare una selezione, che sarebbe stata arbitraria così come il criterio selettivo, ma di ritagliare un determinato periodo nel quale esaminare i post. Inizialmente l’arco temporale stabilito all’interno cui analizzare tutti i tweets pubblicati era la delicatissima settimana precedente alle elezioni del 4 Marzo 2018. Ma il motore di ricerca offerto da Twitter per reperire i vecchi tweets può essere inutile se Twitter o l’autore delle pubblicazioni le “banna”, ovvero le rimuove anche dagli archivi cui attinge la ricerca avanzata https://twitter.com/search-advanced?lang=it . Della settimana pre-elezioni ho raccolto i tweets di Renzi e Di Maio ma non quelli di Salvini, evidentemente oscurati.
Così la ricerca poteva basarsi soltanto sui tweets che compaiono sulla piattaforma social di Twitter, ancora non immagazzinati nel motore di ricerca avanzata. Purtroppo un disgraziato evento che ha sconvolto il nostro paese e interrotto in maniera terribile la vita di alcune decine di persone, ha reso la settimana di Ferragosto estremamente vivace e, a mio avviso, più idonea allo studio. I social networks, più in generale ogni media, di fronte ad un avvenimento di grande rilevanza, positivo o negativo che sia, raggiungono maggiori numeri di affollamento e, conseguentemente, è preferibile fare pubblicazioni in questi momenti.
Del resto è come se i leader politici proseguissero sui social la logica del manifesto, non ancora, di fatto, destituita. Più tweets, più visibilità. Più visibilità, più vicinanza. Diversi modi operandi permettono ad un politico di ottenere la fiducia di un nuovo elettore o di tenere stretto chi lo ha votato, ma la via “social” risulta un ambito a cui si presta sempre maggiore attenzione e, di fatto, estremamente efficace al risultato. Un politico pubblica tweets per stabilire un contatto più diretto con il cittadino, per ergersi a punto di riferimento, per rassicurare, per coinvolgere, ma il post non resta immobile sulla bacheca del suo autore.
Il tweet viaggia e compare nei telegiornali, viene citato nelle migliaia di articoli scritti ogni giorno e poi commentato nei talk show la sera, contrapponendo con forza la sua brevità e la nitidezza del pensiero espresso ai fiumi di parole che l’informazione spende su di lui. E’ facile, in questo modo, che il cittadino-spettatore senta vicino il tweet, magari anche portavoce di uno stato d’animo rabbioso che comprensibilmente potrebbe appartenergli e non trova espresso in nessun altro luogo. Ogni tweet ha una sua energia e una sua caratteristica che gli consente di circolare in maniera diversa, ma, di fatto, più se ne parla più è vincente.
Prima di affrontare quest’analisi comparata, che verrà descritta in altri articoli su 2dueirghe, è bene fare un passo indietro.
Prima di Agosto dovevo proporre una tematica su cui lavorare. Durante una lettura disinvolta ho ricevuto uno stimolo che ha spinto ad indirizzare la mia ricerca verso queste coordinate politico-digitali: un articolo comparso ad inizio estate sul “The Guardian” con la firma di George Lakoff. Il linguista statunitense rivolgeva la sua attenzione ai tweets del presidente americano Donald Trump, consapevole dell’importanza che attribuisce alla sua campagna social. Prima di elaborare una metodologia per analizzare i tweets del presidente, Lakoff accusa i giornalisti di essere diventati i “megafoni” del presidente. Per il celebre linguista quello che stiamo vivendo oggi giorno in alcuni paesi occidentali è un livello di politica spostato a quello del marketing. Di una cosa, dunque, più se ne parla, più la si legittima. In questo modo ogni volta che il politico riesce a far parlare abbondantemente di un suo tweet, ha avuto ciò che voleva. Così l’informazione non deve cercare la notizia, riportare assiduamente le assurdità dei social perché potrebbe, ad esempio, fare il gioco di un tweet diversivo che ha il compito di spostare l’attenzione da una altro argomento.
Lakoff presuppone che Trump, avendo fatto il venditore per quasi mezzo secolo, sappia che è il linguaggio a dar forma al nostro pensiero. Il linguaggio funziona attivando delle strutture cerebrali dette “frame-circuit”, in cui un’informazione si rafforza tanto più è ripetuta. Trump ha messo in gioco tutta la sua capacità commerciale per vincere la battaglia politica. Per diffondere “gli imperativi” su cui ha costruito la propria campagna elettorale, Trump ha utilizzato Twitter in maniera magistrale. Incorniciando un pensiero in un tweet, ripetendolo spesso, ha fatto in modo che questo fosse diffuso da altri e dai media, andando a posarsi nei nostri “frame-circuit”. Scrive Lakoff che Trump ha saputo abbindolare la stampa usando una retorica iperbolica. Mai nei tweets del presidente si riscontrano aggettivi moderati, se qualcosa è positivo sarà “ottimo”, “la migliore”, al contrario sarà “un disastro”, “la peggiore di sempre”. Ha costruito il suo slogan “America First” con un’incessante ripetizione di “deal” e “winning”.
In questo modo il linguaggio politico arriva nei “frame-circuit”, specie di chi vive la politica ascoltando passivamente qualche notizia qua e là. Passiamo dal generale al particolare, seguendo Lakoff, per notare come un linguaggio che distorce la realtà, può modificare l’entità della notizia, confonderla o, addirittura, minimizzarla. Nel caso del “RussiaGate” denominato sempre da Trump, sui media e sui social, “caccia alle streghe” o “spygate”, la stampa statunitense ha utilizzato la terminologia del presidente finendo, di fatto, per ridurre l’informatore del FBI ad una spia.
Visto come il linguaggio può dar forma ad un pensiero, all’idea costruita circa un evento, è ovvia la potenza di un tweet politico. Compreso, dunque, anche il meccanismo attraverso cui si propaga quest’informazione viziata, è bene vedere come nasce più nello specifico. Ogni tweet ha l’obiettivo di raggiungere più cittadini possibili, ma non tutti i tweets hanno la stessa funzione. Lakoff nel suo studio sulla strategia comunicativa del presidente Trump elabora anche una classificazione di quattro tipologie di tweet utilizzati:
- Inquadratura preventiva, per ottenere un vantaggio sulla percezione di un fatto (in questa categoria può rientrare “spygate”);
- Deviazione, per distogliere l’attenzione da argomenti delicati;
- Ballon d’essai, ovvero “palloncino di prova”. Il tweet ha una forma retorica necessaria ad attirare pareri ed opinioni, serve a vedere come le persone reagiscono ad un’idea o ad una problematica;
- Diversivi, che rivolgono la colpa ad altri.
Queste tipologie di tweets sono state le armi della campagna elettorale del presidente, ogni volta che un tweet veniva ripetuto era una vittoria, perché quel tweet avrebbe raggiunto il suo obiettivo e i “frame-circuit” di un cittadino. Sposando la narrattiva di Trump si rendono più popolari i suoi pensieri. Gli Stati Uniti sono chiaramente un paese storicamente e antropologicamente diverso dal nostro, per questa ragione non è possibile eseguire un parallelo esatto. Ma la crisi democratica anche in Italia ha portato ad un’invasione populista (ex. “populista” è un termine che veniva, fino a qualche mese, fa frequentemente usato per definire La Lega e il M5S; significa comunemente “andare a favore del popolo ma il popolo non sa qual è il giusto”, in sostanza, quindi, qualcosa di simile alla demagogia). Credete che questo termine abbia giovato ai partiti non populisti? Sbagliato. Salvini ha potuto dirsi, scaltramente, fiero e orgoglioso di essere populista.
Ora con le dovute differenze, anche in Italia la crisi democratica si è evoluta con un cambiamento d’indirizzo politico e anche in Italia l’informazione ha giocato un ruolo fondamentale, ripetendo le “infuriate” sui social e i più “istituzionali” tweets. Anche i leader politici italiani hanno sfruttato la suddetta potenza del linguaggio e i meccanismi dei tweets nelle varie categorizzazioni fornite da Lakoff. La stessa metodologia elaborata dal linguista statunitense può essere applicata orientativamente per lo studio delle strategie comunicative dei tre leader politici italiani. Lo vedremo in altre pubblicazioni.