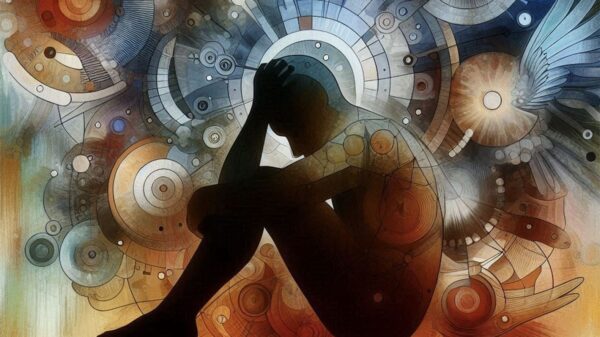Come possiamo continuare ad evolverci

Chi siamo? Da dove veniamo? Qual è la nostra direzione? Sono domande alle quali l’umanità non è in grado ancora di fornire risposte esaustive, certe. Spiegazioni teologiche, altre scientifiche si sono sovrapposte nel corso della storia ma nessuna di queste rappresenta la verità. Bisogna ammettere che negli ultimi due secoli, relativamente alla conoscenza che l’uomo ha di se e dell’ambiente in cui vive, sono stati fatti passi da gigante. Dall’evoluzionismo alla relatività spazio-temporale, dalla rivoluzione psicanalitica al mondo interconnesso, oggi l’uomo sa molto di più su di se e su come dominare la natura da cui è stato generato.
I nostri neuroni sono lontani parenti di cellule di lievito. In milioni di anni microbi semplicissimi si sono trasformati fino a perfezionarsi nelle creature della nostra specie: tutto all’insegna di un monito imperante in natura, l’evoluzione.
Evoluzione è un termine che deriva dal latino, significava “svolgere il papiro”. Collegando la sfera semantica del termine odierna a quella classica si nota come l’evoluzione sia di fatto un dispiegamento di potenzialità, un presupposto che si fa atto in un incessante processo di svolgimento.
E’ così che quel “microbo” è divenuto un individuo che ha imparato a comunicare, poi ad organizzarsi in società, a cooperare e infine a costruire il mondo che oggi conosciamo, all’interno del quale, l’uomo, si sta ancora evolvendo.
L’evoluzione è irrefrenabile e si svolge su due binari: uno genetico e uno mimetico. Quello genetico è il miglioramento naturale che tende a conservare le caratteristiche positive di una specie e ad eliminare quelle nocive o superflue. Quello mimetico rientra invece nella spazio culturale, quell’ambiente in cui uniformarsi, che l’uomo, grazie specialmente a prerogative biologiche, è riuscito a creare.
In questa precisa congiuntura storica, in cui nella cultura umana è entrata a far parte la macchina, in grado di sostituirsi all’uomo non soltanto per prestazioni fisiche ma soprattutto “intellettive”, è fondamentale capire come l’uomo si evolve rispetto ad avvenimenti di questi genere.
Nulla è immediato e nessun lettore, quindi, potrà avere una conferma nella realtà prima che muoia, almeno credo.
Daniel Dennett ha avuto l’audacia di riassumere nel suo ultimo libro: “Dai batteri a Bach. Come evolve la mente“, cinquant’anni di studi a riguardo. Mr Dennett, filosofo e scienziato cognitivo, ha voluto riflettere come siamo passati dai “batteri a Bach” e come oggi questo processo sia a rischio; per farlo chiede un cambio di prospettiva al lettore.
Il filosofo fonda la sua argomentazione su un presupposto essenziale: “competenza senza comprensione”. Secondo Dennett i cambiamenti innescati dal passaggio dalla cultura analogica a quella digitale, intercorrono e interagiscono reciprocamente su quei due binari, genetico e mimetico. L’uomo è stato in grado di costruire intelligenza artificiale ma ora non deve sottomettersi ad essa. Un computer è in grado “di fare calcoli complicatissimi senza sapere cosa sia l’aritmetica”. Il rischio per Dennett è che l’uomo assecondando l’utilizzo della macchina per funzioni intellettive, o meglio risparmiando le energie del proprio cervello con l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, “blocchi” la propria evoluzione. In che senso?
Dennett prevede che i computer aumenteranno sempre la loro competenza ma ritiene improbabile che riusciranno a sviluppare capacità di comprensione. La preoccupazione e il monito che emerge dal libro del filosofo è gli uomini possano sovrastimare l’intelligenza artificiale e iniziare a dipendere fortemente da essa, con un conseguente impoverimento delle proprie facoltà. Ecco come risalta la reciprocità del binario genetico e di quello mimetico.
Questa considerazione non differisce molto da quello che esprimeva Umberto Eco nel 2014 sull’Espresso. L’illustre studioso invitava i giovani ad imparare memoria la formazione della Roma o i la “Vispa Teresa” per non indebolire la nostra memoria, perché Internet non può sostituirsi alla nostra coscienza né alle nostre funzioni intellettive.
E’ evidente la vicinanza delle due opinioni. Dennett delucida chiaramente che l’uomo non può smettere di comprendere quando sfoggia le sue competenze, altrimenti si assimilerebbe ad una macchina, anzi sarebbe, perfino, inferiore ad essa.
Il punto di vista di Dennett ha delle controversie e alcuni controbattono la sua tesi. Uno studioso come De Kerckhowe, consapevole di tali dinamiche, non ha espresso, d’altro canto, la stessa sfiducia nei confronti dei computer, anzi ha affermato la loro importanza se usati secondo criterio.
Per concludere, direi: bisogna comprendere intensamente, perché avremo delle competenze illimitate.