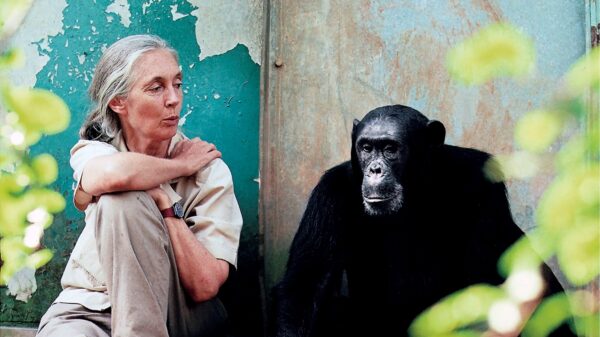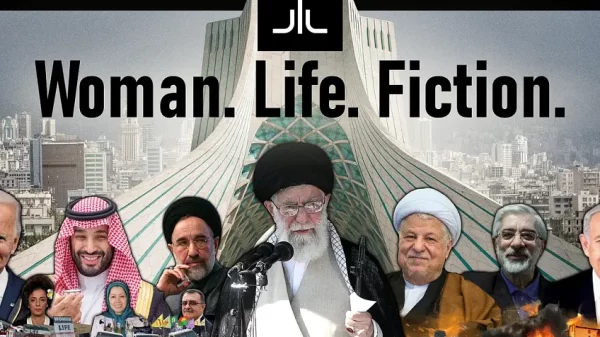Intervista a Carlo Montanaro, curatore della mostra Pasinetti fotografo e cineasta.

Pasinetti fotografo e cineasta è il titolo dell’esposizione al Teatro dei Dioscuri al Quirinale, inaugurata lo scorso 22 Novembre e aperta al pubblico fino al prossimo 28 gennaio 2018. La mostra è stata ideata e curata da Carlo Montanaro, organizzata e promossa da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia.
Abbiamo avuto il piacere di entrare in diretto contatto con il curatore della mostra, Carlo Montanaro, per una piacevole intervista di approfondimento sulla figura artistica di Francesco Pasinetti.
Come nasce la mostra romana da lei curata in onore di Francesco Pasinetti e con quali intenti?
La mostra romana nasce dalla mia necessità di riportare Pasinetti a Roma, una necessità che non ero riuscito a concludere nel periodo delle manifestazioni progettate per celebrare il centenario della sua nascita (2011-2012), e che finalmente ora, grazie a Roberto Cicutto di Luce/Cinecittà e a Felice Laudadio del Centro Sperimentale di Cinematografia, ha potuto concretizzarsi anche grazie all’uscita del volume Francesco Pasinetti – Questa è Venezia.1943, edito da Marsilio Editore. Pasinetti era morto a Roma il 2 aprile del 1949 drammaticamente e in maniera del tutto improvvisa a causa di un aneurisma aortico; non aveva ancora compiuto 38 anni. Da quando era morto, a parte il primo anno di cordoglio e manifestazioni, Pasinetti non era più tornato a Roma. Era un personaggio molto amato e conosciuto, in qualche modo era una sorta di leader. Questa sua leadership era accolta ed accettata dai suoi coetanei, che non la subivano minimamente. I coetanei con cui Pasinetti si relazionò in vita provenivano da ambienti anche molto diversi, a testimonianza di un aspetto che la mostra farà soltanto intravedere, vale a dire la poliedricità del personaggio.
La mostra si intitola “Pasinetti fotografo e cineasta”. Iniziamo dalla prima metà del titolo: che fotografia è la fotografia di Pasinetti?
La necessità di Pasinetti di avere delle fotografie ad hoc per gli articoli che scriveva, unitamente al fatto che era solito portare sempre con sé la macchina fotografica parlano in favore di una vocazione anche fotografica da lui profondamente sentita. Provenendo inoltre da una famiglia di pittori, il nonno Guglielmo Ciardi è stato un grande pittore del vedutismo veneto e italiano, e due zii fratelli della madre erano anch’essi pittori, Pasinetti operò una scelta di campo, per cui se nonno e zii pitturavano in bianco e nero, lui scelse per esprimersi con la stessa profondità di pensiero e d’ispirazione i nuovi modi per costruire immagini, ossia fotografia e cinema. È cominciata prima la fotografia, più semplice da gestire, in seguito il cinema, quello amatoriale prima, quello professionale poi. Il titolo della mostra menziona prima di tutto il versante della fotografia, perché questo era l’elemento più dato per scontato, ma meno conosciuto da un punto di vista autonomo, che non fosse dipendente dal cinema. Presentando la mostra ne vien fuori a mio avviso l’opportunità di parlare genericamente di Pasinetti come artista, che usa i sistemi dell’oggi e non i sistemi di un tempo, non perché il disegno e la pittura siano superati, ma perché Pasinetti nel corso della sua vita è andato alla ricerca di questi nuovi linguaggi comunicativi.
Passando alla seconda metà del titolo, Pasinetti ha lavorato molto per il cinema, ma solo una volta come regista di un’opera narrativa (Il Canale degli angeli). Come mai?
È il cruccio della sua vita. Il suo sogno segreto è sempre stato quello di fare il regista di lungometraggi, ma sotto questo aspetto si è dovuto scontrare con la produzione. Non è mai riuscito a portare a buon fine dei progetti, che lui stesso lanciava. La prima fase nell’ideazione di un film, ossia la creazione di un soggetto, era quasi tutta sua; arrivato il momento in cui il progetto dalla carta doveva diventare esecutivo, a quel punto veniva messo da parte. Non ce l’ha mai fatta e la vita relativamente breve ha fatto in modo che ciò non avvenisse.
Ne Il Canale degli angeli così come nei suoi cortometraggi Pasinetti rende omaggio e narra la sua città, Venezia: qual era il suo rapporto con Venezia e che immagine voleva dare della sua città?
Amava tantissimo la città, la conosceva in tutte le sue forme. Ricordiamo che Pasinetti realizzò una guida di Venezia, che in tre lingue raccontava tutte le vicende della città; alla fine della guida inoltre attraverso delle piantine aveva creato dei percorsi per andare alla ricerca di una Venezia completa e complessa. La conoscenza di Venezia ancora oggi si limita a Piazza San Marco, Ponte di Rialto e poche altre amenità. Invece Pasinetti voleva che si entrasse veramente dentro la città, la si vivesse con un’attenzione diversa. Venezia è una città talmente complessa e senza tempo, che può custodire costantemente delle cose che invece hanno il loro tempo, cioè sono vecchie, ma non si rivelano subito agli occhi del visitatore frettoloso. In questo senso il cortometraggio Venezia minore è un’idea straordinaria. Quello che lui amava era vedere non la monumentalità dei grandi elementi architettonici, ma le cose minori, consuetudinarie, sempre dentro una chiave di lettura classica, importante dal punto di vista luministico e compositivo. L’elemento fondamentale che unisce Pasinetti alla tradizione pittorica della sua famiglia, così come al cinema e alla fotografia, è la luce, lo studio dei grigi, delle ombre e delle zone illuminate dal sole.
Qual è stata la posizione critica assunta da Pasinetti nei confronti della Mostra del Cinema di Venezia e che rapporto ha intrattenuto con questa istituzione della sua città nel corso degli anni?
È una storia un po’ complessa quella di Pasinetti con la Mostra del Cinema, riassumibile dicendo che partecipò alla Mostra fin dal primo giorno. Scriveva infatti su uno dei quotidiani veneziani ed era molto critico per la commercialità della Mostra, che secondo lui accompagnava la presentazione di opere di dubbio valore artistico. Non bisogna dimenticare che Pasinetti si era laureato all’Università di Padova con una tesi (Realtà artistica del cinema. Storia e critica), che per la prima volta conferiva al cinema la stessa dignità di tutte le altre arti. Ha sempre continuato a non osteggiare, ma a criticare la facilità di un certo cinema commerciale, anche e soprattutto del cinema americano. Contemporaneamente però Pasinetti era riuscito ad inserire all’interno della Mostra il lavoro dei giovani, perché lui aveva cominciato a filmare con il Cineclub Venezia, che poi era diventato Cineguf, l’associazione degli universitari fascisti che potevano esprimersi in littoriali anche nel cinema. Per un paio d’anni era riuscito a far coinvolgere nella Mostra addirittura i prodotti europei di questi giovani, che si esprimevano attraverso il cinema in modo sperimentale, con una formula che poi diventerà il nome della scuola che ancora oggi esiste, vale a dire il Centro Sperimentale di Cinematografia fondato a Roma. Pasinetti periodicamente è stato dentro la Mostra del Cinema; poi con la rinascita dopo i drammi della guerra aveva anche sperato di poterne diventare direttore. Non era riuscito ad ottenere questa possibilità, ma aveva avuto la direzione del Centro Sperimentale di Cinematografia. Ebbe però il grande vanto di riaprire quando ripartì la Mostra nel dopoguerra con un suo documentario, Piazza San Marco, vincitore a Venezia quale miglior cortometraggio. Due bellissimi documentari, appunto Piazza San Marco e il Palazzo dei Dogi appartengono alla seconda fase della sua carriera di documentarista, in cui Pasinetti descrive in maniera straordinaria questi due manufatti unici ed irripetibili.
In una delle foto scattate durante le riprese in un teatro di posa, Mussolini assiste tra il pubblico. Dal 1938 invece la direzione del periodico Cinema, alla cui redazione collabora anche Pasinetti, è affidata al figlio del duce Vittorio Mussolini. Qual è stato il rapporto di Pasinetti con il fascismo?
Cinecittà era stata appena inaugurata e Pasinetti era sceneggiatore nel film I due misantropi diretto da Amleto Palermi; probabilmente Mussolini aveva partecipato in visita a quello che doveva essere un primo ciak del film. Mussolini, che chiamava il cinema l’arma più forte, aveva voluto fortissimamente la creazione di Cinecittà. Pasinetti, chiamato da Luigi Chiarini come docente di Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia, era diventato a tutti gli effetti un impiegato statale. Allora se voi avete presente la grande fotografia dei ritratti di Pasinetti, che c’è all’inizio della mostra, potete notare un dettaglio, vale a dire che Pasinetti ha sempre una mano accostata al bavero della giacca. Quello era il suo vezzo, perché il bavero della giacca era il punto in cui avrebbe dovuto portare la spilla del partito fascista, dal momento che chiunque lavorava per lo Stato doveva essere iscritto al Partito. Pasinetti non ha mai avuto incarichi pubblici in politica, però ha sempre lavorato e quindi come tale non poteva non essere all’interno del meccanismo civile dell’epoca legato al governo fascista. Ne Il Ventuno, rivista che aveva fondato con il fratello nel 1932 e che aveva gestito per parecchi anni, diventata poi il trisettimanale del GUF, c’erano articoli e posizioni di fronda; questo a significare che Pasinetti non è mai stato un fascista in senso ideologico, ma uno che doveva vivere nel fascismo, continuando in primo luogo a fare ciò che gli interessava maggiormente, ossia lavorare nel mondo della scrittura e del cinema.
Nel 1933 Pasinetti si era laureato in Lettere all’Università di Padova con una testi intitolata Realtà artistica del cinema. Storia e critica. Era la prima tesi sul cinema come forma d’arte. Cosa è cambiato da allora in avanti nella concezione del cinema?
Le rispondo citando quello che mi disse una volta tanti anni fa il critico cinematografico Fernaldo Di Giammatteo, mentre era impegnato a realizzare un documentario sulla vita di Pasinetti. Fernando Di Giammatteo, nato sulla pagine della rivista Cinema, mi raccontava che grazie alla tesi di Pasinetti, grazie all’attenzione che lo stesso Pasinetti aveva nel ricevere le lettere che i giovani gli inviavano sulla rubrica dell’ultima pagina di Cinema e grazie all’attenzione con cui rispondeva alle loro domande o condivideva con loro pareri, grazie a tutto ciò Pasinetti ha formato la classe della critica cinematografica del dopoguerra, incarnando per questa generazione di critici la figura di un maestro. Il suo lavoro di tesi, che è stato ripubblicato qualche anno fa sempre con l’Istituto Luce, è un po’ la bozza di quella che sarà Storia del cinema dalle origini al 1939, la prima importante storia del cinema, diventata la “Bibbia” per i giovani degli anni ’40 e ’50, edita nel 1939 da Edizioni di Bianco e nero, la rivista del Centro Sperimentale di Cinematografia.
Si può parlare dell’opera di Pasinetti come antesignana del neorealismo italiano?
Assolutamente sì. Pasinetti è stato uno, forse anche il primo, che già ne Il Canale degli Angeli è andato a girare per strada; addirittura i suoi primi documentari avevano sempre a che vedere con la vita reale. Questo suo interesse per gli elementi presi dalla vita, che si può riscontrare ugualmente in Venezia Minore, fa capire come Pasinetti esprime la poetica del neorealismo, che è quella di avvicinarsi alla gente non per i massimi sistemi, non per i grandi temi come l’amore o il potere, ma per la constatazione della vita reale; al tempo stesso si rivela importante inserire queste persone nella realtà luministica e nella ricerca estetica delle riprese cinematografiche. Il primo degli allievi che seguirà questa strada nel genere del documentario sarà Michelangelo Antonioni con Gente del Po. Antonioni mostra di aver seguito la realtà della vita, ma di avere cercato fotograficamente di mantenere la qualità estetica e compositiva, che in nessun modo contrasta con il realismo.
Ringraziamo sentitamente Carlo Montanaro per la sua disponibilità e cortesia.