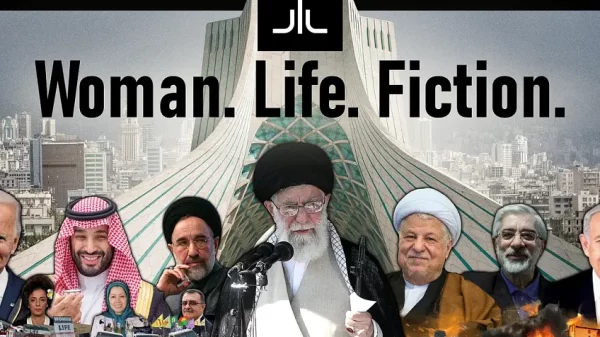L’arte degenerata è una lente sulla gerarchia culturale

Who’s afraid of Red, Yellow and Blue? è un dipinto del pittore astratto Barnett Newman. È alto due metri e mezzo e largo cinque e mezzo. Il titolo è una citazione al dramma teatrale di Edward Albee: Who’s afraid of Virginia Woolf. Nell’opera, quattro personaggi capovolgono completamente la loro vita nel corso di tre ore e 68mila parole. Nei dipinti di Newman ci sono soltanto tre colori. Tuttavia, nonostante l’apparente semplicità del dipinto, Red, Yellow and Blu n.3 è rimasto esposto allo Stedelijk Museum di Amsterdam per molti anni. Finché, un giorno è stato “accoltellato”.

Who’s afraid of Red, Yellow and Blue, Barnett Newman, Stedelijk Museum, Amsterdam, 1966.
Nel 1968, un uomo entrò nello Stedelijk, si mise accanto al dipinto e ne squarciò un totale di 15 metri di tela con un taglierino. Per questo gesto, il vandalo finì in prigione ma ricevette anche molti plausi. Infatti, Red, Yellow and Blu n.3 era già stato sommerso da molte critiche sin dal suo arrivo al museo. Prima di essere squarciato, il museo ricevette dozzine di lettere furiose e chiamate al museo. Secondo le persone, il quadro le faceva sentire fisicamente male. Ma, a monte di tutto, è poi così grave quanto successo? Possibile che nessuno si sia ancora messo su Paint a rifarlo? Quanto ci vorranno, 10 minuti? Se lo facessi effettivamente – e potrei farlo – questo rappresenterebbe l’ennesimo esempio di come il mondo dell’arte convinca sé stesso che qualche macchia di vernice su una tela siano arte. No? Forse no.
Il video che vedete è l’estratto di un gioco gratuito su Itch.io chiamato “2.22 AM”. In molti aspetti è incredibilmente semplice, quasi ridotto all’osso, ma ha qualcosa di strano. Si salta tra diverse “scene” alternate con video sgranati di docce, bivi vuoti e soffioni. A volte sembra un gioco horror, ma non in maniera voluta. O meglio, lo è nel modo in cui può essere horror un incubo in cui non succede nulla di brutto, in cui tutto sembra normale; eppure, sappiamo che qualcosa non va. Di suo l’esperienza di gioco non segue una storia specifica, né una sequenza precisa di eventi. Spesso non c’è neanche modo di interagire con alcune scene. Cliccando, a volte succede qualcosa, a volte no. Ogni tanto si ha piena libertà di movimento. Di tanto in tanto bisogna svolgere compiti come aprire un frigo o scavare una tomba.
Personalmente, 2:22 AM mi ha fatto sentire a disagio, mi ha fatto pensare a tutti gli altri giochi. A quanto siano prevedibili, a come sia facile capirne le regole. Non ci sono molti posti per giochi come 2.22 AM. Tranne Itch.io, che è una sorta di oasi protetta per titoli sperimentali. Questo, tuttavia, l’ha reso il bersaglio prediletto di utenti che non apprezzano esperienze di gioco “non tradizionali”. Intanto, grandi piattaforme come Epic Games Stores, hanno promesso che i titoli in vendita saranno soggetti ad una moderazione più stringente. Venderanno solo esperienze di “alta qualità”. Ma chi decide cosa rientri o meno nelle esperienze di alta qualità? Ci ha provato a fine anni ‘80 l’ex senatore della North Carolina Jesse Helms. Durante il suo periodo da politico, Helms era fermamente dedito a preservare la distinzione tra “vera arte” e “devianza”, tant’è che la sua battaglia viene ricordata principalmente per questa frase:
“Abbiamo dieci o dodici quadri d’arte, ma non abbiamo peni stesi sul tavolo”
L’espressione provocatoria era diretta a Robert Mapplethorpe, un fotografo che faceva foto intime a soggetti umani includendo uomini, vari atti di omosessualità e sadomasochismo, nudità di tutte le forme e, per l’appunto, un pene disteso su un tavolo. L’allora senatore definiva gli scatti di Mapplethorpe devianti e attivamente nocivi per la società americana. Ma qui sta il fatto curioso: Helms non provò mai a censurare l’arte del fotografo direttamente, ma solo per interposta persona. Il bersaglio esplicito del politico era il National Endowment for the Arts, un programma del governo americano che stanziava fondi ad artisti, artiste e musei in giro per il Paese.
L’arte di Mapplethorpe era abominevole e, come non bastasse, l’America la stava pure sovvenzionando (con una somma irrisoria per cittadino americano)! Ma Helms era un uomo di sani princìpi! Avrà anche supportato l’invio di squadroni paramilitari per compiere massacri governativi in America Latina negli anni ’80, ma voleva almeno salvare gli americani dallo spendere quello sputo di centesimo per quelle immagini degenerate. O pudici dipinti di paesaggi o niente!

Ajitto, Robert Mapplethorpe, George Eastman Museum, stampa in gelatina d’argento, 1981.
La sua retorica era così efficace che, grazie alle pesanti proteste dei cittadini, il Museo di Washington cancellò le esposizioni di Mapplethorpe dalla programmazione museale. Eppure, appena ufficializzata la decisione, il museo ricevette un’inaspettata e furiosa chiamata dell’ex senatore, in cui voleva sapere come mai avessero cancellato la mostra fotografica. Helms non voleva eliminare le sovvenzioni; anzi, voleva che quelle foto continuassero ad essere mostrate.
Ma come onorevole Helms! Se pensa che l’arte danneggi la società, non dovrebbe cercare di nasconderla? “Domanda ingenua!” ci avrebbe risposto in uno slancio inaudito d’onestà. Il suo obiettivo era alimentare l’indignazione pubblica e per farlo le foto dovevano continuare ad essere visibili. A Helms non interessava un fico secco d’arte, desiderava soltanto istigare la rabbia degli everyday americans per rappresentare l’insofferenza della nazione verso stili di vita non tradizionali. Ma quello di Mapplethorpe non è l’unico caso di avversione per l’arte contemporanea. Scomodiamo, ad esempio, il lavoro del più celebre Mark Rothko. La sua non è un’arte descrivibile coi soliti aggettivi che usiamo per connotarla.

Mark Rothko al Tate Modern, Black on Maroon, 1958.
Questo quadro è bellissimo? Sì, ma non è “bellissimo”. È complesso? In realtà sì, ma non nel modo in cui intendiamo “complesso”. Cos’è? Sono linee cicciottelle di rosso e marrone su una tela enorme. Eppure, che scossa che fa sentire dal vivo! Non sono in pochi quelli a cui Rothko ha suscitato la stessa indescrivibile sensazione. Le sue sono opere sovversive, sfidano l’idea di cosa debba essere l’arte e a quali criteri debba conformarsi. Nel 2012, infatti, un uomo dipinse il suo nome e una frase nell’angolo di uno dei più importanti dipinti, Black on Maroon. Più tardi, l’autore del gesto affermò che:
“gli artisti contemporanei producono cose che non sono creative nell’essenza… l’arte è diventata un business, utile solo alle necessità del mercato”
A proposito di odiatori delle sperimentazioni contemporanee, come non citare Paul Joseph Watson, celebre youtuber inglese cospirazionista e collaboratore del sito d’informazione Infowars. Watson – che parla in ogni video con alle sue spalle appesa una mappa del mondo che dovrebbe testimoniare la sua ampiezza di vedute – afferma di non avere tempo per l’arte contemporanea. Essa “degrada e sminuisce la società esaltando il volgare, il grossolano e lo scatologico”. Sostiene che essa sia una guerra all’oggettività e che “l’arte fatta bene” esiste; che, insomma, ce ne accorgiamo semplicemente vedendola. Che stiamo rovesciando la “naturale meritocrazia che l’arte dovrebbe avere”. Non solo, sostiene, a causa dell’ignoranza, ma per colpa dell’imperante ideologia buonista. Con questo escamotage, le élites artistiche starebbero elevando arte degenerata per fini economici.
Quest’idea è legata doppio filo con la convinzione che chi crea “arte brutta” sia senza talento. Il ragionamento è anche fin troppo comprensibile. Ognuno di noi avrà pensato, almeno una volta nella sua vita, di fronte a una tela monocolore che “questa potevo farla anch’io”. Eppure, Rothko, re dei rettangoli colorati, è ancora un mistero per il mondo dell’arte. Lavorava a porte chiuse, alterando attentamente la chimica delle tempere con uova, colla, resina e formaldeide. Le sue variazioni tra colori lucidi e opachi sono incredibilmente sottili. Ancora, la profondità di colore offerta da Newman non venne mai più replicata dopo l’assassinio del suo quadro. Il restauro fu un fiasco, sembrava facile ridipingere la parte rossa del quadro. Eppure, gli osservatori si resero presto conto, a lavoro finito, che c’era qualcosa di strano. Non vi era più quella “brillantezza” era sempre Red, Yellow and Blue ma non era Newman.
Nonostante ciò, il dibattito sulla connessione tra arte e abilità non è il punto, anzi concentrarsi solo su quest’aspetto ridurrebbe l’arte a un prodotto. Tant’è che, all’opposto, anche se Caspar David Friedrich avesse impiegato un solo minuto a tratteggiare il suo Monaco in riva al mare, questo non avrebbe cambiato l’inquietudine abissale che quel quadro è in grado di comunicarci. Certo, la difficoltà e il tempo richiesto per fare quel quadro saranno stati tanti, ma non è quello il motivo per cui la gente va lì a vederlo.

Monk by the Sea, Caspar David Friedrich, Alte Nationalgalerie Museen zu Berlin, 1808-1810.
In realtà, lungi da “meritocrazie naturali”, per Helms l’arte dovrebbe semplicemente contribuire positivamente alla società, accrescerla. Ha poi una pretesa così assurda? Beh, cerchiamo di trarre le conseguenze dell’assunto per capirlo. Come può un’espressione artistica contribuire alla coesione sociale? In primo luogo, bisogna far rientrare l’arte in una rigida definizione culturalmente appropriata. Nel suo manualetto d’istruzioni, pertanto, Helms avrà letto quanto sia importante, al fine di ciò, rendere tutto “un’estetica” omogenea. In secondo luogo, quest’estetica dev’essere mitizzata, romanticizzata e sostituita alla storiografia effettiva di una cultura. Infine, una volta che quest’ultima è adeguatamente mitizzata, l’arte che la alimenta è vista come un contributo alla società creata. Perché legittima e cristallizza le sue gerarchie e i suoi rapporti di forza.
È così che si genera il circolo vizioso per cui nel momento in cui la mitologia nazionale si basa sulla sua arte, l’arte della nazione si basa sulla sua mitologia. Nel concreto, se, per esempio, ogni artista apprezzato dall’ideologia dominante degli ultimi mille anni è un uomo bianco che crea opere e messaggi che glorificano ideali bianchi e coloniali, la sua estetica inizierà a sembrare non semplicemente convenzionale ma “naturale”. Così facendo, le gerarchie anziché essere messi in discussione si consolidano. D’altronde, quando diciamo che “è naturale” che una cosa sia così e non altrimenti, stiamo mettendo un punto sulla questione. Tanto quanto faceva Aristotele quando giustificava la schiavitù. Come? Sostenendo che fosse naturale.
D’altro canto, ogni arte che rigetta l’estetica condivisa o, semplicemente, ne segue una differente, non contribuisce più alla narrazione dominante. Infatti, correnti artistiche che seguono estetiche differenti, fanno l’effetto di un attacco, o di una delegittimazione all’ordine “naturale” delle cose. L’occorrenza storica più rinomata di questo processo è rappresentata dai nazifascismi del Novecento (compresa la svolta anti-democratica e nazionalista importata da Stalin in Unione Sovietica). Eppure, qui sta l’apparente paradosso: potremmo guardare, ad esempio, al nazismo e vedere un sorprendente rispetto per gli artisti. Joseph Goebbels chiamava gli artisti “Gottbegnadeten Sinngeber” (elargitori di significato con una dote divina). Bel complimento, per carità, anche se forse ci aveva azzeccato Barbara Fischer quando bollò questo epiteto come figlio di un “banale e forzato tardoromanticismo” dei nazisti. Ma la lode nascondeva di fondo l’idea che “elargire significato” sarebbe stato accettabile soltanto se il significato fosse stato elargito nei confini della mitologia nazionale.

Arno Breker, Die partei, 1939.
In ogni caso, vale la pena prendere in esame specificamente il caso della Germania nazista per una caratteristica. Ci sono poche sfumature dell’arte più apprezzata del Terzo Reich. È più interessante il fatto che, oltre a gallerie piene di ragazzi nudi con spade, i nazisti esponessero anche le cose che odiavano in una galleria chiamata “Arte Degenerata”. Una galleria che conteneva opere artistiche di “deviati” come Henri Matisse, André Derain e Oskar Kokoschka. Quest’arte presentava critiche a norme sessuali e valori familiari tanto cari alla “rispettabilità” borghese nazista. Stili nuovi e trasgressivi di artisti neri ed ebrei era indicativo del loro “intellettualismo degenerato”. I nazisti sostenevano che questo tipo di arte sarebbe solo potuta provenire da artisti folli, degenerati. In particolare sostenevano che bisognasse essere malati mentali per creare questo tipo di astrazioni.
“Eccoci in una mostra che contiene solo una frazione di ciò che era stato comprato coi soldi guadagnati col duro lavoro del popolo tedesco. Intorno a noi possiamo vedere la prole mostruosa di follia, impudenza, inettitudine e puro degrado. Ciò che questa mostra offre ispira orrore e disgusto in tutti noi.”
– Adolf Ziegler, presidente della Camera delle arti visive del Reich
Ai nazisti potremmo fare la stessa domanda che avremmo posto a Jesse Helms: se pensate davvero che l’arte danneggi la società, non dovreste cercare di nasconderla? “Domanda ingenua!” ci avrebbero risposto anch’essi in uno slancio inaudito d’onestà. Il loro obiettivo era alimentare l’indignazione pubblica e per farlo le foto – scusate il lapsus… i quadri – dovevano continuare ad essere visibili. Ancora più curioso è il fatto che, accanto ad ogni quadro degenerato, venisse affiancato, per stimolarne la derisione e la rabbia, il prezzo a cui erano stati precedentemente comprati dalle “élites artistiche”.

The dreaming boys, Oskar kokoschka, Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh.
Torniamo all’inizio con una curiosità sul caso Barnett Newman, anzi due. La prima è che Newman era ebreo, la seconda è che molti degli attacchi ricevuti alla sua opera sono stati di suprematisti bianchi. Un’altra scultura di Newman, “Broken Obelisk” nel ’79 è stata imbrattata con una svastica. Nel 2018, invece, è stata versata vernice bianca nell’acqua che circonda la stessa scultura. Intorno ad essa, dopo l’atto vandalico, sono stati ritrovati volantini di una campagna suprematista nata dal sito web 4Chan: “It’s okay to be white”.
Dunque, traiamo le conclusioni. Quando qualcuno lega l’arte ad un insieme specifico di qualità, attaccando tutto ciò che sussiste aldilà di tali confini in nome della “vera arte” dobbiamo alzare le antenne. Queste qualità sono “accettabili” in quanto prodotte dalla gerarchia che le ha stabilite. Chi fa certi discorsi – che sia in un video su Youtube, vandalizzando un’opera o imprecando dinanzi a un microfono gracchiante circondato di elettori – non mostra rispetto per il mestiere dell’artista, non cerca di “elargire significato”. Sta, più o meno consapevolmente, applicando una gerarchia, sta cercando di definire una narrazione culturale e, ancor di più, non sta parlando di arte.