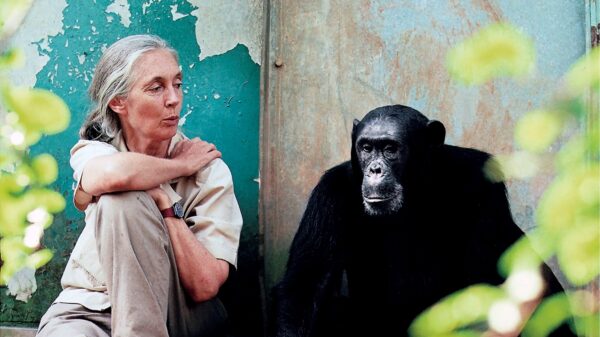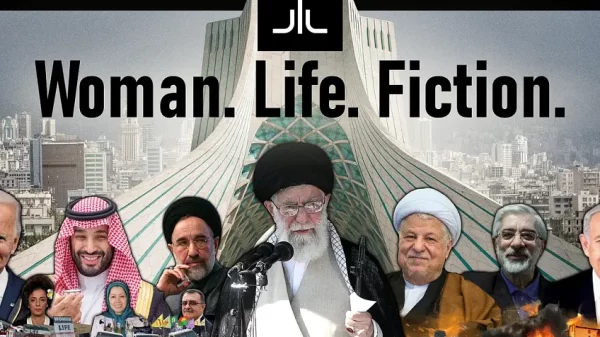GIOVANNI DAL PONTE | Fra antico e moderno
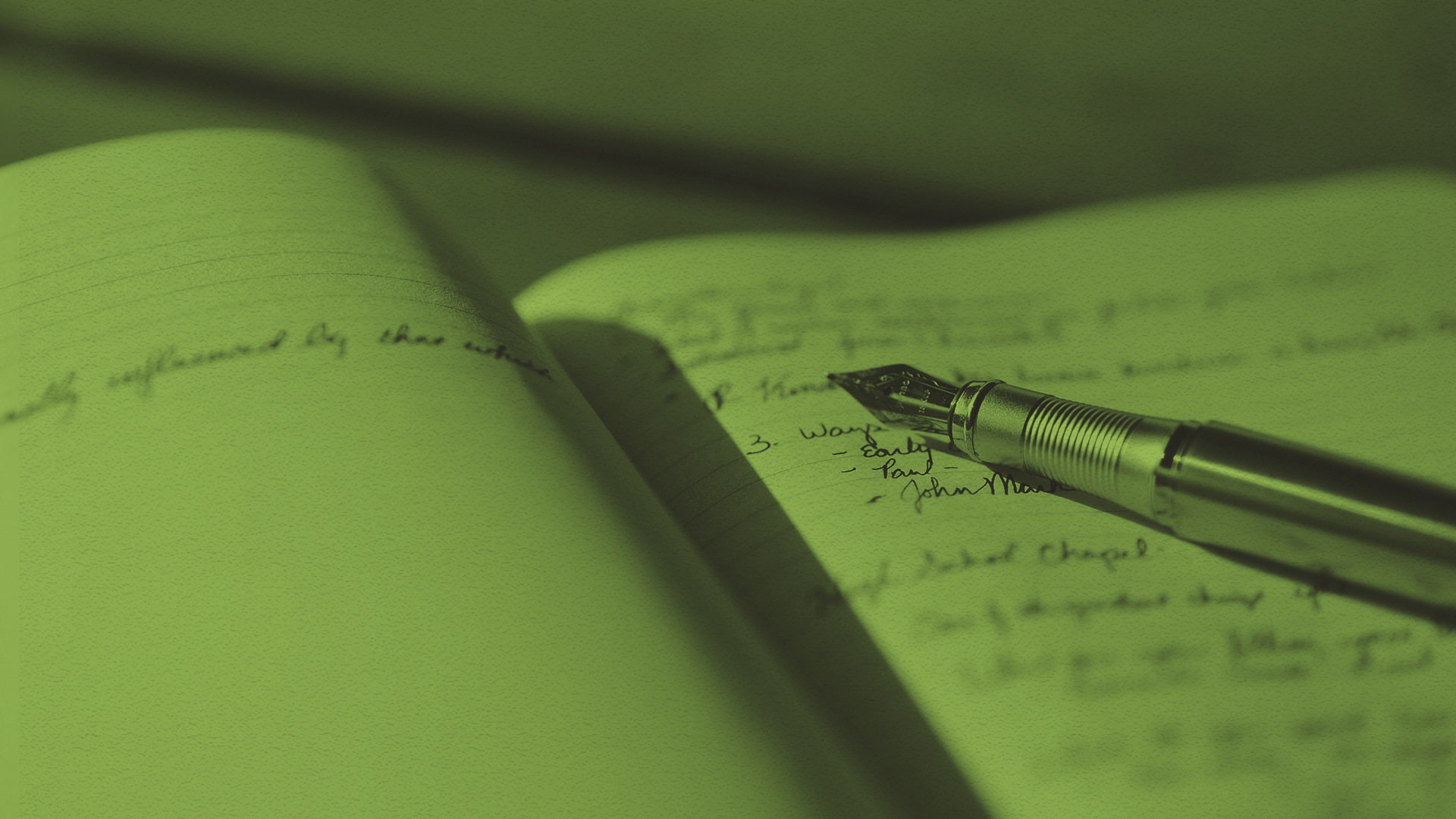
A Firenze, una mostra di studio e di riscoperta di uno degli esponenti più autorevoli della transizione fra Medioevo e Rinascimento. Alla Galleria dell’Accademia, via Ricasoli 58, fino al 12 marzo 2017. www.giovannidalponte.it.
FIRENZE – Se è vero che il Rinascimento prende le mosse dalla “rivoluzione” portata da personalità quali Masaccio e Donatello, geni scapigliati che rinnovarono in profondità l’arte dell’epoca, al loro fianco trovano posto talentuosi colleghi che esprimono una loro particolare visione della pittura.
Fra questi, si annovera il misconosciuto fiorentino Giovanni dal Ponte (1385-1437/38), cui rende omaggio la mostra Giovanni dal Ponte. Protagonista dell’umanesimo tardo gotico fiorentino; curata da Angelo Tartuferi e Lorenzo Sbaraglio, costituisce la prima monografica dedicata all’artista ed è occasione di adeguata valorizzazione delle opere custodite dall’Accademia, affiancate però da prestiti provenienti da prestigiosi musei internazionali, quali la National Gallery di Londra, il Prado di Madrid e il Musée Jacquemart-André di Parigi, prestiti fondamentali per ricostruire in mostra l’intero percorso artistico di dal Ponte.
Il quale visse in un periodo storico cruciale per l’avvenire politico della città di Firenze, a cavallo tra la fine dell’oligarchia seguita al fallimento dell’ordinamento comunale medievale, e l’avvento di Cosimo il Vecchio (1386-1464), ovvero di colui che avvierà l’età medicea, caratterizzata da uno sviluppo culturale ed economico di cui la città non ha più conosciuto l’eguale.
Qui, le ricche corporazioni di banchieri e mercanti rivaleggiavano nel commissionare opere d’arte ai talenti dell’epoca, qui Lorenzo il Magnifico trasformerà il Chiostro di San Marco in una “galleria a cielo aperto” dove Michelangelo poté conoscere la scultura classica. E qui, all’inizio del Quattrocento, rientrò dopo vari anni trascorsi in Spagna Gherardo Starnina, autorevole esponente della pittura tardogotica, la lezione del quale influenzò il giovane dal Ponte. L’intelligenza della mostra sta anche nel contestualizzare la sua opera, accostandola a una selezione di tavole di artisti a lui contemporanei, fra i quali il già citato Starnina, ma anche Paolo Uccello, Lorenzo Ghiberti, Masaccio e il Beato Angelico.
È con loro che si apre la mostra, trasportando di fatto il visitatore nel clima pittorico della Firenze dell’epoca. Il fondo oro di bizantina memoria ancora domina le composizioni, e tuttavia i personaggi hanno persa la loro rigida ieraticità per acquistare un’indubbia carnalità, il tratto di distende, e alla durezza da inferno dantesco si sostituisce una raffinatezza che, per continuare la metafora poetica, è paragonabile ai versi del Petrarca. Santi e Vergini sono eleganti figure dagli abiti raffinati, dalla gestualità sensibilmente ammorbidita rispetto alle medievali spigolosità giottesche. In particolare, la ricerca plastica di Masaccio e dell’Angelico sarà fondamentale anche per lo sviluppo pittorico di dal Ponte.

La prima fase di stacco dalla tradizione tardogotica locale avviene all’inizio del Quattrocento, come testimoniano tre tavole giovanili vicine, per ispirazione, allo stile spagnoleggiante dello Starnina, dai colori vivaci (in particolare la veste del Bambino), e particolari come la lumeggiatura bianca del naso. Di questa influenza spagnolesca sulla pittura italiana e toscana, ci sdebiteremo all’inizio del Cinquecento quando saranno gli spagnoli a calare in Italia per apprendere i rudimenti della “maniera moderna”.
Tornando a dal Ponte, il suo è un tardo gotico moderno, aggiornato al nuovo clima sociale, di fatto già inquadrato nell’Umanesimo. Il talento di questo artista risiede nel fondere senza traumi le due scuole che in quegli anni di transizione si trovarono a convivere, ovvero quella giottesca e quella umanistica. Della prima mantiene la solennità, e sembra di sentir echeggiare un Canto della Divina, mentre la brillantezza dei colori, la raffinatezza dei volti e delle vesti, ci introducono nella Firenze aristocratica del Quattrocento.

Attorno alla metà degli anni Venti, dal Ponte avvia a guardare con maggiore attenzione alla pittura di Masaccio, attraverso l’adozione di una sobrietà sempre più marcata delle nuove opere, che si limitano alla rappresentazione dei personaggi principali, senza sovraffollamenti dalla valenza più o meno simbolica (San Nicola in trono, Madonna col Bambino in trono).
Nella sua ultima fase artistica, dal Ponte sembra tornare alla lezione giottesca mediata da Taddeo Gaddi, lasciando da parte le innovazioni di Masaccio. Un “ritorno all’ordine” ante litteram che ci dà la misura di una personalità a suo modo inquieta.

Di particolare interesse, alcune scene “secolari”, realizzate per i pannelli di cassoni destinati a ricchi committenti. Esemplare la Coppia d’innamorati (1430 ca.), dove spiccano i brillanti colori delle vesti dei due giovani, l’arabesco che orna la pettinatura della donna, e la plasticità dei movimenti.
Parimente suggestiva l’Allegoria delle sette arti liberali (1430-35), al centro delle quali troneggia l’Astronomia, ai cui piedi siede Tolomeo, la cui teoria geocentrica ancora non è stata smentita da Copernico. Aristotele, invece, accompagna la Dialettica, secondo le interpretazioni che la Scolastica aveva dato del filosofo greco, “inquadrandolo” nel sistema teologico cristiano. Forse non casualmente l’opera è caratterizzata da stilemi tardo gotici, che segnano una sorta di ritorno al passato nel percorso di dal Ponte, come accennato di sopra.
Quarantatre le opere in mostra, quasi tutte di soggetto religioso fra grandi polittici (la cui provenienza dalle cappelle gentilizie che testimonia come dal Ponte fosse artista assai richiesto dalla committenza privata) e tavole di dimensioni più contenute, che si offrono ai visitatori incorniciate da un raffinato allestimento, le cui pannellature riproducono le mura in marmo bianco e verde tipica dell’architettura fiorentina del periodo, comprese quelle di molte chiese.
Una mostra raffinata e affascinante, di ampio respiro, che documenta il passaggio cruciale fra il Medioevo e il Rinascimento, decisivo per il progresso dell’umanità.