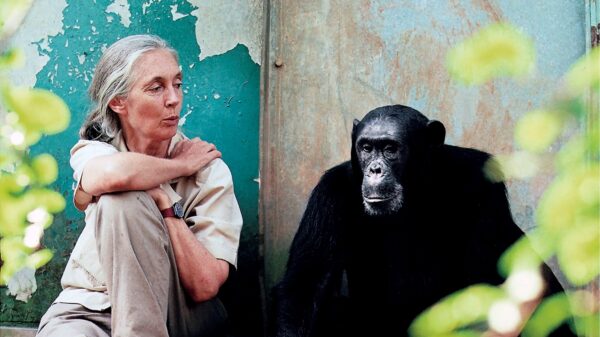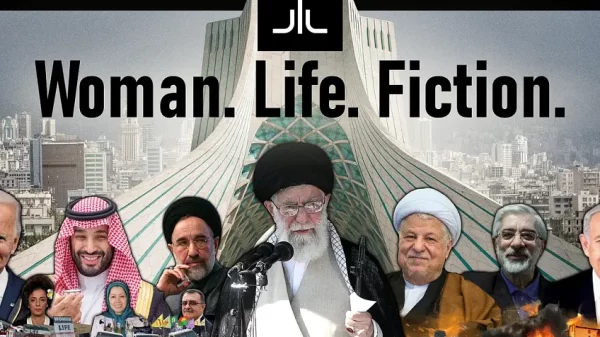La morte del discorso amoroso

La necessità di questo libro sta nella seguente considerazione: il discorso amoroso è oggi d’una estrema solitudine. Questo discorso è forse parlato da migliaia di individui (chi può dirlo?), ma non è sostenuto da nessuno; esso si trova ad essere completamente abbandonato dai discorsi vicini: oppure è da questi ignorato, svalutato, schernito, tagliato fuori non solo dal potere, ma anche dai suoi meccanismi (scienze, arti, sapere). Quando un discorso viene, dalla sua proprio forza, trascinato in questo modo nella deriva dell’inattuale, espulso da ogni forma di gregarietà, non gli resta altro che essere il luogo, non importa quanto esiguo, di un’affermazione. Questa affermazione è in definitiva l’argomento del libro che qui ha inizio.
Rileggendo queste parole, con cui Roland Barthes, nel 1977, giustificava la necessità di un libro come Frammenti di un discorso amoroso, risulta evidente come, a quasi 50 anni di distanza, un testo del genere, che si proponeva di analizzare la dialettica amorosa e la fenomenologia del dialogo tra innamorati, appaia come un disperato tentativo di salvare un’idea di amore che ormai non esiste più. Gli ultimi romantici si ribelleranno a queste parole, tuttavia, in concreto, è l’agito amoroso ad essere sopravvissuto, più della parola.

Non stiamo affermando che l’amore è morto e che i romantici non esistono più, ce ne guarderemmo bene. Certo è che un grande passo indietro è stato fatto nel riconoscimento delle proprie emozioni e, in particolar modo, nella sua verbalizzazione.
Seneca, intorno al 40 d.C., dedicherà un intero trattato intorno al sentimento dell’ira, la più terribile delle passioni.Shakespeare farà gridare al suo geloso Otello: “Tuoni la guerra e s’inabissi il mondo, se dopo l’ira immensa vien quest’immenso amor!”. Montale commuove sempre, quando lo si immagina, ancora una volta, dare il braccio per scendere le scale a Drusilla.
In quelle parole c’è tutta la forza di un sentimento che, una volta espresso, si catasterizza e nell’opera letteraria diviene eterno.

Noi abbiamo smesso di fare poesia e così ci siamo disabituati a dar voce ai sentimenti, l’amore su tutti. Anche l’odio si è verbalmente banalizzato, è scaduto nell’insulto reiterato, privo di invettiva, vuoto vituperio. Le orecchie dei nostri giovani, così come le labbra, si sono abituate a questo alfabeto e, per assurdo, rimangono ferite, imbarazzate da tutta quell’enciclopedia amorosa che nei millenni abbiamo costruito. Ce ne accorgiamo quando – raramente – questi giovani si soffermano a leggere un haiku incrociato per sbaglio su un muro; quando un docente cita loro il verso di una lirica d’amore; quando l’amato, più avvezzo al discorso amoroso, condivide i segreti di quel linguaggio arcano.

Non tutto è perduto vogliamo sperare, ma non possiamo pretendere si parli d’amore, quando i primi ad averne dimenticato il linguaggio siamo noi.