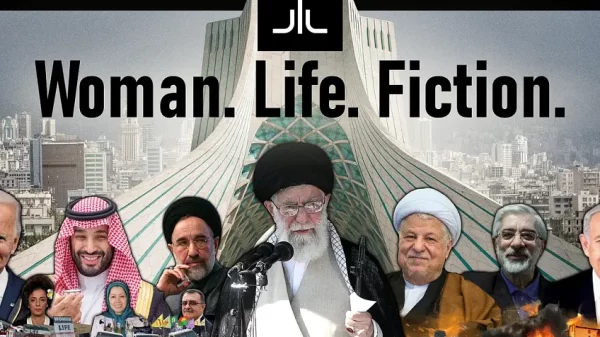“Il disastro di Pavia”: l’eredità di Tolstoj nella storia di Jean Giono

“Mi sono rimasti solo l’onore e la vita” così verga con pathos regale la maestà di Francia, Francesco I, le lettere alla lontana madre, Luisa Di Savoia, dalla sua prigione d’Italia. Parole di un sovrano-cavaliere catturato dalle forze spagnole sul grande palcoscenico dei conflitti europei del XVI sec., l’Italia e i suoi molteplici campanili.
In quel disastro di Pavia del 1525 cade il fiore dei grandi di Francia, tra cui quel Jacques de La Palice divenuto per epitaffio proverbiale definizione del tautologico ovvio. Dramma per i moderni, gioco per quei cavalieri mirabilmente adornati di acciaio mortale alla carica sui loro splendidi destrieri.
Tremenda sciagura per la modernità, il conflitto è onorevole ludico per questi cavalieri che nel tardo autunno del Medioevo si scontrano con il destino caricando fanti e picchieri. Non è il coraggio a guidarli, come scrive Jean Giono nella bella edizione italiana del “Le desastre de Pavie” edita da Settecolori, ma la passione e soprattutto la noia.
Su un modello tolstojano, Giono decostruisce il mito della storia, possibile solo a posteriori, in favore di una micro-storia in grado di restituire, con gli strumenti della narrazione, il reale motore dei processi storici: gli uomini.
Se per il Tolstoj di Guerra e Pace questo significava una lettura degli eventi in cui veniva negato il ruolo dell’individualità geniale delle grande figure incarnanti lo spirito della storia, schiavi essi stessi degli avvenimenti definiti dalla necessità e dalla vita dello “sciame umano”, per Giono si definisce un processo opposto, meraviglia dell’eterogenesi dei fini.
La Storia di Giono diviene allora mirabolante affresco di ritratti individuali, un petite histoire in grado di descrivere e comprendere i caratteri personali, gli ingranaggi profondi, poiché per lo scrittore francese “la storia non è fatta né dai re, né dal popolo, essa è fatta delle passioni”. Il mestiere dello storico subisce allora, come in Tolstoj, sua suggestiva eredità, la pesante accusa di ricostruzione posticcia, forzatura dei contemporanei per mancata comprensione del passato nel suo tempo reale.

Sotto la penna di Giono, seguendo tale strada analitica, Carlo V acquisisce i contorni pennellati di un borghese fiammingo, lontano dal campo di battaglia e aperto verso una pragmatica modernità di calcolo di interessi, fondi di banchieri e denaro.
Figlio del retaggio cavalleresco che permea il trono francese, il re Francesco I assume, in controluce all’avversario imperiale, le fattezze dell’emblema cavalleresco il cui carattere primario non è ascrivibile ad un’esaltazione del coraggio ma ad uno spirito bellico da homo ludens, impegnato nella guerra così come nei divertimenti della caccia, pronto ad accettare anche la morte perché parte del grande spettacolo guerresco.
La fine dell’epopea della cavalleria francese a Pavia, seppur storicamente ricollocata dalla postfazione di Franco Cardini, poiché segna il passaggio simbolico in favore delle masse dei fanti incarnate dal quadrante svizzero dei mercenari elvetici e poi all’innovazione degli agili tercios spagnoli, si colloca, da questo punto di vista, anche come il tramonto di una visione della guerra vista come giostra ludica d’abilità.
Le guerre perdono allora progressivamente, con il venir meno del cavaliere, il sentore dello scontro al singolar tenzone, dello scintillare d’armatura su bellissime e mortali cavalcature, per divenire il regno dell’anonimo colpo di moschetto e del tiratore appiedato: “Oh gran Bontà dei cavalieri antiqui”.