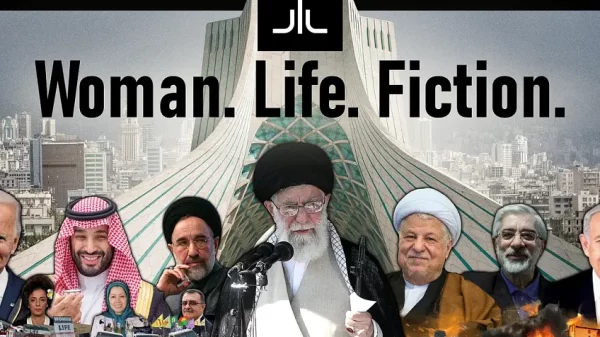Leopardi e il tempo della filosofia: il Dialogo di Timandro ed Eleandro

Leopardi è inutile. La lettura di una pagina talvolta può aiutare nella ricerca di una qualche consolazione; quella di Giacomo Leopardi non rientra in questo genere. Essa, per l’angosciato, risulta angosciante e non consolatoria, si presenta come ciò che è in grado di manifestare il nucleo di quell’angoscia, ma non di toglierlo. Per questo essa nega qualsiasi dimensione consolatoria e, in virtù di ciò, risulta come ciò che più radicalmente è inutile.
Nel Dialogo di Timandro ed Eleandro, una delle Operette morali, Leopardi afferma: «Cavinsi le maschere, si rimangano coi loro vestiti; non faranno minori effetti di prima, e staranno più a loro agio». Questo dialogo rappresenta in maniera piuttosto evidente il tentativo estremo di giustificare le posizione filosofiche leopardiane e di rispondere anticipatamente alle possibili critiche. Esso, tuttavia, va ben oltre quelli che a tutta prima potrebbero essere gli obiettivi dell’autore: esso, infatti, finisce per mostrare una volta ancora e in modo definitivo il pensiero fondamentale di Leopardi, benché molta critica – De Sanctis, ma anche Fubini – spesso abbia tentato di mettere in risalto più i punti di debolezza che quelli di forza del testo. Si tratta di un dialogo non lunghissimo che, nel suo andamento, richiama quel modo di indagare che, in ultima istanza, ha come sua matrice il dialeghestai socratico-platonico. La potenza del punto a cui Leopardi perviene nel testo è ciò che più colpisce ed è anche ciò che, in qualche modo, lo rende attuale, in grado di parlare non a tutti ovviamente, ma al lettore – diciamo così – angosciato.
L’essenza rattristante del filosofare e il ridere del vero
Dopo una prima parte abbastanza rapida, in cui Eleandro, alter-ego dello stesso Leopardi, tenta di liberarsi dalle accuse rivolte al suo modo di scrivere e parlare dall’interlocutore Timandro, si giunge alla parte decisiva del testo: Timandro chiede a Eleandro quali siano i motivi profondi del suo scrivere. A questa domanda, che Leopardi-Eleandro percepisce come decisiva, segue una risposta molto articolata ed estremamente profonda. I motivi sono presto detti tramite le parole stesse di Leopardi: l’intolleranza di ogni simulazione e dissimulazione e il dolersi del fato.
Queste motivazioni, che sono corrosive rispetto alla sua contemporaneità, ma che ancora oggi risultano tali, riposano su un fondamento, che è alla base della riflessione filosofica del recanatese e che ben è stato messo alla luce nei suoi studi proprio su Leopardi da Emanuele Severino. In una lettera al Giordani del 6 marzo 1820, Leopardi scrive: «Queste considerazioni io vorrei che facessero arrossire quei poveri filosofastri che si consolano dello smisurato accrescimento della ragione, e pensano che la felicità umana sia riposta nella cognizione del vero, quando non c’è altro vero che il nulla […]».
Non è importante tanto dove vada a parare il discorso che qui Leopardi sta affrontando, quanto recuperare quel tanto – tantissimo – che esso in sé racchiude: Leopardi mette a tema la coincidenza tra vero e nulla, quella che con Severino si potrebbe chiamare l’essenza della Follia. Il fondamento, ossia la verità ultima, è la vanità del tutto. Si tratta di un fondamento che rompe e che si rompe, quindi più propriamente di uno sfondamento, che ha come determinazione manifesta proprio quell’atteggiamento leopardiano corrosivo che mal tollera “certi enti razionali o fantastici”, di cui la sua (come la nostra) contemporaneità è costellata.
A questo proposito Leopardi, che anticipa Nietzsche e parte della letteratura italiana del Novecento, pone anche il tema della maschera, l’orpello dietro il quale ci si traveste per evitare il vero e con tono esortativo si pronuncia dicendo «cavinsi le maschere, si rimangano coi loro vestiti; non faranno minori effetti di prima, e staranno più a loro agio». Cosa significa in questo passaggio che staranno a loro agio? Pirandello molto dirà proprio di colui che si priva della maschera: l’agio di chi è sempre a un passo dalla realizzazione è forse nient’altro che un disagio, ma queste, forse, sono solo divagazioni di chi ancora non si è arreso alla dura, triste, misera e fredda verità leopardiana e ancora cerca la felicità. Il disagio dell’uomo moderno, da questo punto di vista, non sarebbe che il prodotto di un irrealizzabile desiderio di felicità; irrealizzabilità che, però, è intrinsecamente umana.
Rispetto a questa condizione, certo non lieta per l’uomo, Leopardi mette a tema anche un modo specifico di “dolermi del fato“, che è quello stranissimo del riso: «Ridendo dei nostri mali, trovo qualche conforto». Il riso non è che l’espressione estrema della noncuranza di colui che non perde il coraggio di combattere la necessità: si può morire sperando, si può morire illudendosi, si può morire combattendo.
La dannosissima filosofia e la sua inutilità
Chi porta alla luce queste verità? Chi indaga le cause delle infelicità dell’uomo? La risposta è presto detta, se si pensa in uno stesso tempo alle nozioni di verità, di causa, di infelicità e di uomo. È la filosofia. Essa mostra le verità che sono la sostanza del mondo, la legge che governa il mondo. Eleandro dice che la filosofia è dannosissima: colui che filosofa impara a proprie spese quelle verità profonde che governano il mondo. A proprie spese significa che, a meno di impazzire, egli non sarà più in grado di liberarsi di quelle verità conosciute. Il filosofare è l’abito che, una volta fatto proprio, è inscindibile da chi se ne appropria. Da lontano si intravede quel filosofo folle, che proprio di Leopardi avrà grande stima.
Eleandro rileva come proprio nel momento in cui la filosofia si approssima più di altre epoche al vero, essa si scopre contemporaneamente inerme, quando non inutile. Si tratta di un’inutilità diversa rispetto a quella aristotelica: nello Stagirita, proprio il fatto di essere inutile poneva la filosofia come più elevata rispetto alle altre scienze necessarie al sostentamento umano, qui l’inutilità è radicale e rende la filosofia nella condizione di aver necessità di un rimedio, da che essa si poneva come rimedio.
Cosa resta? Il legame col vero, un legame debole e contraddittorio di chi vive nella condizione antinomica e, forse, tragica di sapere dell’inutilità di ciò che vive filosofando, ma di cui non può fare a meno. Il presente è, quindi, il tempo tragico par excellence, quello in cui il vero si fa più prossimo e in cui, forse, non sarà più possibile sperare o illudersi, ma dolersi del fato, fare i conti con la necessità vivendo e ridendo. Lo abbiamo vissuto e lo stiamo vivendo: è il tempo della filosofia.