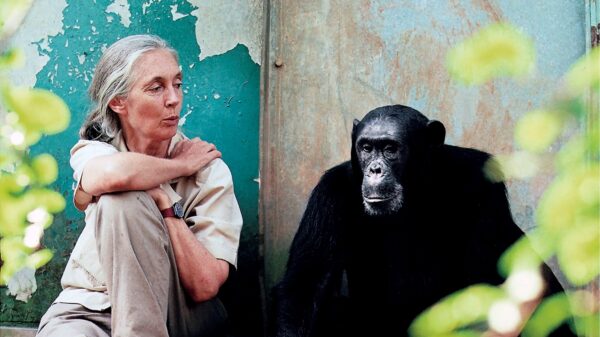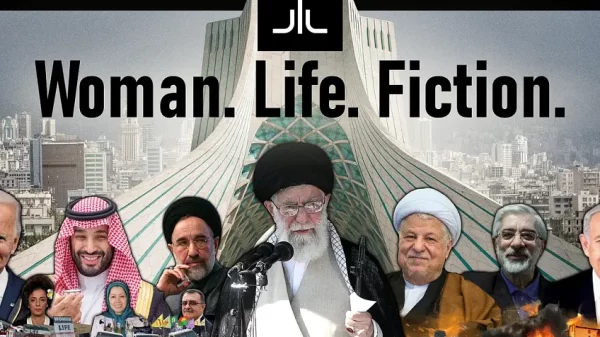Bonus-Malus: il latino in tasca alla portata di tutti

Bonus-Malus. Il latino degli italiani nasce da un’idea di Raffaele Giomini e Pasquale Cosi concretizzatasi nel 2004 quando il volume ha visto la luce per la prima volta, editato dalla Società Editrice Dante Alighieri, ma è costantemente ristampato poiché grazie a suggerimenti volontari si arricchisce di nuove espressioni.
Disponibile anche in formato Kindle per gli amanti del digitale è un testo suggerito agli adolescenti, ma adatto a tutte le età, che svela come il latino non sia affatto una lingua morta, ma presente nel nostro quotidiano molto più di ciò che si possa immaginare.

Il latino nel lessico quotidiano
L’editio maior comprende più di mille espressioni attualmente in uso nella lingua italiana, raccolte scrupolosamente dai due autori Raffaele Giomini e Pasquale Cosi, professori e autori di diversi libri, che per l’occasione si sono avvalsi della collaborazione della Società Editrice Dante Alighieri, nel settore dell’editoria scolastica da oltre un secolo.
Alla base di questo fortunato testo vi è un evento catastrofico, ovvero l’incidente automobilistico di uno dei due autori, che lo portò alla scoperta del sistema bonus-malus con il quale era assicurato, e che gli fornì il pretesto per “ripensare” alla lingua latina con maggiore attenzione.
Bonus-Malus è infatti una formula messa in circolazione nel 1976 dalle società di assicurazione automobilistica contro gli infortuni. Tali società classificano tramite i due aggettivi latini il guidatore che non provoca incidenti (dunque «buono» per l’assicurazione, che non deve pagare per lui somme di risarcimento) e quello che invece li provoca (definito «cattivo» per l’assicurazione perché costretta a pagare per lui somme di risarcimento dei danni che egli ha provocato).
Questo esempio è chiarificatore della portata del latino, lingua dei padri prima in assoluto a godere di un’aura internazionale, che permea tuttora non solo il linguaggio giuridico ed ecclesiastico ma anche quello quotidiano. Tutti noi usiamo modi di dire, motti, sentenze ed aforismi di origine latina; il nostro modo di pensare e di parlare affonda le radici in questa lingua che appartiene intrinsecamente al nostro passato, presente e futuro.

Cinque significative espressioni latine
Di seguito alcuni esempi pratici estratti dal testo:
Ab ovo (usque ad mala): «dall’uovo (fino alle mele)». Il banchetto dei Romani si apriva con le uova servite come antipasto e si chiudeva con la frutta. Cominciare ab ovo significa impostare un ragionamento, una discussione o una qualsiasi altra cosa proprio dal suo effettivo inizio.
Ad ungeum: «a (prova d’) unghia»; si dice di una cosa riuscita a perfezione o di una persona veramente impeccabile. L’espressione appartiene al linguaggio tecnico degli antichi lavoratori del marmo che ritenevano perfetta una superficie solo quando, passandovi sopra l’unghia di un dito, non vi percepivano alcuna scabrosità.
Factum infectum fieri non potest: «ciò che è accaduto non può diventare non accaduto»; espressione, tratta dalle commedie di Plauto e passata nel linguaggio giuridico, attestante la realtà non negabile né modificabile di un fatto ormai verificatosi.
Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini: «quel che non fecero i barbari, hanno fatto i Barberini»; allusione alla nobile e potente famiglia romana che costruì i suoi palazzi demolendo talvolta antichi edifici e prendendo da essi le pietre necessarie per quelli nuovi. Si dice ancora di chi demolisce qualche cosa di ben fatto per metter su qualcosa di meno valido.
Similia similibus curantur: «le cose (le malattie) simili si curano con rimedi che assomigliano ad esse». L’apoftegma medico può ben dirsi l’insegna della medicina chiamata omeopatica perché cura i mali con medicamenti che assomigliano ad essi. Omeopatia infatti deriva dal greco hómoios-simile, e dalla radice path– del verbo pascho-io soffro; significa dunque: “che cura mediante sostanze che provocano sintomi uguali a quelli prodotti dalla malattia che si vuole curare”.