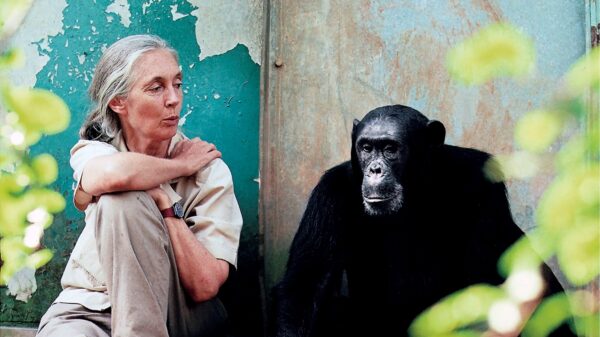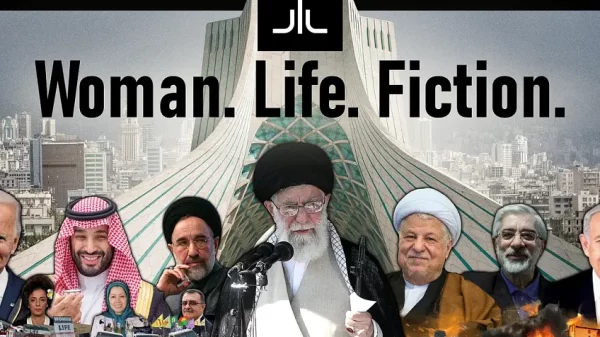Movimento neo-borbonico: un curioso caso dal web

Ultimamente in rete, analogamente a quanto accade per altre teorie prive di fondamento scientifico, ma che godono di grande seguito popolare, come le campagne no vax o lo strano fenomeno dei terrapiattisti, si sta diffondendo il movimento dei cosiddetti neo-borbonici.
Il caso dei neo-borbonici
In poche parole, vi è chi sostiene che il Mezzogiorno, che prima dell’Unità d’Italia godeva di un sostanziale stato di florida prosperità economica e culturale, sia stato condannato alla miseria proprio a causa del passaggio dalla casata dei Borbone a quella dei Savoia. Pare che essi, infatti, non si impegnarono tanto in una guerra per unificare l’Italia, quanto per annettere il resto della penisola al Piemonte.
Sia chiaro, delle cose vere in questa versione ci sono, ma come in tutte le teorie sensazionalistiche è la loro connessione e la ricostruzione generale a fare acqua da più parti.
Breve analisi delle tesi dei neo-borbonici: Garibaldi e i Mille
Quando Garibaldi scese nel Mezzogiorno si trovò di fronte a uno Stato praticamente collassato. I Borboni erano ormai decaduti e non c’era più nulla di quella fiorente civiltà che aveva contraddistinto le regioni meridionali nei cinquant’anni precedenti, a partire dalla fine del dominio napoleonico. Questo è un aspetto molto semplice da comprendere. Garibaldi non avrebbe mai potuto soppiantare un esercito organizzato con i suoi Mille, qualcosa di realmente molto simile all’Armata Brancaleone di monticelliana memoria.
I detrattori dell’Unità d’Italia menzionano altresì spesso le malefatte commesse da Garibaldi durante la sua permanenza in Sicilia e nel Sud in generale. C’è sicuramente molto di vero. Delitti vergognosi commessi dai Mille ce ne sono stati. Basti pensare ai Fatti di Bronte, di cui si macchiò in particolare Nino Bixio, luogotenente dell’eroe dei due mondi soprannominato da alcuni, per l’appunto, “il macellaio”. Si potrebbe fare un discorso analogo con la Resistenza. Sono ravvisabili casi di partigiani responsabili di crimini ed efferatezze, come gli episodi noti delle marocchinate o il Triangolo della morte. Questi eventi, però, per quanto deplorevoli, non sminuiscono il valore complessivo della lotta partigiana. Per giunta non è vero che, come dicono i neo-borbonici, la storiografia ufficiale li abbia occultati. Il Verga, ad esempio, ne parla ampiamente pur restando da generazioni parte integrante dei programmi ministeriali di tutte le scuole superiori.
Breve analisi delle tesi dei neo-borbonici: l’economia del Sud Italia
Altro argomento caro ai neo-borbonici è quello per cui l’economia del Sud Italia sotto la casata spagnola sarebbe stata molto ricca. Non è così. L’economia agricola del Mezzogiorno a metà ‘800 era ridotta a latifondo e mezzadria. Non esistevano nemmeno i presupposti di un’economia industriale, che in Italia arriverà soltanto alla fine dell’Ottocento con il triangolo industriale To-Mi-Ge e soprattutto con il Piano Marshall nel Dopoguerra.
Ancora i neo-borbonici sono soliti ricordare avvenimenti isolati e poco densi di significato come la circostanza per cui a Napoli è stata fabbricata la prima nave a vapore. Verissimo, ma questo dato non indica certo che a Napoli fosse ravvisabile una produzione industriale su larga scala.
Arriviamo quindi al tema forse più utilizzato dai neo-borbonici, ovvero la leggendaria Napoli-Portici, la prima ferrovia italiana. Se si va ad approfondire, questa fila di 7 chilometri di binari era praticamente a uso privato della famiglia reale!
La ricchezza dei Borboni insomma era molta, ma come quella di tutte le famiglie reali in trasferta assolutamente mal distribuita nella società. C’erano pochi ricchissimi e una massa di disperati. Un po’ come accade oggi nel Sudamerica.
I neo-borbonici, per concludere, citano spesso Gramsci, il quale è il primo a parlare di conquista più che di liberazione da parte dei Savoia. Vero, per opportuno senso di completezza, però, va aggiunto che secondo il filosofo sardo questa occupazione ha riguardato anche e soprattutto il resto del Nord Italia e in particolare Milano, che in quegli anni era economicamente già più sviluppata di Torino e, di conseguenza, più meritevole del titolo di Capitale.
Studiare la storia aiuta molto a capire il presente, ma bisogna fare attenzione a cercare la spiegazione di ciò che accade oggi in eventi di 160 anni fa.