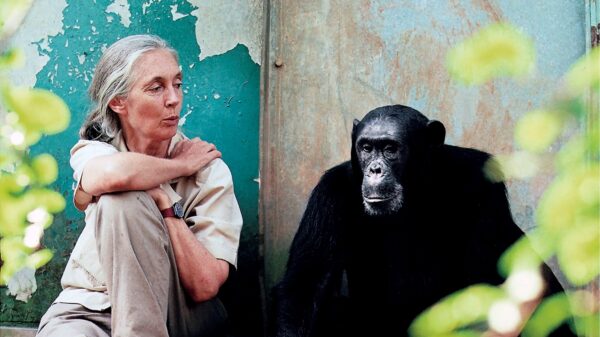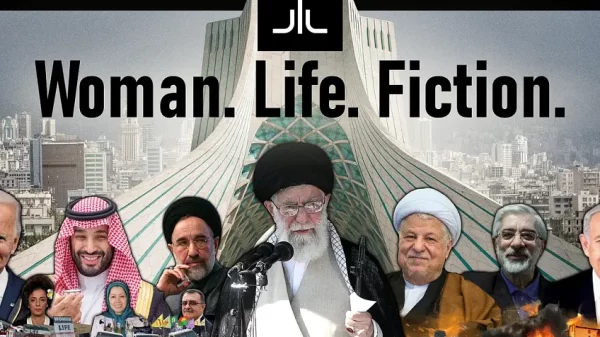Poli museali e musei civici: intervista al Professor Marco Germani

Per comprendere le vicende che sottendono alla gestione di un museo civico abbiamo intervistato il Professor Marco Germani, docente a contratto per il laboratorio “Museo e Territorio: Documentazione e Valorizzazione di disiecta membra” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e direttore del e del Museo Civico Archeologico di Castro dei Volsci, due esempi di musei dipendenti dall’amministrazione comunale situati in due piccoli centri abitati della provincia di Frosinone. Ci faremo illustrare da lui cosa, come e perché vivono poli museali e musei civici.
Veronica Budini: Nella visione generale si crede che tutti i musei esistenti siano sotto la gestione statale. In realtà non è così: esistono dei musei che vengono gestiti dallo Stato e altri dagli Enti locali. Lei è il direttore di due musei: il museo di Aquino e quello di Castro dei Volsci, musei del territorio che vengono gestiti dalla comunità delle rispettive città. Quando nasce questa dicitura e che status ha nei confronti del sistema museale italiano?
Prof. Marco Germani: I Musei di Aquino e Castro dei Volsci sono due musei civici di indirizzo archeologico. In quanto tali sono gestiti dai rispettivi Comuni di appartenenza. Allo stato attuale in Italia abbiamo Musei pubblici e privati. Nel primo caso s tratta di tutte quelle strutture gestite da Enti pubblici ma all’interno di questo gruppo va fatta una differenza. I cosiddetti musei nazionali o di proprietà statale sono, infatti, quelli che, in seguito della recente creazione della Direzione Generale Musei, sono stati sottratti alle Soprintendenze e affidati ai Poli Museali Regionali. I Musei civici però non fanno parte di questo gruppo di istituti, essi restano invece legati alle Soprintendenze attraverso rapporti “indiretti”. Già il d.lgs. n. 112/1998 nell’art. 152 aveva stabilito, infatti, che la valorizzazione è materia di gestione degli enti locali che va però attuata in collaborazione con lo Stato.
VB: Quando lei dice Polo cosa intende?
MG: Per polo si intende un aggregazione di più istituti che condividono una stessa realtà amministrativa, territoriale o culturale. A seguito della riforma Franceschini i musei nazionali italiani sono stati inseriti nei Poli Museali Regionali. Anche i musei civici, tuttavia, stanno tentando sempre più spesso la via aggregativa come soluzione alla mancanza delle risorse economiche utili al loro sostentamento e come risposta alla crescente volontà di semplificazione della gestione degli stessi. La provincia di Frosinone, ad esempio, in cui insistono i due musei da me diretti, sta tentando di costituire un sistema integrato di istituti culturali aggregando tra di loro musei, archivi storici e biblioteche presenti all’interno del territorio provinciale. In realtà i musei civici del Lazio avevano già trovato una forma di aggregazione e condivisione in alcuni sistemi museali tematici come il PROUST ma soprattutto nell’OMR (Organizzazione Museale Regionale). L’OMR è stata istituita dalla Regione Lazio nel 1997 con la L.R. 42. Essa raccoglie musei di diverso tipo sia dal punto di vista delle collezioni che custodiscono sia dal punto di vista della loro natura giuridica.
VB: Che rapporto corre tra i musei civici e il MIBAC? Questi musei non dipendono direttamente dalla Soprintendenza.
MG: Come ho già spiegato, mentre la tutela è assegnata al Ministero la valorizzazione è azione compiuta dagli Enti locali in accordo con le Soprintendenze competenti. L’art. 117 Cost., a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, ha diviso la materia dei beni culturali in due ulteriori submaterie, cioè “tutela” e “valorizzazione”, che appartengono, rispettivamente, alla legislazione esclusiva dello Stato e alla legislazione concorrente delle Regioni. Sono, invece, materie di legislazione concorrente (divise cioè fra Stato e Regioni) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l’organizzazione delle diverse attività culturali. Attraverso una stretta collaborazione con gli organi periferici del MIBAC e, in particolare, con i funzionari di zona, si attua un programma condiviso di valorizzazione dei beni presenti nelle strutture museali civiche ma si collabora spesso su azioni di tutela del patrimonio del territorio.
VB: Un museo ha una “missione”, come suggeriscono gli standard dell’ICOM che, grazie alla riforma Franceschini, sono finalmente diventati un punto di riferimento per l’amministrazione museale italiana. Un museo come quello di Aquino che tipo di “missione” ha?
MG: Il Codice etico dell’ICOM rappresenta un insieme di standard minimi di recente condiviso dal MIBAC. Nel 2001, infatti, è stata formalizzata, attraverso l’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei del MIBAC, una lista in cui figurano otto ambiti di azione entro i quali sono stati individuati gli standard minimi da raggiungere. Rispetto a quelli dati dall’ICOM è stato aggiunto un punto fondamentale che riguarda i rapporti del museo con il territorio. Per quanto riguarda i musei da me diretti, oltre alla naturale e nomale finalità che ogni museo dovrebbe perseguire nella costante ricerca della valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e paesaggistico, con particolare riguardo all’accessibilità per la comunità, ho cercato sempre di proporre il museo come l’Ente capace di spingere e di riattivare le politiche culturali dell’area. I musei se da strutture chiuse in se stesse riescono ad aprirsi alla comunità e al territorio che li accoglie possono realmente svolgere un servizio per l’area in cui essi operano. La programmazione di un calendario di attività variegato e serrato fa sì che questi luoghi non diventino un contenitore in cui le persone transitano una volta soltanto senza più farvi ritorno. Un museo non deve mai risultare statico agli occhi della comunità locale perché nel momento in cui la sua vitalità si arresta la collettività non si interesserà più alla struttura e non avrà a cuore la vita di questa; Quando e se questo si realizza la macchina amministrativa ha fallito.
VB: Si parla di standard dell’ICOM. Come vengono declinati all’interno della politica gestionale di musei come quello di Aquino e quello di Castro?
MG: Nei musei di Aquino e Castro stiamo tentando, sebbene nella ristrettezza economica in cui si opera ormai da anni nel settore, di trasformare l’esperienza di visita all’interno dei musei in qualcosa di estremamente piacevole. Intanto la semplificazione degli apparati comunicativi che spesso risultano, soprattutto nei musei di vecchia progettazione, molto datati sia a livello della comunicazione scritta sia per quanto riguarda le immagini e le ricostruzioni funzionali ad una migliore comprensione della materia. Se il visitatore entrando in un museo non riesce, ad esempio, a muoversi in maniera consapevole nello spazio, discernendo rapidamente percorsi, cronologie, rapporti tra luoghi ed oggetti, tra usi e reperti, può avvertire un senso di disagio che difficilmente lo porterà a vivere un’esperienza positiva e che probabilmente lo allontanerà dal mondo dei musei. Il visitatore va preso per mano anche laddove il personale non può accompagnare direttamente il turista; oggi la tecnologia ci può aiutare molto in questo senso, ciò che fino a qualche anno fa era affidato solo alla forza delle parole oggi può essere supportato dall’ausilio tecnologico del digitale ma anche, più semplicemente, da ricostruzioni e immagini che semplificano i concetti e i testi. L’accessibilità alla struttura e ai suoi contenuti è fondamentale. Per Aquino, ad esempio, all’interno del vecchio museo, divenuto una sorta di camera delle meraviglie in cui il turista appariva spaesato e maltrattato da un percorso espositivo confusionario e privo di un criterio comprensibile, nel 2014 è stata apportato un grosso cambiamento che ha completamente stravolto la struttura organizzando i materiali attorno ad un percorso cronologico scandito da ambienti di colore differente. Anche solo attraverso la caratterizzazione cromatica si può riuscire a parlare in maniera più efficace e immediata. In realtà, gli interventi proposti nel museo di Aquino hanno riguardato tutta la struttura e il percorso espositivo a cominciare dai pannelli e dai cartellini didattici. Anche il calendario delle diverse manifestazioni attuate dal museo ha fatto in modo di solleticare l’interesse dei diversi gruppi sociali locali riuscendo ad attirare l’attenzione di utenti fino ad allora lontani dalla struttura. Il museo non deve essere avvertito dalla comunità come luogo per élites o come struttura chiusa in se stessa, polverosa e immobile, deve essere invece avvertito come un luogo aperto capace di coinvolgere i propri utenti nella vita della struttura.
VB: In che modo si portano avanti all’interno dei movimenti generali del museo i progetti pensati dalla direzione? Quali sono gli itinera di richiesta alla Soprintendenza per poter portare avanti delle idee?
MG: L’accordo con la Soprintendenza è fondamentale, soprattutto nel momento in cui si parla di valorizzazione che prevede spostamenti di materiali o creazione di apparati relativi al supporto delle opere; in generale, le politiche di movimentazione vengono discusse con l’ispettore. I progetti, invece, partono dalla struttura stessa, sempre in accordo e condivisione delle scelte con i funzionari locali della Soprintendenza. Per le spese, in genere, per quanto attiene ai musei civici, questi progetti di valorizzazione possono essere realizzati o con fondi provenienti da bandi pubblici o con somme destinate dagli assessorati locali o con azioni di fundraising operate tra le aziende che insistono sul territorio. In molti casi, devo confessarle che ci si affida anche al volontariato o all’opera gratuita di esperti nei diversi campi dei servizi necessari per la realizzazione del progetto. Ad Aquino, ad esempio, la comunità locale ha risposto in maniera entusiasta all’invito rivolto dal museo a collaborare in occasione della risistemazione del museo. Ciascuno a proprio modo ha messo a disposizione quello che poteva o sapeva fare. Ad oggi per il museo di Aquino è stato approvato dall’amministrazione comunale un progetto di ampliamento che prevede la triplicazione della superficie disponibile del museo; il progetto è stato preparato da architetti e ingegneri che hanno lavorato in simbiosi sotto la nostra egida. Adesso stiamo tentando di trovare i finanziamenti per la realizzazione dell’opera. L’esperienza mi ha insegnato che bisogna sempre essere pronti ed avere in mano la carta da giocare nel momento in cui, all’improvviso, si presenta un’occasione inaspettata.
VB: Ha delle idee che sente necessarie sia attuabili che poco attuabili?
MG: Di cose da fare per dei musei così ce ne sarebbero tante… I piani di interesse sono tantissimi, a partire dagli allestimenti interni che avrebbero bisogno di un ammodernamento. Ad Aquino ad esempio, abbiamo degli espositori un po’ datati che non valorizzano appieno i reperti. Un’altra cosa, forse più attuabile, è portare la tecnologia all’interno del museo. Siamo ad un livello comunicativo ancora legato al cartaceo, al pannello didattico di stampo classico in forex attaccato alla parete oppure al cartellino didattico posto accanto all’opera. Purtroppo, però, l’ingresso del digitale ha dei costi ancora un po’ elevati. Oggi, però, per un museo archeologico le tecnologie sono fondamentali poiché sono in grado di offrire una modalità differente di fruizione capace di comunicare in maniera più rapida ed incisiva con l’utente. Il progetto che spero tanto di poter realizzare è sicuramente quello dell’ampliamento del museo di Aquino. Ci sono, tuttavia, altri obiettivi che mi interessa continuare a perseguire; in questi anni sono riuscito a riportare ad Aquino molti reperti archeologici conservati in altri Musei statali o in collezioni private, convinto del fatto che i materiali vadano esposti e conservati nel territorio in cui essi sono stati prodotti. Con il museo di Castro dei Volsci la sfida è solo all’inizio. Castro dei Volsci ha una delle aree archeologiche più interessanti del Frusinate con una villa romana con un apparato musivo veramente di alto livello. Il Museo dopo molti anni di chiusura si prepara alla riapertura e stiamo lavorando strenuamente affinché possa riassumere quell’importanza e centralità che merita grazie al patrimonio in esso conservato.
VB: Secondo me il lavoro e la manodopera di cui c’è bisogno potrebbe essere svolto attraverso laboratori universitari di Tor Vergata o della Sapienza o di Roma Tre. Se ci dovesse essere la possibilità di far partecipare nei progetti le Università lei ne usufruirebbe?
MG: Certo, soprattutto con l’interdisciplinarietà del sistema che si è creato tra le varie facoltà. Per esempio lo scorso anno abbiamo lavorato ad un progetto di diagnostica per i beni culturali che prevedeva il lavoro congiunto tra la Facoltà di Lettere e quella di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata. Con questa collaborazione il museo di Aquino ha avuto la possibilità di realizzare gratuitamente degli esami diagnostici non invasivi che, diversamente, sarebbe stato impossibile realizzare. Anche con l’Università di Cassino esiste una buona collaborazione. Nel 2015, ad esempio, la Facoltà di Ingegneria assieme alla Facoltà di Lettere di Cluj Napoca (Romania) e all’Accademia di Romania di Roma è stata al nostro fianco nella campagna di scavo archeologico realizzato nel sito di Aquinum. Le collaborazioni sono linfa vitale per i nostri istituti.
VB: Per raggiungere Aquino si prende comodamente un treno dalla stazione Termini. Il problema sorge quando si deve andare dalla stazione di Aquino al Museo. Credo comunque ci siano molte persone che partirebbero per visitare quest’area quindi mi chiedo: esistono dei modi per implementare questo collegamento?
MG: Ci sono degli autobus che svolgono il servizio di collegamento con la città ma non sono così frequenti. Abbiamo tentato di chiedere alle aziende di trasporto locali di aumentare il servizio, ma poichè non c’è un’utenza fissa che faccia questo spostamento dalla stazione al museo o al centro città ci rispondono che per l’azienda non è vantaggioso. Mi rendo conto che questo è un problema. Va però detto che Aquino con il suo museo, i suoi monumenti e la sua area archeologica si trovano vicinissimi al casello autostradale dell’Autostrada del Sole. Questo costituisce sicuramente un punto di forza per la città.
VB: Nel 2014 in occasione della Riforma Franceschini e soprattutto della delicata situazione instauratasi in quel periodo, la fruizione dei musei è stata definita dal parlamento “servizio pubblico essenziale”. Cosa pensa lei di questa affermazione? Quanti passi avanti sono stati fatti nella gestione generale dei musei italiani dal 2014 ad oggi?
MG: Lo sciopero è un diritto sacro, detto ciò va anche aggiunto che l’Italia con il flusso turistico che deve gestire dovrebbe far in modo che certe situazioni di disagio non debbano mai essere arrecate ai visitatori. Le dico, però, che avendo viaggiato abbastanza, certe volte si tende ad idealizzare un po’ troppo quanto accade all’estero in materia di gestione museale. Ricordo, ad esempio, che, per problemi di natura nettamente inferiore e certamente meno importanti di quelli verificatisi in Italia nel 2015 che nell’estate del 2016 arrivato davanti alla biglietteria di un importante museo nazionale svedese non sono riuscito ad entrare ed acquistare il biglietto per l’incompetenza del personale incapace di gestire un problema di emissione tickets.
VB: Servizio pubblico essenziale” invece è una definizione molto forte.
MG: L’affermazione è da situare in un momento in cui la gestione del patrimonio italiano si trovava in grave crisi: a Pompei c’erano delle situazioni fatiscenti con crolli giornalieri e anche nel Colosseo c’erano problemi, quindi, forse, in quel momento è stata giustificata dalla situazione. Il settore dei Beni Culturali italiani è un mondo fatto di personale altamente specializzato ma anche fortemente sottopagato. Quando finalmente si comprenderà che queste persone mandano avanti una macchina ben più complessa di quella del singolo museo o della singola area archeologica, in grado cioè di fungere da organo propulsore per l’intera economia di un paese allora forse potranno cambiare molte cose compresa la possibilità di cancellare quell’essenziale dal concetto di fruizione del patrimonio pubblico.
VB: C’è un modo per dare una sferzata alla situazione attuale? Io consiglierei l’educazione.
MG: Decisamente l’educazione al patrimoni. Questo è un paese in cui l’ignoranza nei confronti del patrimonio porta una mano criminale ad imbrattare la cattedrale di Trani o altri monumenti, quasi come se il loro valore storico e artistico non avesse alcun conto. Il percorso di formazione al rispetto del patrimonio inizia dalla conoscenza. La scuola, in primis, ha l’obbligo di forma e di diffondere il rispetto nei confronti del patrimonio. L’idea di cancellare la Storia dell’Arte dalle materie scolastiche è una cosa terribile. Tutti i paesi dovrebbero dedicare più tempo nell’arco della formazione scolastica alla conoscenza del patrimonio.