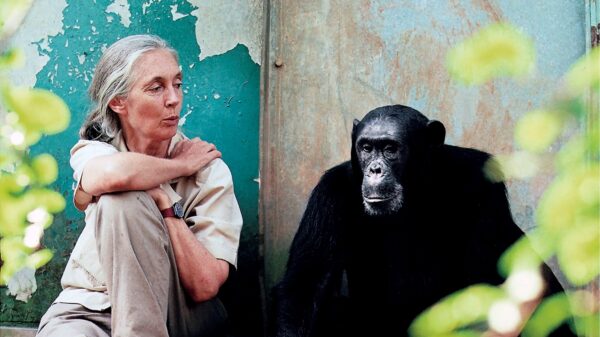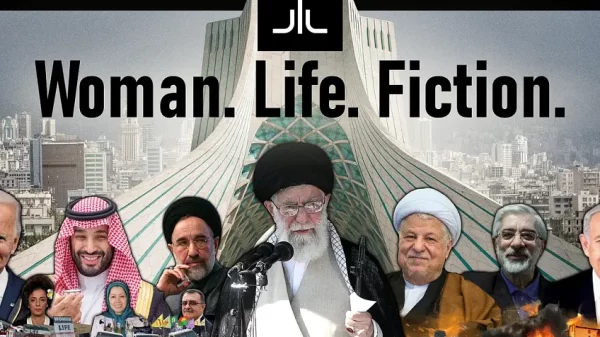La Magnifica Fabbrica: La Scala tra araba fenice e camaleonte

La Magnifica Fabbrica è la mostra dedicata ai 240 anni di trasformazioni architettoniche del Teatro La Scala di Milano. Sostenuta da Intesa Sanpaolo e progettata da Italo Lupi, Ico Migliore e Mara Servetto, è a cura di Fulvio Irace e Pierluigi Panza.
Dal 4 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, al piano superiore del Museo Teatrale della Scala, è possibile vedere l’evoluzione storica della struttura architettonica del Teatro sino al dopoguerra. Il percorso cronologico parte dal 1776 ed arriva alla ricostruzione del dopoguerra, per continuare poi nel Ridotto dei Palchi.
Qui infatti c’è la sezione dedicata agli interventi recenti, tra il 2002 e il 2004, firmati dall’architetto Botta e all’ampliamento del suo progetto con la costruzione di una nuova torre. Essa è prevista per il 2022 e arricchirà il profilo del Teatro di Via Verdi.
Sempre nel Ridotto, è esposta la splendida maquette in legno pregiato, realizzata da Ivan Kunz che riproduce con straordinaria minuzia costruttiva una sezione dell’edificio in scala 1:75. Grazie ad essa si può, con un po’ di immaginazione, entrare all’interno della struttura esplorandone da diversi punti di vista, le trasformazioni architettoniche e funzionali.
Le Gallerie d’Italia poi, sede museale di Intesa Sanpaolo, ospitano fuori dall’edificio della Scala, la maquette del progetto di Botta insieme a due pannelli esplicativi.
Percorso espositivo
La Magnifica Fabbrica è una narrazione su più piani: non solo della Scala, ma del tessuto urbano che l’accoglie e della società che cambia con lo sviluppo tecnologico. E la Scala, come un camaleonte, si adatta al gusto del tempo ed impiega le sue trasformazioni tecnologiche.
É un omaggio quindi anche alla città di Milano e alla sua borghesia illuminata che la vuole ricostruire a proprie spese in cambio della proprietà dei palchi, dopo che l’incendio del 1776 ha distrutto il Regio Ducal Teatro.
Perchè, come ricorda l’architetto Botta, un buon progetto architettonico, ha sempre una buona committenza. E La Scala l’ha sempre avuta: prima nella borghesia e nobiltà meneghina, da diversi anni nell’amministrazione comunale, che mantiene ed accresce questo patrimonio della collettività, carico di memoria.
Dopo Piermarini, è Sanquirico che tra il 1821 e il 1830 rinnova dall’interno il teatro, sostituendo anche alle candele le lampade ad olio. Nel 1883 grazie ad Edison, entra la luce elettrica. E pochi anni più tardi, Paganini decreta la fine del teatro salotto, imponendo buio e silenzio durante la messinscena. Proverbiale resta il divieto dei bis (Paganini non ripete) e quello di entrare ad opera iniziata.
Secchi, ingegnere capo nominato nel 1932, realizza la trasformazione stile Nuovo Impero.
Poi la guerra. I bombardamenti dell’agosto 1943 distruggono parte della Scala che però, come l’araba fenice nuovamente risorge, simbolo di cultura contro le barbarie. E sarà Toscanini, tornato dall’America, a dirigere il concerto inaugurale l’11 maggio del 1946.
Nel Ridotto è visibile l’intervento sulla facciata realizzato dall’architetto Botta tra tra il 2002 e il 2004 e quello “di domani” che prevede una nuova torre sulla via laterale della Scala, via Verdi.
Il catalogo di La Magnifica Fabbrica è realizzato dal partner editoriale Treccani.
Museo Teatrale alla Scala
Largo Antonio Ghiringhelli 1, Milano