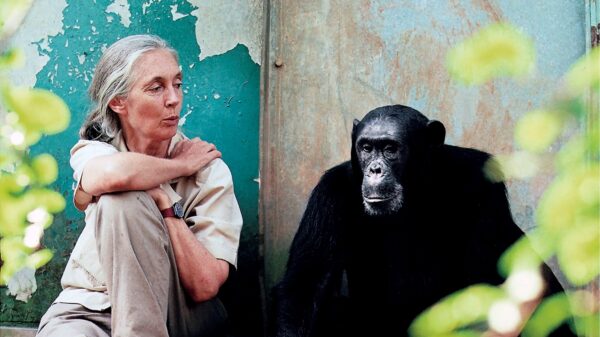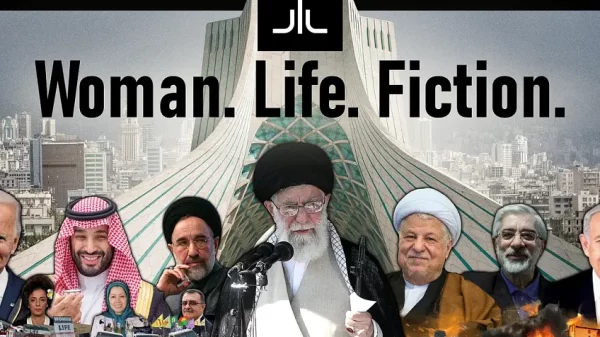Genova, Palazzo Imperiale: il sistema dei Rolli

8 novembre 1576. Il Senato della Repubblica di Genova approva un decreto con il quale viene data visibilità alle famiglie più illustri grazie all’onore/onere di farsi carico di alloggiare nei propri palazzi ospiti illustri qualora se ne presentasse la necessità. Nonostante le ovvie opposizioni a questa ospitalità imposta, peraltro un ottimo sistema per esercitare i commerci, i Palazzi dei Rolli, cosi venivano chiamati dal nome degli elenchi redatti all’uopo, dovevano apparire come simbolo manifesto dello splendore della città.
Esistono pagine su pagine che magnificano la bellezza degli edifici dei signori genovesi. Ennio Poleggi, il maggior studioso del sistema dei Rolli, lo definì una “reggia repubblicana”: una sorte di grande corte diffusa, molto sontuosa, nonostante le contraddizioni e le opposizioni. I genovesi si impegnarono così comunque ad offrire agli ospiti un’immagine di splendore simile a quella delle monarchie assolute del Seicento. Questa “destinazione d’uso” toccò anche a Palazzo Imperiale, perché era davvero notevole se pur realizzato quasi vent’anni prima del suddetto decreto.
Vincenzo Imperiale nel 1560 aveva dato incarico infatti prima a Giovanni Battista Castello, il “Bergamasco”, poi ad Andrea Ansaldo di realizzare il suo palazzo nel cuore di Genova, a Piazza Campetto. Fu poi inserito nella prima lista dei Rolli di Genova con gli eredi di Vincenzo e vi rimase fino al1664. Vediamolo più da vicino che merita. Il nuovo assetto urbanistico voluto da Gio Giacomo Imperiale – eletto doge della Repubblica di Genova -, ridisegna la vista della facciata studiata da Castello per essere goduta di scorcio e di sotto in su, ora fondale della prospettiva che si gode con l’apertura della strada voluta dal Doge, Scurreria la Nuova, che collega piazza San Lorenzo a Piazza Campetto.
Il palazzo è immenso e si sviluppa su rampe di scale affacciate a logge diversamente orientate in inediti svolgimenti di spazi. “Mio nonno ha iniziato la costruzione, mio padre l’ha terminata, io l’ho riempito per fare otium”, nel senso originario del termine. Rubens però che “censì” il tripudio urbanistico della Superba, lo ignorò. Il palazzo ebbe una vita diciamo così avventurosa ad iniziare dal bombardamento della flotta navale francese del 1684 per non dire di quello degli alleati nel 1942. Oggi l’entrata principale è preclusa da un esercizio commerciale e lo scalone è accessibile da un ingresso secondario.
Al primo piano nobile, una teoria dì affreschi di Giovanni Battista Castello, di Luca Cambiaso sulle Nozze di Psiche, mentre il secondo piano fu teatro di un celebre “duello” fra il Cambiaso e Giovanni Battista Castello sulle Storie di Cleopatra, e qui lavorò anche Domenico Piola. Fini grotteschi sono affrescati sulla scala originale e busti marmorei adornano i bei portali. Il palazzo fu suddiviso in appartamenti poi pressoché abbandonato, subì le ingiurie del tempo e fu brutalmente spogliato, ma al suo interno è ancora possibile ammirare la qualità che lo distinse. Tutto questo preambolo per dire che a maggior ragione oggi è motivo di vanto per la città il restauro e recupero del secondo piano nobile ad opera di Raoul Bollani, che gestisce a fini professionali questo spazio di cui è letteralmente innamorato. Nel 1999 iniziò a restaurare il palazzo di cui oggi tesse le lodi. Il suo sogno è stato coronato grazie alla sua tenacia. A conoscenza della storia del dipinto, lo individuò nei fondi di Palazzo Bianco, e dopo incredibili burocrazie lo restituì alla sede da cui le vicende della storia lo avevano strappato.
Il recupero di questa tela imponente raffigura la famiglia Imperiale in “villa” in uno dei suoi palazzi, quello di Sampierdarena, ma era immenso anche quello di San Fruttuoso che ora ospita un’importante biblioteca. Domenico Fiasella il titolare della commessa che fu eseguita da Giovanni Battista Casoni, uno dei suoi principali collaboratori. Sul dipinto, su una delle paraste, la data di esecuzione, 1642. Vincenzo Imperiale, uomo colto e sensibile che si dilettava di poesia, è circondato da figli e nipoti. Tre generazioni sono riunite serenamente di fronte al pittore, tutte abbigliate alla spagnola. Vincenzo è la seconda figura a partire da sinistra con la moglie, Brigida Spinola. Accanto ai tanti nipoti due maschietti nudi in basso a sinistra. Probabilmente i due figli morti infanti.
La fanciulla in rosso al centro della composizione è Maria Cristina che reca un garofano, rosso anch’esso, simbolo di promessa nuziale. Riceve la benedizione del nonno e della madre, mentre la nonna tenendo il cagnolino in braccio allude alla fedeltà coniugale. Forse il titolo potrebbe essere proprio un poema composto da Vincenzo Imperiale, letterato sensibile e colto, in cui paragona la vicenda umana a quella del divenire della natura “tal che in un tempo ha triplicato germe/ il sen fiorito del pregiato padre;/ questi nasce, questi cresce, e l’altro invecchia/ al rinverdire dell’un, l’altro rosseggia; e pargoletto un altro in fior biancheggia”. Al centro del dipinto la moglie, madre di ben 12 figli, Brigida Spinola Doria. Obbligata a vestirsi come tutte le dame di nero, se sposate, qui indossa un abito a colori, deroga consentita alle signore solo durante i soggiorni in campagna.
Questo volo radente si conclude qui, ma non la mia passione per i bei palazzi di Genova no per cui, se vi piace l’argomento, ci sarà occasione di conoscerli da vicino.