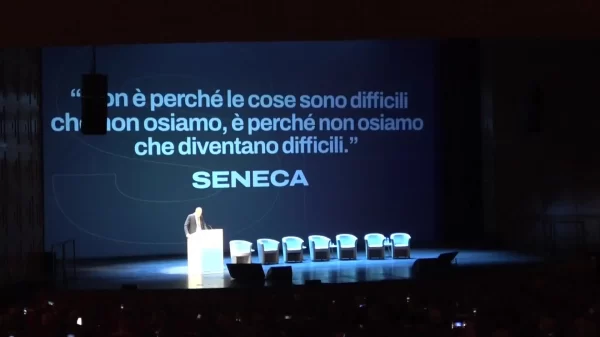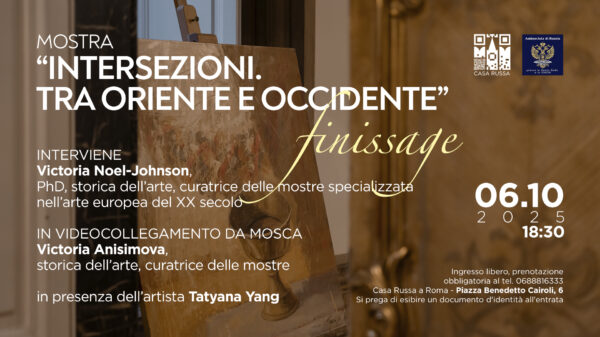Quello che le macchine non dicono
La storia dell’informatica degli ultimi decenni non è avara di esempi di prodotti che non hanno avuto successo benché chiaramente migliori rispetto ai concorrenti. I motivi sono stati diversi. L’Apple Lisa (1983) era troppo diverso rispetto a quelli del suo tempo, e il tipico utente lo considerava quasi un costosissimo gioco in confronto al molto più rudimentale IBM PC: e così quest’ultimo vinse. Alla fine degli anni ’80 il fato di XTree, forse il miglior gestore di files mai scritto, fu segnato dal declino del DOS sul quale esso funzionava. Il sistema operativo BeOS (1991) possedeva eleganza e capacità multimediali che gli utenti di Windows sognavano: ma bastò ad una certa azienda dominante dissuadère i produttori di computer ad includerlo nelle loro macchine, e il BeOS venne spazzato via (certo, quella certa azienda avrebbe poi pagato come risarcimento 23 milioni di dollari, ma nel frattempo il concorrente era stato annientato). Il sistema operativo Plan 9 (1992) era molto più avanzato rispetto al vecchio Unix: ma ormai le aziende si erano abituate a quest’ultimo e nessuno riuscì a convincerle a passare alla nuova creatura. E così via.
C’è però un caso strano che non si lascia inquadrare facilmente: un computer che rispondeva tempestivamente a necessità diffuse, che non doveva opporsi a nessuna consuetudine diversa ed era perfettamente autonomo, e contro il quale non ci fu nessuna manovra monopolistica. Era di gran lunga superiore a tutti i concorrenti, eppure dopo qualche anno glorioso dovette rassegnarsi ad uscire di scena. Si tratta dello Psion 5, commercializzato nel 1997 e dopo un paio di anni presentato in forma aggiornata con il nome di Psion 5mx (quest’ultimo a volte rimarchiato come Ericsson MC218). Apparteneva alla categoria, oggi estinta, dei «palmari»: nati come agende elettroniche, un po’ alla volta avevano assunto la fisionomia di computer tuttofare in miniatura. Di questa storia proprio la Psion, un’azienda britannica, era stata protagonista: i suoi ingegneri avevano concepito nel 1984 la prima agenda elettronica, e miglioramento dopo miglioramento erano giunti a progettare un computer poco più grande di un astuccio di occhiali e pesante 350 grammi, che una volta aperto metteva in mostra a sorpresa uno schermo tattile retroilluminato in bianco e nero (paragonabile a quello degli odierni lettori di libri elettronici) e soprattutto un’eccellente tastiera: malgrado le dimensioni, essa permetteva di scrivere quasi con dieci dita ed era il punto di forza del piccolo apparecchio.
Con un po’ d’enfasi, qualcuno ha definito lo Psion 5 l’«ultimo computer» mai progettato. C’è del vero: in un paio di anni una piccola squadra di ingegneri aveva pensato da zero la forma fisica del computer, il processore, il sistema operativo (chiamato EPOC32), l’interfaccia grafica, tutti i programmi applicativi (scrittura, foglio di calcolo, agenda, database, calcolatrice, disegno, poco dopo le applicazioni per la posta elettronica e la navigazione nella rete) e addirittura un nuovo linguaggio di programmazione (chiamato OPL). Ogni cosa era cesellata per adattarsi perfettamente alle altre.
Il risultato finale? Visto a distanza di più di quindici anni, si può definire miracoloso. Mentre con Windows bisognava imparare anzitutto la mitica combinazione Ctrl-Alt-Canc per resettare la macchina (a volte più volte al giorno), lo Psion 5 restava permanentemente acceso (veniva chiamato spegnimento ciò che in realtà era una «sospensione»), e dunque lo si ritrovava sempre immediatamente nello stato in cui lo si era lasciato; io stesso (che se non si è ancora capito ero tra i felici possessori) in circa cinque anni dovetti resettarlo una sola volta. Il consumo di corrente era incredibilmente basso: il computer era alimentato da due comuni batterie a stilo che duravano per una ventina di ore di uso continuato. Il sistema operativo era velocissimo e la sua interfaccia una delle migliori mai concepite. Alcuni dei programmi erano superbi e si adattavano a meraviglia alle ridotte dimensioni dello schermo. L’OPL includeva nativamente comandi per l’interfaccia grafica e perfino per un database SQL: cosa mai più vista in nessun altro linguaggio. Le possibilità di connessione ed espansione erano infine ottime per gli standard del tempo, e a mo’ di bonus era incorporato anche un registratore digitale. Non c’è da meravigliarsi se a distanza di più di tre lustri c’è ancora chi vende di seconda mano lo Psion 5, chi lo ripara e chi sviluppa programmi per esso.
Il confronto con gli altri palmari era imbarazzante per questi ultimi: i celebri Palm erano ottimi, ma specializzati solo come agende; i numerosi altri basati su Windows CE (un sistema operativo sviluppato dalla Microsoft per dispositivi di questo tipo) erano al confronto a stento usabili. Lo Psion svettava insomma in tutte le prove comparative. I miei amici mi chiedevano perplessi: «Ma riesci a lavorarci, su una macchina così piccola?» Sì, ci lavoravo perfettamente, tutti i testi che scrivevo in quegli anni nascevano lì e poi venivano trasferiti sul computer fisso solo per l’impaginazione finale. Il fatto che fosse così piccolo e poco intrusivo era un grande vantaggio pratico e psicologico: pratico, perché ogni volta che avevo un’idea o trovavo qualcosa di interessante mi bastava allungare una mano nella tasca per annotarla subito nel posto giusto; psicologico, perché quando lavoravo alla scrivania, il piccolissimo computer (tra l’altro molto elegante) se ne stava discreto tra un libro aperto e un altro, senza mai distrarmi.
Nel 2001 giunse la ferale notizia: la Psion aveva deciso di abbandonare il mercato dei palmari. Che cos’era accaduto? Sicuramente erano stati commessi errori nell’organizzazione dell’azienda, ma un motivo determinante era l’impossibilità di competere nelle vendite con i concorrenti Windows CE: certo, questi erano mediocri e macchinosi, malgrado il nome non avevano nessuna «compatibilità» con la versione ordinaria di Windows, ma erano, appunto, Windows! Chi ne comprava uno aveva l’impressione di comprare una cosa «normale». «Psion» era invece un nome strano che non si sapeva neppure come pronunciare (psìon? psiòn? psàion? sàion?). E poi, bisognava fidarsi di un produttore così ingenuo da raccomandare all’inizio del manuale, molto britannicamente, di inserire subito nel computer i propri dati personali, «so that your Series 5 can be returned if you lose it»? e così intellettuale da giustificare l’unico gioco presente, l’immancabile campo minato, spiegando che serviva per sviluppare il «logical thinking»? Insomma, un’elegante scatolina che sembrava porgerti la mano dicendo: «My name is Psion. Psion Five».
Lo ho ripreso in soffitta e lo rigiro tra le mani. Pur apparendo ancor oggi moderno, questo minuscolo computerino pare venire in effetti da un altro mondo. I suoi lontani successori sono evidentemente gli smartphones. Ma la differenza fondamentale è che esso era progettato attorno ad una piccola bella tastiera, pensato per essere poggiato su una scrivania, o magari sulle ginocchia in metropolitana, per poter star seduti, scrivere con calma da soli e forse addirittura pensare. Mi viene in mente Pascal: «Tutta l’infelicità degli uomini proviene da una cosa sola: dal non saper restare tranquilli in una camera». Tutto si può usare in maniera intelligente oppure stupida, ovviamente: ma è interessante comprendere quale modello di umanità le macchine, nel loro piccolo, suppongono e incoraggiano. In genere senza dirlo ad alta voce.
di Giovanni Salmeri
(Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Filosofia, Roma Tor Vergata)
26 aprile 2014