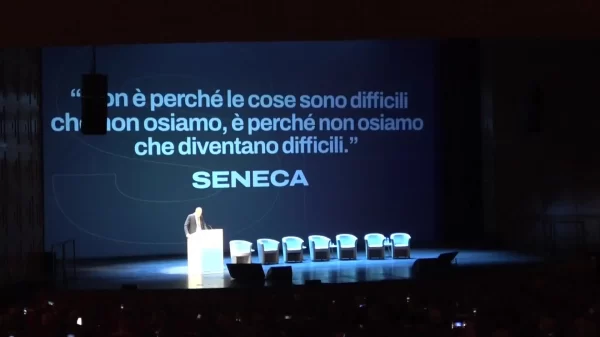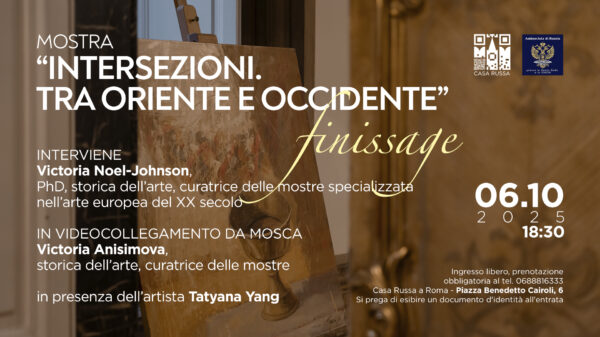La Siria e Roma
Qualche giorno fa ho visitato a Roma la mostra «Siria. Splendore e dramma» (Palazzo Venezia, fino al 31 agosto, ingresso libero). La maggior parte della mostra è costituita da grandi sale in cui, con testi ampi e dettagliati, molte fotografie, ottime riproduzioni di reperti e non poche opere archeologiche originali (prestate dai Musei Vaticani), si racconta la vicenda culturale e artistica della Siria. Una terra ricchissima di storia: diversi influssi si sono incrociati conducendo a risultati ammirevoli, popoli e religioni si sono alternati in maniera non sempre pacifica ma sempre feconda. Lì si trovano alcune delle città più progredite della remota antichità (per esempio Ebla), lì si sono verificati alcune delle fusioni più inaspettate tra Oriente e Occidente (per esempio Palmira), lì ha avuto sede uno dei filoni più ricchi del cristianesimo orientale, lì l’ebraismo ha sviluppato una raffinata cultura figurativa altrove sconosciuta, lì l’islam ha trovato la sua prima grande elaborazione artistica che ha prodotto le gemme delle città di Damasco e Aleppo, lì anche il passaggio dei crociati ha lasciato tracce monumentali. Attraversare le sale significa fare una felice cavalcata nei secoli, rendendosi conto di come tante cose più o meno conosciute sono in effetti concentrate in quel lembo di terra, e trovandosi ad annotare nomi di luoghi e musei pensando tra sé e sé: prima o poi dovrò andarci.
Le ultime sale gelano l’entusiasmo: è solo lì che ci si accorge che tanti luoghi e musei non si potranno mai più visitare. I conflitti che infiammano il Vicino Oriente hanno provocato distruzioni enormi: un po’ perché l’anarchia lascia mano libera a ladri e trafficanti di arte, un po’ perché i luoghi antichi vengono bombardati quando diventano rifugio di truppe, un po’ perché il fanatismo del più violento islam si dirige non solo contro le persone (uccise, torturate, cacciate in massa), ma anche contro la cultura e le memorie del passato. Musei dei quali prima si era annotato il nome sono ora edifici diroccati, opere d’arte conservate per millenni sono intenzionalmente ridotte a frammenti di pietra, capolavori dell’arte islamica e cristiana sono macerie. Forse la distruzione delle opere d’arte con la loro carica simbolica riuscirà a smuovere un po’ di più il nostro Occidente così lento a reagire, anche solo moralmente, di fronte allo sterminio di esseri umani?
Per una felice coincidenza, consecutiva a questa mostra se ne trova un’altra, dedicata alla liberazione di Roma alla fine della seconda guerra mondiale («Roma prima capitale d’Europa liberata», fino al 24 agosto, ingresso libero). Qui si trovano raccolte pubblicazioni dell’epoca e documenti che testimoniano la restituzione di Roma alla libertà e i primi timidi passi di quello Stato che di lì a poco diventerà la nostra Repubblica Italiana. Tra i tanti pannelli uno attira la mia attenzione, portandomi a conoscenza di una circostanza che non conoscevo: il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, governo che aveva sede a Salerno, con uno dei suoi primissimi provvedimenti ripristinò gli studi accademici in quella città (che erano stati interrotti nel 1861 e formalmente istituiti qualche mese prima). Non si trattava ancora di un’Università, ma di un «Istituto Superiore di Magistero», dedicato cioè ai maestri e alla maestre diplomati nell’Istituto Magistrale, che conferiva le lauree destinate all’insegnamento in esso: Materie Letterarie, Pedagogia, Lingue e letterature straniere.
Con gli occhi scorro alcuni nomi e foto dei ministri: Casati, Croce, Degasperi, De Ruggiero, Gronchi, Saragat, Togliatti. Persone di orientamenti differentissimi (e la cui vocazione democratica non è sempre al di sopra di ogni sospetto), ma che condividevano una profonda convinzione nel ruolo civile della cultura. In un paese in parte ridotto alla miseria, disorientato dall’illibertà, stordito dalla guerra, la prima cosa era ritornare a studiare e formare una nuova generazione che potesse preparare gli insegnanti del futuro. Su molte pareti sono riprodotte le prime pagine dei giornali dell’epoca. Con una punta di amarezza mi viene da pensare: fortuna che all’epoca non esistevano gli editorialisti del Corriere della Sera che scrivono, docilmente seguiti dai Governi, che per favorire lo sviluppo italiano bisogna tagliare il numero di professori e studenti e corsi di laurea (il motivo è sempre la «qualità», ovviamente).
La cultura è uno dei primi e più importanti bersagli quando si vuole distruggere la libertà, o quando non si sa più che cosa questa sia, la cultura è una delle prime e più decisive scommesse quando la si vuole ripristinare. La cultura porta con sé anche la possibilità della convivenza, perché significa di per sé educazione alla complessità, capacità di puntare sull’umanità e trovare i necessari compromessi, sguardo che sa apprezzare le ricchezze dell’altro, coraggio nel fermare il fanatismo e la prepotenza. A volte ho l’impressione che ci si pongano troppi problemi riguardo alle strategie della coesistenza pacifica, come se fossero necessarie chissà quali difficili ricette pedagogiche: la cultura in quanto tale (non solo quella accademica, beninteso) sa sempre apprezzare l’umanità, questo è il primo passo necessario e spesso anche sufficiente.
Esco dalla mostra, poco più in là un capannello circonda due ragazzi che suonano per strada una bella musica per violoncello e chitarra, alla spalle c’è il Pantheon. Si è fatta l’ora di pranzo, con mia moglie mangio qualcosa in un novello locale di cucina siriana. Il proprietario è di Damasco, e a due turisti dà consigli sulle cose belle da vedere nel Lazio. Non vende bevande alcoliche, e dice che sarebbe un dramma se i cristiani se ne andassero dalla Siria.
di Giovanni Salmeri
(Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Filosofia, Roma Tor Vergata)
18 agosto 2014