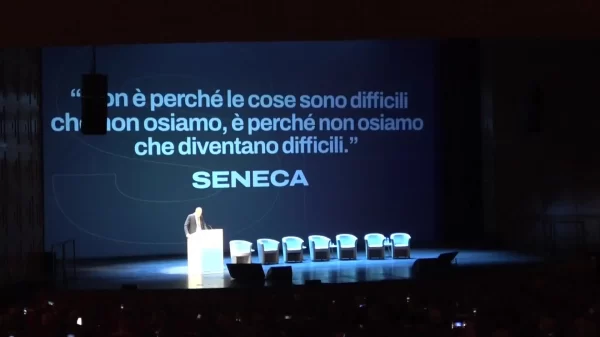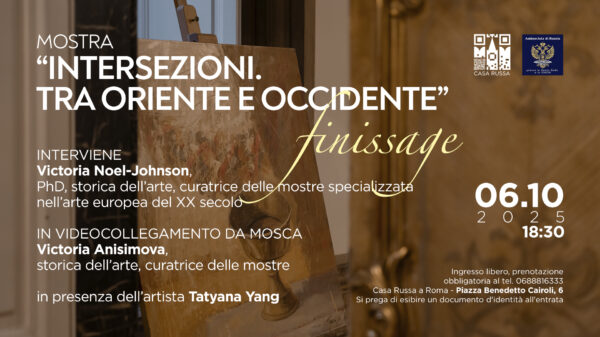Che c’entra la filosofia?
Per chi è abituato a far lezione al massimo ad una quarantina di studenti, e spesso di meno, non è una sfida facile entrare in un’aula di quattrocento. È quello che sto facendo da qualche settimana, tenendo un corso di «Economia e filosofia» per le matricole del corso di laurea di «Economia e management». Il numero degli studenti non è ovviamente l’unica difficoltà né la maggiore: molto più delicato è convincerli che ciò di cui parliamo è importante e che c’è un buon motivo se a partire da quest’anno questo piccolo corso è stato stabilito obbligatorio per tutti.
Una ventina di ore di lezione non sono sufficienti neppure per una sommaria introduzione alla filosofia. Quando ancor prima di iniziare il liceo mi venne regalato un manuale liceale di Filosofia, lo cominciai a leggere con avidità per sapere anzitutto che cosa essa fosse esattamente… Ma l’autore avvertiva sùbito che pretendere di definirla all’inizio era un tipico esempio di errore filosofico, al massimo una risposta si poteva avere alla fine. Non ho dimenticato la lezione (che peraltro oggi penso che vada un po’ sfumata), e dunque so che non si può neppure cominciare con una definizione. Che cosa fare allora in poche ore? Alla fine ho deciso di affrontare solo tre temi.
Il primo: che cosa significa pensare in maniera critica, e perché la competizione per la verità che il pensiero critico mette in opera è molto differente dalle altre. È differente, in poche parole, perché quando si è trovata una verità (in qualsiasi campo) tutti risultano vincitori. Certo c’è qualcuno che la ha scoperta, se è vanitoso potrà gloriarsene: ma la cosa essenziale è che la verità diventa di tutti, tutti possono avvalersene, nel condividerla essa non diminuisce e non si usura: un po’ come, mentre una torta divisa tra cento persone diventa una briciola, un quadro ammirato da diecimila persone resta tutto intero e anzi quasi si moltiplica a causa delle diverse sensibilità e intelligenze che lo incontrano.
Il secondo: che cos’è la «scienza» e quali sono le sue caratteristiche. Da quando la filosofia greca tentò di definirne il concetto, molta acqua è passata sotto i ponti e la discussione non è terminata. Una tappa essenziale è stata la cosiddetta «rivoluzione scientifica» dell’età moderna, in cui la scienza naturale venne caratterizzata dalla descrizione matematica dei fenomeni e dall’uso dell’esperimento per confermare o smentire un’ipotesi. Ma ovviamente questo è un metodo adatto per la realtà naturale, non per quella umana in cui sono in gioco azioni libere. Che cosa significhi «scienza umana» è un problema dunque ancora più complesso e delicato.
Il terzo: che cosa significa interrogarsi sul senso delle azioni umane. Tutti consideriamo un complimento dire che qualcosa è «utile». Ma «utile» significa «finalizzato a qualcos’altro», e non si può andare all’infinito. Alla fine ci sarà pure qualcosa che vogliamo per sé stesso, in quanto è valido e prezioso, in quanto merita gli sforzi di una vita. Che cos’è? è la felicità? e pure se tutti fossimo d’accordo sul nome di «felicità», perché non siamo d’accordo sul suo contenuto? Certo, le opinioni sono diverse, ma il fatto stesso che a volte le cambiamo (a volte in maniera dolorosa) significa che esse non si equivalgono.
Ecco tre temi tipici della filosofia, affrontati innumerevoli volte nella storia e ancor oggi aperti. Ma che cosa c’entrano con l’economia? Non è difficile rispondere. Tutte e tre queste domande attraversano questioni cruciali del discorso economico. Nel primo caso si tratta per esempio di capire che cosa sia la concorrenza, e perché esista una categoria di beni (forse quelli alla fine più importanti) per i quali lo spirito della competizione muta. Il secondo tema costringe a chiedersi se l’economia sia o no una scienza, e in che senso, e magari riflettere un po’ sulla celebre «domanda della Regina» («Se siete i migliori economisti del mondo, perché non siete stati in grado di prevedere questa enorme crisi economica?»), o anche sul fatto che la matematica è utile non solo per fare scienza, ma anche per fingere di farla. L’ultimo tema infine fa comprendere che la domanda sullo scopo dell’economia non è né banale né inutile, ma anzi fondamentale. Le risposte possono essere profondamente diverse, e far credere che nel campo economico si tratta solo di applicare regole «tecniche» è una solenne truffa, che maschera il fatto che in ogni decisione sono coinvolti valori e scelte radicali. Questo era vero al tempo delle grandi ideologie, è vero anche in questo tempo più disincantato, che proprio per questo ha ancora più bisogno di una cultura umanistica, non in concorrenza con le altre ma alleata con esse.
Sicuramente l’anno prossimo riuscirò a far di meglio, ma anche ora sono contento (spero lo siano anche i miei quattrocento studenti…). Ogni corso di laurea è bello, e mi pare bellissimo il corso di laurea in filosofia nel quale lavoro il più del tempo. Ma è anche bellissimo che ogni campo del sapere si incontri con gli altri e aiuti così a chiarire quei problemi che ognuno per sé vedrebbe più difficilmente.
di Giovanni Salmeri
Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Filosofia, Roma Tor Vergata
25 marzo 2014