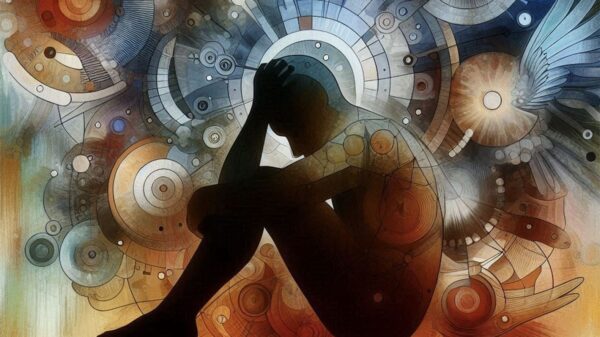Da bob a bob: storie di un disastro. La miopia della politica digitale

La lettura dell’unica recensione finora comparsa alla novella app del Partito Democratico mi ha regalato qualche minuto di sano divertimento: quel divertimento che, un po’ malignamente, solo le stroncature sanno dare. In questo caso la stroncatura era ancora più saporosa, perché proveniva da L’Espresso, una testata teoricamente vicinissima al Partito Democratico o almeno alle sue posizioni. Per coloro che non avessero tempo e voglia, ecco in poche parole la vicenda. Dopo anni di dileggio (non infondato) nei confronti della «democrazia digitale» dei Cinque Stelle, pare che il Partito Democratico abbia mutato strategia: dopo aver tanto disprezzato ha cominciato a comprare, e la nuova app sarebbe il primo segno di un partito più digitale, più vicino ai giovani. «Conosci, partecipa, sostieni» sono le sue tre parole chiave, essa dovrà costituire un «ecosistema digitale di riferimento» per permettere la partecipazione dei sostenitori. E dove sarebbe il problema? Ecco, non funziona niente. E pure se funzionasse, sarebbe una parodia di partecipazione alla vita politica. Nessuna delle possibilità realmente preziose offerte dalla rete sono sfruttate, praticamente solo una sequenza di spot ridicoli (manca solo Renzi con Totti) e di improbabili sondaggi. Il titolo della succitata recensione riassume così la situazione: «Abbiamo provato Bob, la nuova app del Partito Democratico. Ed è un disastro totale». Non esattamente un bel biglietto da visita per un partito che si vuol presentare come molto smart e pronto a riprendersi la guida del Paese (o a mantenerla, piuttosto).
Non è la prima volta che una grande iniziativa informatica è seppellita da una risata. Nell’app del Partito Democratico vi è però un aspetto intrigante su cui conviene soffermarsi: la scelta del nome, «Bob». Nel mondo dell’informatica non è una parola nuova: così si chiamava la rivoluzionaria interfaccia creata dalla Microsoft nel 1995, come un nuovo modo di accedere alle funzioni del computer. Bob ottenne importanti riconoscimenti: per esempio la rivista PC World lo classificò settimo tra i 25 peggiori strumenti tecnologici di tutti i tempi, e il sito CNET.com con pari entusiasmo gli assegnò il premio di peggior prodotto del decennio. L’unanimità degli apprezzamenti raccolti fece sì che dopo appena qualche mese Bob fosse già discontinued: muore giovane chi è caro agli dèi. Ma che cosa aveva di così peculiare Bob? Bob portava un passo avanti la metafora delle interfacce grafiche (ormai all’epoca comuni anche nel mondo Windows, dopo che la Apple le aveva rese celebri un decennio prima): non più solo una «scrivania», ma un’intera casa! Un’intera casa da arredare secondo lo stile preferito. Una casa nella quale cercare gli strumenti per lavorare (vuoi scrivere? un bel click su carta e penna posate sul tavolo! vuoi il calendario? un bel click sull’orologio appeso alla parete). Una casa nella quale essere accompagnati da graziosi animaletti che propongono interessanti attività (soprattutto un cane parlante, ma anche un coniglio, un dinosauro, un verme eccetera). Che qualcuno abbia pensato che questa mostruosità potesse favorire l’ingresso nell’informatica di persone adulte ha veramente del misterioso.
Ma ha anche del misterioso che, una ventina d’anni dopo, qualcuno abbia pensato di riesumare questo famigerato e jellato nome per l’applicazione del Partito Democratico, e che nessuno lo abbia fermato. Con un sorriso si potrebbe dire: nome azzeccatissimo, quale nome migliore per un disastro novello che quello di un antico disastro? Ma oltre a questa coincidenza c’è anche qualcosa di più sottile su cui conviene riflettere. L’antico Bob era un disastro non solo perché, invece di rendere più facile e veloce il lavoro, lo rallentava in maniera grottesca, trasformando banali operazioni in sciocchi videogiochi. Era un disastro anche perché, più che offrire strumenti supplementari per la realtà, si proponeva di sostituirla: ecco la tua nuova casa virtuale, le tue stanze virtuali, il tuo arredamento virtuale. Avveniristico? Forse: ma nessuno voleva quello. Sembrava quasi una presa in giro.
Mutatis mutandis, questo sembra anche il problema fondamentale della «politica digitale»: utile quando aggiunge qualcosa alla realtà (di conoscenza, di incontro, di relazione, di partecipazione), sicuramente disastrosa quando la sostituisce, e anche disastrosa quando pretende di dettarle legge. Che Twitter non permetta più di 140 caratteri non è un buon motivo per eliminare ogni argomentazione, che un messaggio possa arrivare in pochi decimi di secondo al mondo intero non è un buon motivo per ritenere inutile la riflessione, che la metrica più importante sia quella dei like e delle condivisioni non è un buon motivo per confondere la ricerca del consenso con quella della popolarità. Sollecitare la partecipazione in questi confini è, esattamente come nel caso del primo Bob, una presa in giro. Il fallimento del novello Bob pare dovuto semplicemente al fatto che è realizzato malissimo: ma se questa fosse l’occasione anche per riflettere al fatto che la politica va liberata e protetta da una superficialità che riterremmo inaccettabile pure per decidere il rifacimento della grondaia in un’assemblea di condominio, sarebbe una buona cosa.