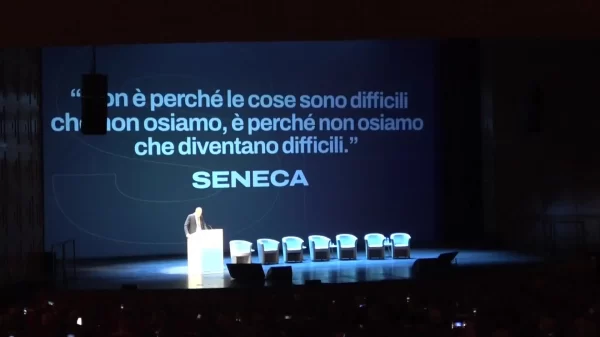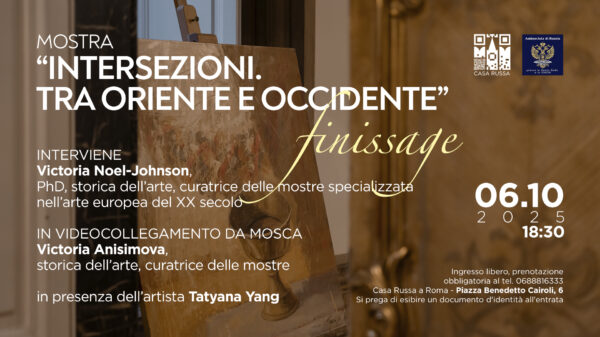La cultura non si mangia
La crisi economica esplosa nel decennio passato ha reso più urgenti e affannose domande che di per sé accompagnano qualsiasi decisione sull’indirizzo del sistema dell’istruzione e sull’allocamento delle risorse. Spesso a queste domande vengono date risposte ragionando su «ciò che serve» e «ciò che non serve», e la cultura cosiddetta «umanistica» è una delle prime a farne le spese. Come diversi anni fa disse un ministro dell’economia, «la cultura non si mangia»: la conclusione neppure troppo nascosta è che investire tempo, forze, spazio e denaro in cose come letteratura, poesia, arte, storia, filosofia, è uno spreco di risorse che non possiamo permetterci, perlomeno non di questi tempi.
È vero che la cultura non si mangia? Verissimo! Anzi, ragionando un poco su che cosa si mangia e che cosa no si possono capire tante cose. Proviamo anzitutto a fare un elenco delle cose che si mangiano. In effetti è abbastanza lungo: si mangiano patate, melanzane, asparagi, cicoria, mandarini, nespole, grano, orzo, latte, uova e cose simili (in omaggio ai miei amici vegetariani e alle loro ragioni fermo qui l’esemplificazione). Riconosciamolo: letteratura, poesia, arte e simili non fanno parte di quest’elenco. Per equità possiamo intendere «ciò che si mangia» come una sinèddoche, e dunque includere ciò che in generale è necessario alla sopravvivenza: e allora dobbiamo aggiungere il vestiario e l’abitazione: dunque calzature, camicie, pantaloni e simili, e almeno una camera con un letto. Inseriamo per generosità anche un bicchiere per bere (benché Diogene il cinico alla fine abbia capito che era superfluo: basta il cavo delle mani). Ci siamo! Ora l’elenco è veramente finito, e letteratura, poesia, arte e simili, con tutti i loro armamentari (libri, violini e simili) continuano a rimanere fuori.
Il piccolo particolare è che innumerevoli altre cose sono rimaste fuori: sono rimasti fuori mobili, stoviglie, televisori, macchine fotografiche, videocamere, telefoni più o meno smart, computer, lampade, giochi, orologi, gioielli, profumi, treni, aerei, automobili, motociclette e cose simili. Replicare che alcune di queste cose sono indirettamente necessarie per la sopravvivenza non vale: lo sono solo nella misura in cui nel concetto di sopravvivenza vengono inclusi certi aspetti culturali, determinati modi di rapporto sociale, a cui si può tranquillamente rinunciare, per esempio perché sostituibili con altri che non richiedono questi beni e che si possono giudicare ancora migliori. Un frate trappista in effetti direbbe che di tutte quelle cose non ha alcun bisogno ed è felice lo stesso, anzi anche più. Pure tutti gli strumenti elaborati della medicina, a partire dai farmaci, restano fuori: alla fine dobbiamo tutti morire in ogni caso, no? E dal nostro elenco del necessario per la sopravvivenza sono rimaste fuori anche le elaborazioni del necessario per la sopravvivenza: grano e latte sono nell’elenco, ma la pastiera napoletana no; vestiti essenziali sì, ma le infinite mutazioni della moda no; una camera sì, ma appartamenti, palazzi e giardini no.
È per questo che non credo che sia una buona strategia replicare ai detrattori che «anche la cultura umanistica fa guadagnare». Carlo De Benedetti raccontò che Bill Gates gli aveva confidato: «Se avessi avuto l’archivio degli Uffizi ci avrei fatto più utile che con Windows»: giustissimo, ma questa è una cosa ovvia, e il fatto che suoni come un’affermazione rivoluzionaria testimonia solo l’immensa stupidità di certe politiche. Il punto cruciale è osservare che, appena ci si sollevi al di sopra di un facilissimo, elementarissimo livello indispensabile alla sopravvivenza, tutto il resto, che sia scienza, tecnica, medicina oppure arte, musica, filosofia e poesia, è un di più, un investimento a perdere che testimonia la straordinaria capacità dell’umanità di riconoscere il senso della propria esistenza nell’inutile, nel gratuito. Alla stragrande maggioranza delle cose viene riconosciuto un valore perché simboleggiano e significano qualcosa di umano, perché sono inserite in un sistema in cui le persone vanno oltre ciò che semplicemente è utile alla sopravvivenza. Nessuna differenza da questo punto di vista tra una bella macchina fotografica e una bella canzone. Non c’è davvero da meravigliarsi del fatto che la stragrande maggioranza dell’economia si muova attorno a questo inutile!
Ma che cosa intende allora chi ripete che «la cultura non si mangia», visto che la frase in sé è, come abbiamo visto, veramente stupida? Forse sta pensando un’altra cosa: che è meglio non investire troppo in quelle inutilità (come i libri o l’arte, per esempio) che invitano a pensare, a progettare una vita e un mondo diverso, a ricordare che alla fine ciò che è determinante per la felicità umana sono i beni umani: anche questa è un’ovvietà, però rivoluzionaria per esempio in un mondo in cui si continuano a fare politiche sotto l’assioma deviante che chi alla fine deve essere felice sono i mercati e i conti dello Stato, mica le persone. La gente che pensa è insomma sempre più scomoda da gestire. Vale la pena convincere che, piuttosto che sprecare il proprio tempo leggendo un libro o ascoltando un concerto, sia meglio sprecarlo guardando in alta definizione un reality show con Rocco Siffredi, oppure ripetendo all’infinito un giochino ipnotizzante sul proprio smartphone, accanto ad altre decine di persone che sprecano il proprio tempo nello stesso identico modo. È tutto più semplice e più ordinato.
Giovanni Salmeri
(Presidente del Corso di laurea in Filosofia, Università di Roma Tor Vergata)
4 luglio 2015