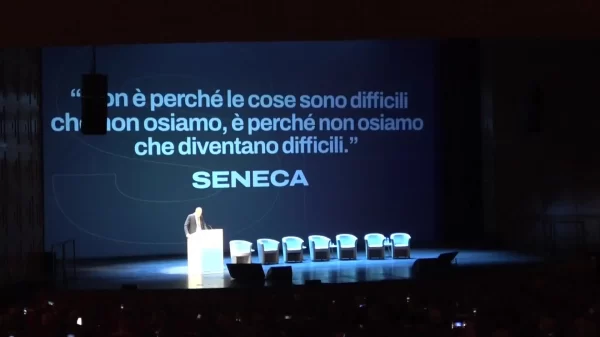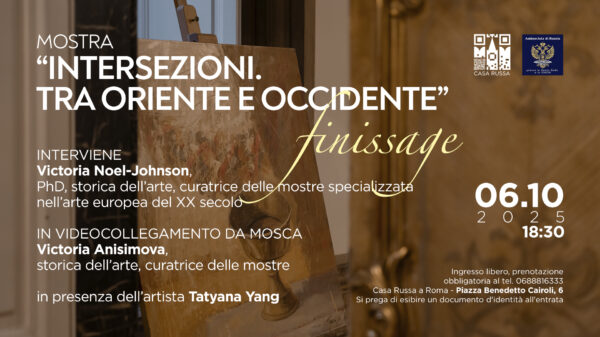Usciranno assassini dalle nostre scuole?
Tutti i commentatori hanno ritenuto che non fosse casuale che l’ultimo filmato diffuso dallo Stato Islamico indugiasse nel mostrare all’opera come assassini a volto scoperto giovani occidentali, prontamente riconosciuti nelle loro nazioni. L’accento londinese che si percepiva nel primo filmato della serie non era dunque un’eccezione isolata: sono molti i giovani europei, musulmani dalla nascita o convertiti all’Islam, pronti a partire per unirsi alle loro gesta. Leggermente più sottile ma egualmente presente è il messaggio: ormai gli europei non devono sentirsi sicuri neppure a casa propria, perché il terrore può scatenarsi da un momento all’altro nelle loro strade.
Com’è possibile che giovani che sono cresciuti, spesso nati, in Europa, che hanno convissuto per molti anni con la lingua, la cultura, i valori, la scienza, l’arte dell’Occidente, rifiutino poi tutto con odio e disprezzo? Ogni tanto la domanda viene formulata, raramente però riceve una risposta un po’ articolata. Il problema non è come il fanatismo possa attrarre (non è una sorpresa, la debolezza psicologica e la fragilità dei rapporti umani sono per esempio un ottimo terreno di coltura). Il problema è come ciò non venga impedito dalla consuetudine con una civiltà completamente diversa, la nostra magnifica civiltà europea. Cerchiamo insieme una risposta?
Mi pare che le cose più importanti da dire siano due. La prima: gli esseri umani sono liberi. Invincibilmente, irrimediabilmente liberi. Ogni domanda della forma: «come è possibile che il tale faccia questo?» ha la stessa prima risposta: perché il tale è libero. Non esistono condizioni di contorno (a parte la coercizione fisica, ovviamente) che possano impedirgli di agire in un modo che in ultima analisi è imprevedibile. Giovanni Duns Scoto, un filosofo medievale che, andando controcorrente rispetto al suo tempo, sosteneva l’assoluta originarietà della libertà umana («la volontà è libera perché è volontà», diceva), non esitava ad andare fino in fondo e sostenere che non c’è nulla di contraddittorio se oggi San Francesco, dopo una lunga permanenza in paradiso, decidesse liberamente di andarsene all’inferno. È questa una risposta che tronca la discussione? No, la apre. È la risposta che ci ricorda che ogni volta che sono in questione i comportamenti umani non si sta ragionando (solo) di condizioni sociali, economiche, politiche. Si sta ragionando di atti di libertà, e dei loro incontri e scontri. E i problemi delle libertà non si risolvono mai soppesando gli ingredienti come in una macchina per fare il pane, dove il risultato è assicurato quando si mettono i grammi esatti di farina, lievito, acqua e sale. No, i problemi di libertà si affrontano solo rischiosamente attraverso rapporti umani.
Ma come si chiamano i rapporti umani quando in gioco c’è la formazione del proprio atteggiamento nei confronti di una civiltà? Questi rapporti si chiamano educazione, o anche, riducendo un poco la prospettiva, istruzione (distinguere tra le due cose è in realtà difficile). È in questo tipo di rapporti che una libertà s’incontra con un’altra (fosse pure attraverso la forma mediata di una pagina stampata), per trasmettere qualcosa e chiedere una risposta. «Chiedere», non «causare»: perché dall’altra parte c’è una libertà. E dunque la seconda cosa che bisogna dire è che la presenza di volti occidentali tra gli assassini dello Stato Islamico è l’indizio di un fallimento nell’educazione e nell’istruzione. Costoro hanno frequentato per anni scuole in nazioni avanzatissime, con belle leggi sull’istruzione obbligatoria e gratuita: ma proprio nelle nazioni europee in cui il sistema educativo è in maggiore crisi di identità, Francia e Gran Bretagna in primis. Ciò non spiega tutto, ma non è neppure casuale.
Per decenni soprattutto in alcune nazioni si è ripetuto: «la scuola non deve “trasmettere”, perché questo è un atto violento che coarta la creatività degli scolari», «il sistema educativo dev’essere neutrale nei riguardi di qualsiasi valore, perché viviamo in una società pluralistica», «proprio questa neutralità insegna ad essere tolleranti, aperti, accoglienti dell’altro», «teniamo fuori la religione, perché è una cosa privata e discrimina chi la pensa diversamente», «un’istruzione moderna si preoccupa solo di ciò che serve per lavorare, il resto è zavorra». Tutte affermazioni in cui c’è una particella di verità, ma formulata in maniera tale da distruggere la cosa essenziale dell’istruzione e dell’educazione: che in esse è in gioco la formazione di esseri umani liberi tramite l’incontro con altri esseri umani liberi, che in esse una civiltà trasmette ciò che crede ci sia di grande, bello e buono nella sua tradizione, lasciando ovviamente la libertà di criticarlo, migliorarlo, anche rifiutarlo.
Trovo stupefacente che considerazioni di questo tipo, o almeno discussioni sui temi connessi, siano così rare in queste settimane: sarebbe uno dei modi per trarre dalla presente tragedia qualcosa di buono e costruttivo. Anzi no, questi temi sono presenti, ma grazie all’invadenza crescente di voci che, ignorando la domanda da cui siamo partiti, propongono esattamente gli orientamenti che altrove hanno portato alla disfatta della pubblica istruzione. Teniamolo presente quando leggiamo proposte ingenuamente liberali che vogliono trasformare l’insegnante in un «pianificatore della costruzione della conoscenza» (le informazioni si trovano googlando, che bisogno c’è di trasmettere, no?). Teniamolo presente quando assistiamo a dileggi nei confronti del liceo classico (meglio conoscere le origini della vita che le origini della nostra cultura, no? in Francia il liceo classico mica esiste!). Teniamolo presente pure quando le ricette elaborate si avvicinano sinistramente al programma scolastico dello Stato Islamico, in cui il sapere umanistico è stato cancellato per lasciare spazio solo a scienze e tecniche, così inevitabilmente asservite ad un’ideologia da non discutere.
Giovanni Salmeri
(Presidente del Corso di laurea in Filosofia, Università di Roma Tor Vergata)
22 novembre 2014