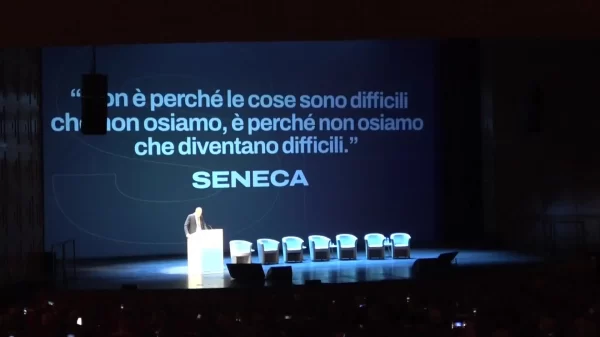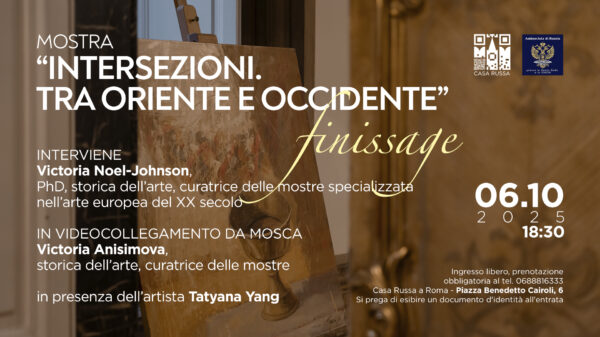Gli studenti non sono clienti
Qualche tempo fa mia moglie (belga francofona) mi chiese perché in italiano si dica «università degli studi»: di che cosa dovrebbe mai occuparsi un’università se non dello studio? La risposta non era difficile, ma è stato grazie a lei che mi sono reso conto che in effetti solo l’italiano ha mantenuto questa preziosa traccia della lingua latina, in cui è necessario dire universitas studiorum: universitas infatti è un termine generico, che corrisponde grosso modo a «corporazione, associazione». Così come esistevano dunque le «università dei lanaioli» o «dei fabbri», esistevano anche le «università degli studi», che raggruppavano i nuclei di insegnamento superiore.
In effetti è una caratteristica del mondo medievale la presenza chiara e forte di quei «corpi intermedi» che per noi sono difficili da concepire, figli come siamo della concezione dello Stato moderno direttamente interfacciato con l’individuo. Leggere qualche cronaca medievale è estremamente istruttivo per comprendere quanto fosse forte lo spirito di corpo nelle università e quanta fosse l’autonomia di cui esse godevano. Un’università era quasi una repubblica indipendente, sia rispetto al potere civile, sia rispetto a quello religioso, pure nei periodi in cui entrambi erano più saldi e indiscussi. Perfino i reati comuni venivano giudicati dalle autorità accademiche. Nel XIII secolo Alessandro di Roes, che non aveva nessuna particolare preoccupazione di difendere l’università, dà per ovvio che nel mondo esistono tre poteri: il sacerdozio, l’impero e lo studio (in termini moderni diremmo: il potere religioso, civile e culturale). Il primo ha il suo centro a Roma con il papato, il secondo in Germania con l’imperatore, e il terzo a Parigi con l’università degli studi, che all’epoca godeva di un primato indiscusso in tutto l’Occidente. La cultura sta solo ad un modesto terzo posto? In realtà no, perché Alessandro di Roes mette in parallelo i tre poteri con le tre persone della Trinità divina, che hanno identica sostanza e identica potenza, e la cultura occupa il posto dello Spirito. La cultura è dunque in terra lo spirito che anima ogni cosa, il legame che tiene unite le esigenze della terra con quelle del cielo, la gestione delle cose terrene e gli ideali dell’uomo.
Perché tanta autonomia? Gli studiosi della sociologia della cultura se lo chiedono, e giungono all’unica risposta possibile: sia il potere civile sia quello religioso capivano quale vantaggio ricevevano da un’università libera. Libera! Solo essa era capace di elaborare la migliore cultura, che ritornava come un vantaggio prestigioso per tutti, con i migliori giuristi, i migliori medici, i migliori teologi, i migliori filosofi e matematici. Perfino quando qualcuno ragionevolmente sosteneva che lo studio della teologia era finalizzato ad un successivo impegno nella predicazione, i più illuminati (per esempio Enrico di Gand) rispondevano che non era così: la ricerca della verità ha sempre un suo senso, pure quando immediatamente non giova a nessuno. La conoscenza progredisce solo quando deve rispondere a sé stessa, e non alle esigenze del potere, o del denaro, o a qualsiasi altra buona o lecita preoccupazione. Invano si cercherà quindi nel Medioevo qualcosa che assomigli pure lontanamente all’incredibile invadenza che gli odierni Ministeri (l’Italia è da questo punto di vista uno dei casi più abnormi) esercitano sugli ordinamenti interni delle università.
Ma c’è un altro punto decisivo da sottolineare. Universitas studiorum, abbiamo detto. Ma che cosa erano esattamente gli studia? Erano l’insieme di un maestro, dei suoi assistenti e degli studenti (due categorie, queste ultime, con un confine sfumato). L’università era dunque, detta in altro modo, un’«associazione dei docenti e degli studenti». Gli studenti, organizzati in nationes, erano considerati parte integrante dell’impresa culturale e godevano di tutti i privilegi accordati all’universitas. Questa idea in realtà è durata a lungo anche oltre il Medioevo: chi a Padova attraversa Piazza dei Signori, può leggere ancora una macabra lapide che ricorda le terribili punizioni riservate nel 1723 a dodici «sbirri» che avevano osato aggredire alcuni studenti: «il che resti à perpetua memoria e della pubblica giustizia, e della pubblica costante protezione verso la prediletta insigne università dello studio di Padova». Ancora nel Settecento, toccare uno studente significava attentare a ciò di cui la città si vantava di più. I nostri governanti quale lapide lasceranno ai posteri?
Non è comunque facile capire, nelle così mutate condizioni sociali di oggi, che cosa possa significare tenere in vita questo antico spirito, che dovrebbe riguardare anche la scuola secondaria superiore, visto che la medievale Facoltà delle Arti era in realtà l’equivalente del nostro liceo. Certamente non è la sola presenza degli studenti negli organi di governo che può realizzare uno spirito di partecipazione: ma è già qualcosa. Più importante ancora è mantenere aperte le porte della carriera dell’insegnamento. Ovviamente solo pochi tra gli studenti, per evidenti motivi di equilibrio, diventeranno professori: ma il rapporto tra «pochi» e «nessuno» è infinito. L’atteggiamento di un professore e quello di uno studente cambiano enormemente quando si può intravedere insieme un futuro in una medesima impresa (e quindi quando il primo non si sente, come ho letto qualche giorno fa, «l’ultimo esemplare della specie»). C’è però un elemento che mi pare oggi ancor più decisivo: smetterla una volta per tutte con l’equivoco secondo cui gli studenti sono i «clienti» che pagano per una merce e devono anzitutto essere messi in grado di sceglierla, confrontando fra loro le «aziende» università e scuola, soppesandone le «offerte formative» come se fossero tostapani sullo scaffale di un ipermercato. A chi poteva venire in mente di parlare di «erogazione della didattica» (come oggi ufficialmente dice il Ministero) se non a chi non ha la benché minima idea di che cosa sia l’università? In un’associazione non si è mai clienti, ma, appunto, soci, e sbagliarsi su questo porta ad errori a cascata. La scuola superiore e l’università sono anzitutto un’avventura da intraprendere insieme, in cui si diventa corresponsabili della cultura, della sua capacità di rendere più umani, di uno sguardo critico su ciò che altrimenti sarebbe ovvio e dovrebbe solo essere ordinatamente gestito dai poteri di questo mondo.
di Giovanni Salmeri
(Presidente del Consiglio di Corso di laurea in Filosofia, Roma Tor Vergata)
18 dicembre 2013