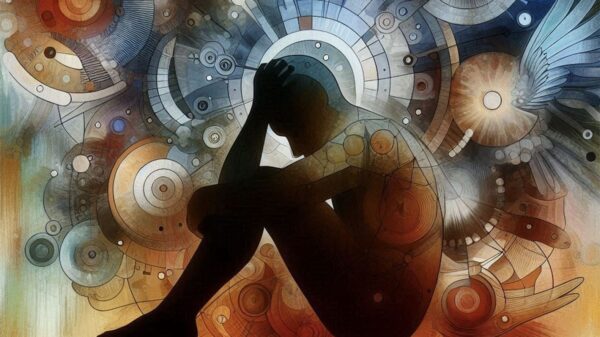Scuole di frontiera: l’espressione della crisi sociale

Scuole di frontiera, dunque scuole di confine, di limite e di muri divisori. Scuole di assenze e confusione, di vuoti e di paure. Le scuole nascono per raccogliere vite, per mantenere promesse, per formare sogni e rimediare ai disastri, per proteggere ambizioni e preparare ai fallimenti.
Tutte le scuole. Ma alcune più di altre. Queste alcune sono le scuole di frontiera, nelle quali non ci sono semplici studenti, ma piccole donne e aspiranti uomini che non riescono a sentirsi discenti, ma gente di strada. Come insegnare a chi non vuole sentire, come sorprendere chi ha già visto troppo, come costruire un rapporto di reciproco confronto con chi si sente già così forte? Con chi, insomma, non considera la formazione scolastica una scelta, benché meno una reazione al degrado.
Frontiera significa, però, anche “metterci la faccia”. Le persone di frontiera sono esposte in prima linea, prendono e riparano i colpi. Sono le più esposte e dunque le più vulnerabili, ma non per questo apolidi. La frontiera è sì il limite di un luogo, ma fa parte dello stesso, vi è contenuta: deve essere riconsiderata e responsabilizzata dall’interno.
È evidente come la scuola non possa essere ridotta ad un’istituzione in sé chiusa, poiché l’educazione e la formazione rappresentano un continuo scambio fra l’interno e l’esterno del circolo scolastico. La scuola di frontiera plasma la figura del docente in base alle esigenze sociali e strutturali dell’ambiente in cui crescono gli studenti. Non è scontato lo svolgimento delle lezioni: tra il docente e l’alunno si instaura un rapporto di complicità e reciprocità, ma anche di sfida e di lotta.
Insegnante sfregiata al volto da un suo studente
Risale proprio a ieri l’ennesimo episodio di violenza interno ad una scuola. Uno studente di 17 anni, iscritto all’istituto superiore Ettore Majorana di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, ha sfregiato la guancia sinistra della sua insegnante di italiano. La professoressa, Franca di Blasio (54 anni), voleva interrogarlo per fargli recuperare un’insufficienza, ma l’alunno, residente ad Acerra, che era entrato a scuola con un coltellino, l’ha colpita durante la lezione, di fronte ai compagni di classe mentre era in corso la lezione, per poi scappare dall’istituto. Le grida dell’insegnante e degli altri studenti hanno richiamato l’attenzione dei collaboratori scolastici e degli insegnanti impegnati in altre classi, che sono entrati in aula per controllare cosa stesse succedendo.
La professoressa è stata condotta all’ospedale Maddaloni, dove i medici hanno rilasciato una prognosi di 15 giorni, mentre il ragazzo è stato subito fermato, in un bar vicino alla scuola, e condotto in caserma. Deve rispondere di lesioni gravi e porto illegale di oggetti atti ad offendere. Intanto i carabinieri stanno cercando di capire se lo studente avesse deciso precedentemente di aggredire l’insegnante, portando con sé l’arma, oppure se il possesso dell’arma è indipendente dall’accaduto.
Gli studenti dell’istituto superiore Bachelet-Majorana si dissociano dal gesto, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook della scuola: «intendiamo assolutamente dissociarci e condannare l’atto di violenza di cui si è reso protagonista uno studente del nostro istituto. Il gesto ci lascia amareggiati e stupiti. Esprimiamo il nostro affetto alla nostra Professoressa e all’intero corpo docente che quotidianamente si prende cura di noi, non solo istruendoci, ma soprattutto educandoci al rispetto delle regole e delle persone».
La preside dell’istituto, Giuseppina Sgambato, ancora scossa per gli avvenimenti della giornata di ieri, racconta le poche informazioni che ha in merito alla vicenda, dicendosi innanzitutto preoccupata per la professoressa: «spero che non restino segni perché la ferita è profonda, mi ha preoccupato parecchio. Io ho incontrato il fratello fuori dalla caserma dei carabinieri. Ho la sensazione che questo ragazzo non si sia nemmeno reso conto di ciò che ha fatto. L’insegnante lo invitava da diversi giorni ad essere interrogato per confermargli il sei».
Anche la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha condannato l’atto, dichiarando di per sé già inaccettabile il fatto che lo studente si sia recato a scuola con un coltello. «Simili episodi di violenza non dovrebbero mai accadere, men che meno in un luogo come la scuola, in cui educhiamo le nostre ragazze e i nostri ragazzi al rispetto e il cui obiettivo è formare cittadine e cittadini consapevoli e responsabili».
Dispersione scolastica
Come sottolinea la stessa ministra Fedeli, «la dispersione scolastica è un fenomeno che va contrastato con forza, perché dove la dispersione è alta vuol dire che non sono garantite a sufficienza pari opportunità alle ragazze e ai ragazzi».
Secondo il rapporto del MIUR del 2017, relativo all’anno scolastico 2015/2016, il tasso di dispersione è sceso fino al 13,8%, rispetto al 20,8% del 2006. L’Italia si avvicina dunque all’obiettivo Europa 2020, che prevede di scendere per quella data al livello del 10%. Ogni regione ha la propria percentuale di abbandoni scolastici, ma è al Sud che si registrano i livelli più alti.
Per quanto riguarda l’anno scolastico 2015/2016, sono stati 14.258 gli studenti che hanno abbandonato la scuola, circa lo 0,8% di coloro che frequentavano la scuola secondaria di I grado. Tra le regioni con maggiore dispersione spiccano la Sicilia con l’1,3%, la Calabria, la Campania e il Lazio con l’1%. La percentuale più bassa si evidenzia in Emilia Romagna e nelle Marche con lo 0,5%. Il picco di dispersione si registra nel passaggio dalle scuole medie alle superiori, quando infatti 34.286 studenti hanno deciso di lasciare gli studi, quasi il 6,1% degli studenti.
Durante gli studi delle scuole secondarie di secondo grado, la dispersione si aggira intorno al 4,3%, circa 112.240 studenti. Il Mezzogiorno ha una percentuale più elevata della media nazionale (4,8%). Tra le regioni con maggiore abbandono spiccano Sardegna, Campania e Sicilia, con punte rispettivamente del 5,5%, del 5,1% e del 5,0%. Mentre le percentuali più basse si evidenziano in Umbria con un valore del 2,9% e in Veneto e Molise con valori del 3,1%. L’abbandono complessivo più contenuto si è registrato per i licei, che hanno presentato mediamente una percentuale del 2,1%, mentre per gli istituti tecnici la percentuale è stata del 4,8% e per gli istituti professionali dell’8,7%.
Scuole di frontiera
Molto spesso si parla di “scuole difficili”, realtà nelle quali l’istruzione non è scontata, al contrario spesso anelata e sofferta. Le scuole difficili ripropongono al loro interno influenze e tendenze esterne all’istituto-scuola. L’unico strumento che la scuola possiede per non soccombere al disagio è smettere i panni dell’istituto e indossare quelli del centro, nel quale l’accoglienza e la comprensione fungono da presupposti imprescindibili per il lavoro tra studente e insegnante.
Lo dimostrano anche i video-documentari, Prof in trincea, girati da La Repubblica, nei quali vengono presi in considerazione alcuni istituti scolastici delle varie periferie italiane. Fra queste la scuola media Federico Fellini di San Basilio, periferia nella zona nord-est di Roma.
Francesca Pellizzaro, la vicepreside dell’istituto Fellini, spiega come si può essere insegnanti in simili contesti: «i ragazzini non nascono cattivi. Quando uno si alza e non fa fare lezione, sbatte, va fuori e prende a male parole anche la preside, lì c’è qualcosa che non va. Le scelte sono due: o fai l’insegnante integerrimo oppure ti domandi che cosa c’è dietro quello che è una provocazione e anche una richiesta d’aiuto». Invece, la preside, Malvina Fiorani, riferendosi ai risultati che questi ragazzi possono raggiungere descrive come traguardi l’iscrizione alla scuola superiore, realizzabile in pochi casi, perché la maggior parte degli studenti abbandona il percorso formativo dopo il diploma di scuola media; l’assunzione di un posto di lavoro, o “semplicemente” l’abbandono di un contesto familiare malavitoso. L’abbandono scolastico non è dovuto a problemi di apprendimento, quanto alla prevaricazione del contesto sul ragazzo, «ci deve essere la possibilità di un’altra risposta. Sono ragazzi che spesso non fanno i compiti a casa ovviamente, ma dovreste poi vedere che intuito, che conoscenza del mondo diversa».
Stessa situazione, se non peggiore, all’istituto di istruzione superiore Melissa Bassi di Scampia, periferia nord di Napoli. Una scuola descritta da Giuliana Zoppoli, docente di diritto, come “una scuola di frontiera nella frontiera”. Per capirlo basta osservare la struttura, a metà fra la scuola e il carcere: ogni corridoio termina con un cancello chiuso a chiave e aperto dai collaboratori scolastici. Gli ingressi sono monitorati da telecamere, per assicurarsi che a scuola entrino soltanto gli studenti e il personale autorizzato. In alcuni casi le famiglie degli studenti non sono neanche identificabili e l’istituto è stato più volte vittima di furti.
Anche l’istituto comprensivo statale Giovanni Falcone, del quartiere Zen di Palermo, sopravvive in condizioni di disagio importanti. La preside dell’istituto, Daniela Lo Verde, chiarisce subito che “qui la scuola non è una priorità”. La docente di lettere, Giovanna Trapani, fornisce un’analisi tanto triste quanto realistica, chiarendo che i loro studenti «sono ragazzi che non sanno sognare, perché vivono il presente, giorno per giorno. Pensare di costruire un progetto, un futuro, una vita professionale, per loro, è una cosa che accade raramente. Anche abituarli a sognare è un obiettivo della scuola».
La contaminazione etnica nemmeno tra i banchi di scuola
Partendo dal presupposto che in Italia l’istruzione è un diritto universale, il MIUR, nel febbraio 2014, ha pubblicato le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, che antepongono la personalità dei minori stranieri alla loro nazionalità. In accordo con questo principio non sono previsti requisiti di legge per i rifugiati, né per i minori neo arrivati nel nostro paese per accedere al sistema di istruzione. Sulla base di ciò, le scuole accettano l’iscrizione degli alunni stranieri anche se privi di documenti di identità, perché la loro irregolarità non può impedire il diritto all’istruzione.
Negli ultimi dieci anni sono nettamente aumentati gli alunni con cittadinanza non italiana, i nati in Italia, ma da entrambi i genitori stranieri. Nell’anno scolastico 2005/2006 il loro numero superava appena le 400.000 unità, nel 2014/2015 era raddoppiato, raggiungendo circa le 830.000 unità.
È altrettanto vero, però, che la dispersione scolastica, relativa al primo ciclo di istruzione, colpisce maggiormente i cittadini stranieri rispetto a quelli italiani, arrivando al 3,3%, contro lo 0,6% relativo agli alunni con cittadinanza italiana. Ma anche nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, la percentuale di alunni stranieri che ha abbandonato gli studi è del 5,72%, contro l’1,2% relativo agli alunni con cittadinanza italiana.
L’istituto comprensivo Scaloia (materna, elementari e medie) di Milano, dove 7 bambini su 10 sono stranieri, è la viva dimostrazione di quanto sia difficile e faticoso realizzare le logiche dell’integrazione a scuola. La difficoltà di fare lezione emerge soprattutto con i NAI (neo arrivati in Italia): l’interazione è difficile perché questi bambini non parlano neanche una parola di italiano, ma si trovano a seguire programmi che richiedono la conoscenza della lingua. Questa difficoltà riguarda gli insegnanti, che hanno difficoltà nell’approcciarsi agli alunni, ma anche questi ultimi, completamente disorientati proprio nel luogo che dovrebbe rappresentare la bussola del loro futuro.