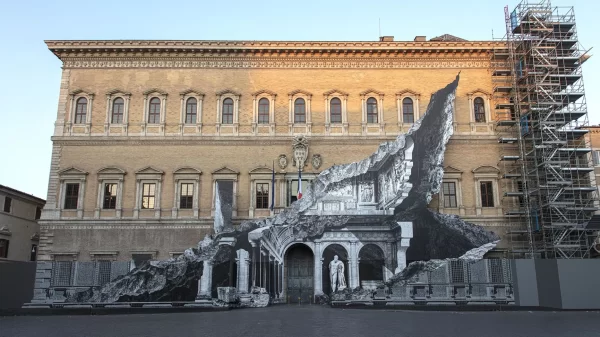Didattica a distanza. L’importanza della ludicità per i più piccoli

La didattica a distanza è ormai pane quotidiano di tutto il corpo docente a livello nazionale. A poco più di un mese dalla fine delle attività scolastiche, il ritorno alla normalità sembra ancora molto lontano e si concretizza sempre di più uno scenario con l’uso di questo strumento didattico anche per il prossimo anno, a partire da settembre, come risorsa costante da integrare alla didattica in presenza.
Gli studenti più grandi, adolescenti e giovani, hanno un vantaggio di non poco conto rispetto agli alunni in tenera età poiché, avendo un proprio metodo di studio, riescono ad acquisire i concetti nuovi anche a distanza, tramite l’uso di videolezioni o attività laboratoriali che tengano conto dei diversi stili di apprendimento e facciano uso di metodologie attive, come la flipped classroom e il cooperative learning. I più piccoli invece sono ancora in piena fase evolutiva e necessitano di un supporto maggiore durante la didattica, per riuscire a dar vita a un ragionamento personale e un’acquisizione completa.
In aiuto dei docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado corre quindi la didattica ludica, una metodologia che prevede l’uso di tecniche basate sulla ludicità e sul gioco nell’insegnamento linguistico. Il metodo ludico pone al centro il discente e il suo benessere psico-affettivo, considerando lo studente come un soggetto attivo, autonomo e responsabile. Creando un contesto ricco di stimoli positivi, l’allievo è protagonista del proprio percorso formativo e apprende la lingua attraverso un processo naturale di scoperta.

Tecniche didattiche basate sulla ludicità
La glottodidattica ludica è strettamente legata all’approccio umanistico-affettivo, sviluppatosi intorno agli anni ’80 del secolo scorso sulla scia della psicologia umanistica di Carl Rogers, secondo il quale le caratteristiche affettive e della personalità del discente influiscono in maniera rilevante sui processi di apprendimento. In situazioni di stress e di ansia, l’allievo infatti innalza il filtro affettivo, una barriera che permette soltanto l’apprendimento momentaneo, per cui è necessario creare percorsi didattici che siano capaci di ridurre le resistenze psico-affettive dell’apprendente, consentendo così un’acquisizione completa e duratura.
La ludicità risponde a pieno a tale scopo perché permette di abbassare i livelli di ansia, creando le condizioni favorevoli affinché lo studente apprenda, divertendosi e distraendosi dai contenuti strettamente linguistici del compito. Si tratta della rule of forgetting di Krashen, secondo cui si acquisisce meglio quando ci si dimentica che si sta imparando una lingua. Una tecnica didattica che si avvale della ludicità è la Total Physical Response (Asher, 1960), che prevede una risposta fisica dello studente ai comandi dati dall’insegnante, eliminando lo stress e rendendo l’apprendimento gradevole e divertente. Il gioco può essere sfruttato anche per le attività di Suggestopedia (Lozanov, 1978) e di Silent Way (Gattegno, 1972), in quanto queste prevedono un clima di lavoro piacevole, privo di fattori che possano creare agitazione e tensione nervosa, ostacolando quindi l’apprendimento.
La metodologia glottodidattica ludica aderisce a pieno anche negli approcci comunicativo-funzionali, poiché giocando si valorizza la funzione comunicativa della lingua in un contesto autentico. Anche il cooperative learning si coniuga bene con la ludicità, permettendo una forte interazione tra i membri del gruppo classe, favorendo la socializzazione e consentendo allo studente anche di imparare dai compagni. Nel realizzare attività stimolanti e coinvolgenti, il docente, in aggiunta alla funzione prettamente didattica, svolge anche la mansione di giudice e arbitro, controlla il rispetto delle regole e la qualità dell’interazione fra gli alunni, valutando infine le attività svolte, sotto il profilo linguistico e comportamentale.

La classificazione dei giochi didattici
I giochi utilizzabili in chiave glottodidattica possono classificarsi in tre categorie:
- giochi di esercizio, collegati all’intelligenza senso-motoria, come le ripetizioni di parole e frasi, scomposizioni e ricomposizioni, associazioni di parole e immagini, giochi di movimento e tutta l’enigmistica;
- giochi simbolici, che si avvalgono dell’intelligenza rappresentativa, come le attività espressive e teatrali, musicali e canore, che prevedano la transcodifica dal verbale all’iconico o al motorio, e includono le drammatizzazioni, i giochi di simulazione e i giochi di ruolo;
- giochi di regole, che si collegano allo sviluppo dell’intelligenza riflessiva e delle relazioni sociali; sono giochi più complessi, come quelli di carte e gli sport (basati sull’assunzione di ruoli) o i giochi comunicativi (basati su un vuoto di informazione e sul libero uso delle risorse linguistiche).
Tra le forme più elementari di gioco didattico ci sono:
- esercizi strutturali e manipolativi trasformati in partita a dadi o a tris;
- giochi su schema, come il gioco dell’oca e battaglia navale;
- giochi di analisi morfosintattica presentata come gara di velocità, basati sulla rapidità di esecuzione;
- tecniche di inclusione ed esclusione in due insiemi, caratterizzate da un certo livello di sfida enigmistica;
- seriazione, ranking, all’interno di un insieme;
- fissazione lessicale attraverso le carte del gioco “Memory”, che stimola la memoria visiva;
- intervista impossibile o talk show, come gioco di simulazione per il riutilizzo delle conoscenze culturali.
Infine, affinché il gioco espleti tutta la sua funzione didattica ed educativa è importante però che alla fase ludica segua un momento di riflessione, in cui lo studente possa avviare una sistematizzazione delle strutture che ha utilizzato durante il gioco, fondamentale per manifestare chiaramente l’intenzionalità educativa di questo tipo di metodologia glottodidattica.

Dalla teoria alla pratica: i verbi
Inseriamo di seguito un esempio concreto di attività ludica efficace, stimolante e divertente utilizzata in questi giorni in ambito didattico da chi scrive. Il focus del gioco è di carattere grammaticale e riguarda il verbo.
Materiale occorrente:
- cartoncini colorati contenenti le domande ideate dall’insegnante
- un tabellone in formato digitale facsimile al gioco dell’oca con caselle colorate con gli stessi colori dei cartoncini
- un dado a sei facce oppure un sistema automatico di lancio dei dadi
Regole del gioco: Dividere la classe in più squadre e assegnare un simbolo a ciascun gruppo. Tirare il dado e far avanzare la squadra sul tabellone digitale inserendo il simbolo corrispondente nella casella di arrivo. In base al colore raggiunto estrarre un cartoncino e formulare la domanda ai partecipanti. Se la risposta è esatta si potrà procedere al lancio dei dadi nel turno successivo, in caso contrario si risponderà nuovamente a una domanda dello stesso colore. Si prosegue in questo modo con le altre squadre. Il gruppo che raggiunge per primo la casella “arrivo” vince.
Ecco alcuni esempi di domande inserite dall’insegnante nei cartoncini:
- Analizza la seguente forma verbale “noi avevamo giocato”
- Coniuga il verbo “dormire” alla prima persona singolare del tempo presente del modo condizionale (forma attiva)
- Coniuga il verbo “essere” al tempo imperfetto del modo indicativo
- Coniuga il verbo irregolare “andare” alla seconda persona plurale del tempo futuro semplice del modo indicativo (forma attiva)
- Inventa due frasi con il verbo “fuggire”, nella prima usalo in funzione transitiva mentre nella seconda in funzione intransitiva
- Inventa una frase attiva con il verbo “mangiare” e trasformala poi al passivo
- Inventa una frase con un verbo usato nella forma riflessiva
- Inventa una frase con il seguente verbo difettivo “solere”
- Inventa due frasi usando i seguenti verbi sovrabbondanti “marciare” – “marcire”
Buon lavoro! Divertitevi e scegliete un premio da assegnare alla squadra vincitrice, per esempio un attestato che certifichi la vittoria o un bonus per un’interrogazione programmata.