La follia come suprema saggezza. Un viaggio nella letteratura e nella psiche dei letterati
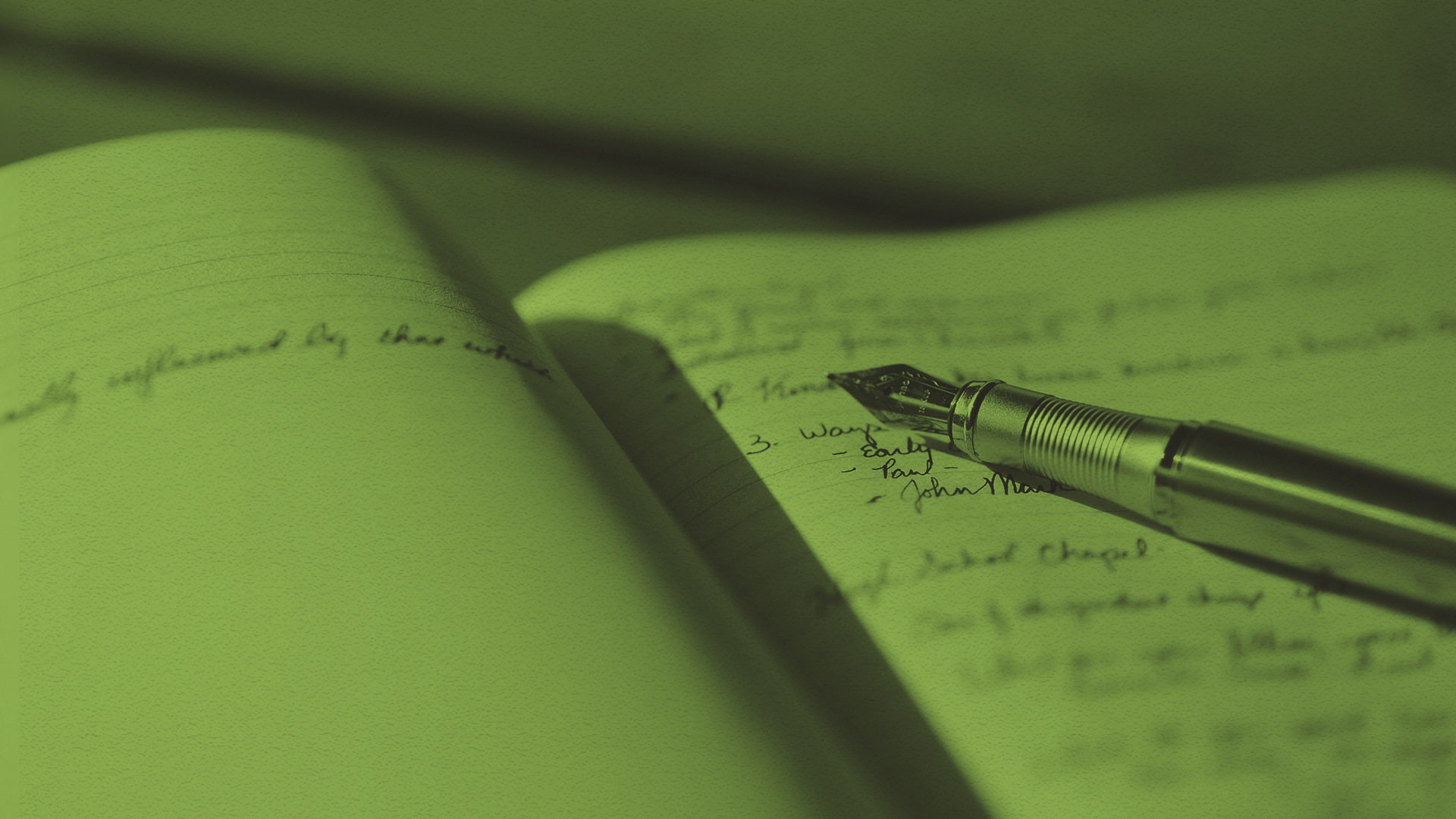
“Dirò d’Orlando in un medesimo tratto/ cosa non detta in prosa mai né in rima: /che per amor venne in furore e matto,/ d’uom che sì saggio era stimato prima”.
Follia e letteratura
Con questi versi viene introdotto nell’Orlando Furioso uno dei personaggi più importanti della letteratura italiana. Ludovico Ariosto dà molta importanza in tutta l’opera al tema della follia, della mancanza di senno. Orlando, il più valoroso paladino, si innamora di Angelica e, lasciando tutti i suoi doveri, impazzisce quando scopre che la donna si è concessa a Medoro.
Come la follia sia una forma di saggezza
Orlando diventa dunque matto e la follia è collegata irrimediabilmente all’amore. Un amore che gli fa perdere la dignità di essere uomo e paladino, un amore che, facendolo diventare folle, lo fa errare in modo affranto e con un movimento oscillatorio nei versi che recitano “Di qua, di là, di su, di giù discorre”.
Inizialmente penserà che Angelica, la donna che ama, abbia sbagliato a scrivere il nome dell’innamorato ma, dopo una serie di vicissitudini e capendo che i due amanti si sono perfino sposati diventa matto tanto da essere paragonato a una bestia, un animale che spacca qualunque cosa trovi davanti a sé.
Il suo senno sarà recuperato dal paladino Astolfo, figlio del Re di Inghilterra che, accompagnato da S. Giovanni Evangelista, salirà fino al cielo della luna dove si trovano tutte le cose ritenute vane che si perdono sulla terra o a causa della Fortuna e dunque del caso o secondo il libero arbitrio dell’uomo.
Nonostante sulla luna ci siano le ampolle contenenti il senno che si perde sulla terra a causa di diversi problemi, l’unica cosa che non si troverà mai è la follia perché questa è irrimediabilmente propria della terra. La tematica della follia è stata discussa molte volte in ambito letterario da diversi poeti e letterati.
La follia in letteratura: Omero
Già ai tempi di Omero fu portato avanti il concetto di follia considerata come malattia mentale e vista come punizione ricevuta dagli dei. Trasportata in ambito letterario, e in particolare nei poemi omerici, la follia, ad esempio, può essere rintracciata nei passi dell’Odissea in cui viene narrata la storia di Polifemo, visto come folle dai suoi compagni nel momento in cui chiede aiuto contro “Nessuno” che vuole ucciderlo.
Al contrario della follia vista con Ariosto nel ‘500 che la trattava in relazione all’amore, con Omero assistiamo alle conoscenze della cultura popolare. Sia l’Iliade che l’Odissea, infatti, furono per tantissimi secoli cantate oralmente dai cantori i quali attingevano a un bagaglio culturale molto antico e tradizionale.
I cantori si servivano infatti di formule, frasi ricorrenti che tornavano nel canto ogni qual volta si parlasse di un determinato tema. È quindi evidente che la follia vista come punizione divina è costante in entrambi i testi della tradizione.
La follia in letteratura: Pirandello
Facendo un salto temporale di tantissimi secoli e, arrivando quasi ai giorni nostri, possiamo osservare il tema della follia in Luigi Pirandello. Egli può essere sicuramente considerato come un anarchico perché rifiuta categoricamente la vita sociale in tutti i suoi aspetti. Per Pirandello è da condannare la società che impedisce all’uomo di far parte della “vita” e lo ingloba in una “forma”.
Una reazione a queste forme imposte dalla società è, per Pirandello, la fuga nella follia. Il personaggio pirandelliano, denominato “forestiero della vita”, attua questa reazione rifiutandosi di indossare la propria maschera e guarderà gli altri indossare la loro con atteggiamento umoristico e di pietà.
La follia in letteratura: Paolo Volponi
Ciò che rispecchia la condizione della società nel ‘900 è vista nel romanzo “Il Memoriale” di Paolo Volponi. Lo scrittore racconta la storia di Albino Saluggia, un operaio che viene assunto in una fabbrica del Nord il 2 Giugno 1946. Il protagonista è folle, affetto da manie di persecuzione e pensa che i capi della fabbrica abbiano indetto una congiura contro di lui per licenziarlo. Saluggia capisce, nella sua pazzia, che le nuove fabbriche del tempo si preoccupassero all’apparenza dei bisogni degli operai perché l’intento principale era quello di racchiuderli in essa e alienarli imprigionandoli e facendoli diventare malati.
La pazzia e i letterati
Infine, dopo aver fatto alcuni brevi accenni e riferimenti al tema della follia all’interno della letteratura, è utile capire come, nonostante la follia vista come vera e propria pazzia e dunque come malattia mentale possa intaccare anche i letterati, questi continueranno a produrre e a creare opere di un livello artistico molto elevato e fondamentale nella nostra cultura nazionale.
Tra genio e follia: Torquato Tasso e Alda Merini accomunati da un destino comune
Due importantissimi letterati, due persone così lontane nel tempo ma così vicine per delle vicissitudini personali. Torquato Tasso e Alda Merini. Cosa possono avere in comune un poeta del ‘500 e una poetessa del ‘900? Ci sono 400 anni che separano i due eppure, entrambi affetti dalla patologia della pazzia, hanno vissuto la tragica esperienza del manicomio.
Proprio all’interno del manicomio di Sant’Anna Tasso autorizzò la pubblicazione della “Gerusalemme Liberata”, una delle opere più importanti e belle della nostra letteratura con passi di altissimo livello stilistico e con passi particolarmente commoventi.
Più di 400 anni dopo la Merini dovette sopportare oltre al manicomio 46 elettroshock a cui è stata sottoposta ma, nonostante ciò, come lei stessa disse, la sua memoria non si è mai spenta e proprio in quegli anni quel dolore le permise di comporre versi sublimi e forti di significato.
Alda Merini fu rinchiusa nel manicomio a sua insaputa e proprio per questo confessò che impazzì nel momento in cui si rese conto di essere entrata in un “labirinto” dal quale avrebbe fatto fatica ad uscire.
La poetessa era convinta, dopo aver vissuto queste esperienze sulla propria pelle, che le malattie mentali non esistessero. Disse, una volta fuori dal manicomio, che il vero inferno è la società, “è fuori, qui a contatto degli altri, che ti giudicano, ti criticano e non ti amano”.




