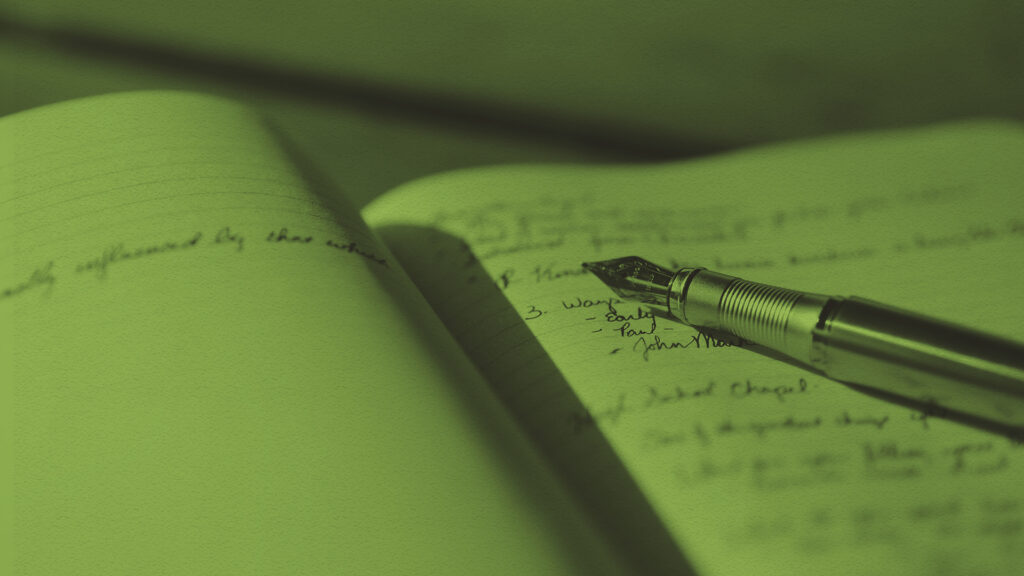“L’Italia ha perso un regista e uomo straordinario”, niente di più vero trovandoci, purtroppo, a parlare di Ettore Scola, il grande maestro di cinema che si è spento ieri all’età di 84 anni al Policlinico Umberto I. Il pensiero del ministro dell’Istruzione Stefania Giannini inquadra bene la vita e la carriera di Scola (nato a Trevico il 10 maggio 1931) che – precisa il presidente del Senato Pietro Grasso – “attraverso la macchina da presa ci ha fatto emozionare, ridere e soprattutto riflettere sulla nostra società e i suoi cambiamenti”. Quest’oggi la salma rimarrà al Policlinico Umberto I mentre domani sarà esposta alla Casa del Cinema di Roma (secondo le ultime volontà del regista). Venerdì, infine, la camera ardente dalle 8.30 alle 15, in cui interverranno amici e colleghi di Scola.
Ai tanti che vivono con estremo dolore la perdita del Maestro, che intraprese la carriera da regista nel 1964 con ‘Se permettete parliamo di donne’ con Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni, si è aggiunto anche il Capo dello Stato Mattarella: “con Ettore Scola scompare un protagonista del cinema italiano. La cultura e lo spettacolo mondiali perdono un grande maestro che ha raccontato, con acume e sensibilità straordinari, vicende, personaggi e periodi della nostra storia contemporanea”. Per Nichi Vendola, Scola ha sempre interpretato il proprio mestiere guidato da “una grande passione civile, una straripante umanità, una voce tenerissima e spesso scanzonata e ironica. Con Ettore scompare uno dei grandi maestri del cinema italiano. Per molti di noi, anche un caro amico e un compagno di lotta”.
Scola, la teatralità nel cinema
Tra i lavori più importanti di Scola ricordiamo ‘C’eravamo tanto amati’ (1974), ‘Brutti, sporchi e cattivi’ (1976), ‘Una giornata particolare’ (1977) e ‘La famiglia’ (1987). L’acume del Maestro lo ritroviamo nella particolarità del suo modo di fare cinema, caratterizzato anche dall’inserimento di elementi di teatralità che consacrano quest’ultima come struttura fondamentale di riferimento. Il cinema, che accoglie in tal modo la teatralità nei propri codici, diviene una via per arrivare a forme di riflessioni metalinguistiche. Questo lo ritroviamo nell’opera di Scola ‘Il viaggio di Capitan Fracassa’ (1990) commedia in costume con Massimo Troisi, in cui è presente sia il riferimento al tema della labilità del confine tra realtà e finzione – Serafina dice a Sigognac: “succede che una cosa che reciti, un’astuzia di donna, un artifizio costruito per piacere o per mostrarti innamorata, ti resti dentro anche a recita finita, e ti accorgi che… ossia, voglio dire che, quando credevi di essere bugiarda, eri sincera” – sia una riflessione sul concetto di rappresentazione, in cui risiede una certa ambiguità tra teatro e cinema. A testimoniarlo le parole di Matamoro nei confronti della ‘nipote’ Isabella (Emmanuelle Béart), addolorata perché il barone cede alle lusinghe di Serafina (Ornella Muti): “non ti permetterò di patire. Sorridi subito! Un’attrice deve soffrire o gioire solo quando è in scena. La vita, con i suoi piccoli desideri, deve servirci da esercizio, da prova generale, per interpretare le grandi passioni che noi dobbiamo mostrare al pubblico. Su, dammi la tua battuta” – “che cosa devo dire?” – “Una battuta qualunque per interrompere la mia che è troppo lunga”. Nella prima parte osserviamo la metafora della vita come teatro ma, capovolgendo i due elementi e riducendo l’esisenza all’approssimazione delle prove, la conclusione di Matamoro assume un carattere interessante, che in riferimento alla sceneggiatura del film crea straniamento nello spettatore, che all’improvviso si trova lontano dalla cornice ma al contempo diviene cosciente della messinscena che gli si dipana davanti.