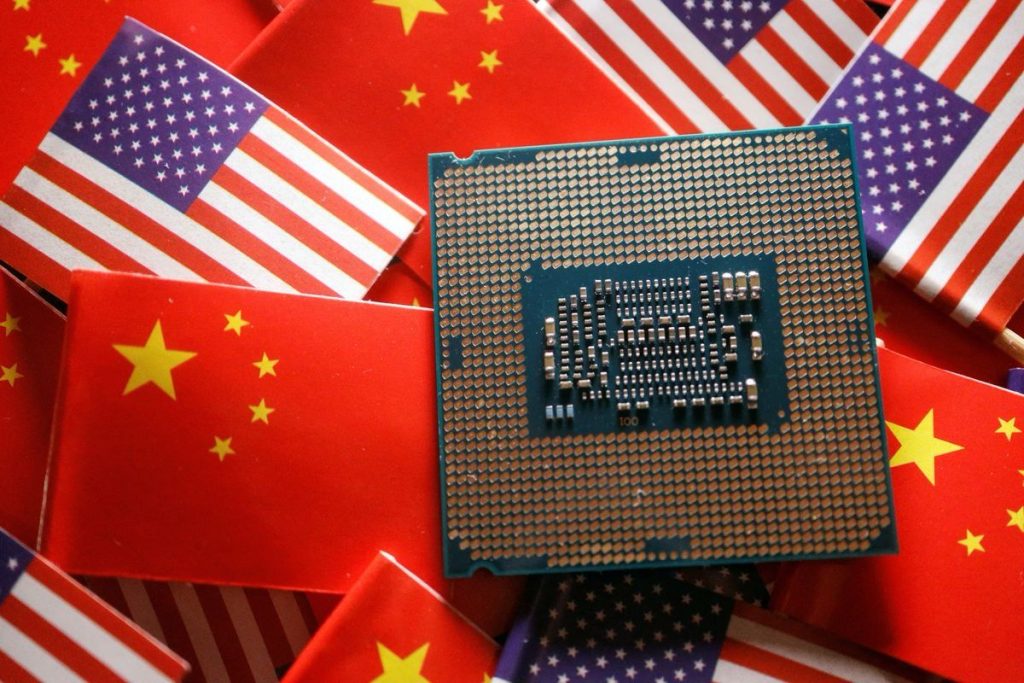Immaginate di svegliarvi e non possedere più nulla. Attenzione, possedere, non disporre. La differenza è sottile, ma sostanziale. Disporre, implica un uso, temporaneo, revocabile, ma non la proprietà. Possedere è esercitare un diritto esclusivo, definitivo, non sottoposto alla dipendenza dal volere altrui. Ora immaginate che l’aria che respirate non vi appartenga più. Qualcuno in un consiglio di amministrazione o per decreto presidenziale, d’un tratto, può decidere quanto, quando e se potete ancora respirarla. Assurdo, certamente. In primis perché in ballo c’è la vostra vita, secondo perché è vostra, appunto.
Un’ipotesi che sa di apocalittico, solo nella misura in cui non siete abituati a pensarlo. Perché si tratta della logica che governa il mondo attuale: la proprietà è una “concessione su delega” e l’accesso ai beni si basa sul criterio di esclusività. Possedere è diventato un attributo di pochi e il valore di una risorsa non è più legato alla sua utilità, quanto alla sua scarsità: più è rara, più chi la controlla ne determina prezzo, flusso, distribuzione e ci costruisce un vantaggio elitario.
La conseguenza naturale è una regola di appropriazione che si basa sulla presunta finitudine: le risorse scarseggiano perché in passato il loro razionamento si è basato su un’errata considerazione delle stesse. Almeno è quello che risuona. Una narrazione che si realizza in un modello economico e societario di cui il trumpismo è l’emanazione: la competizione globale non risiede più nella creazione di valore per generalizzare il benessere, ma nella lotta a chi riesce a negarlo prima agli altri.
Donald Trump lo ha capito bene. La sua modalità di politica estera, non è mai casuale, ma svela una postura americana che ha dell’incredibile, a tratti presuntuosa e anacronistica. Ma è esattamente questo il punto.
Il capitalismo della finitudine
Arnaud Orain incasella questo nuovo assetto mondiale nel “capitalismo della finitudine“, il monopolio di alcuni Stati e alcune “aziende-impero” su beni e risorse, per generare profitto e accrescere il proprio potere. Una predazione al libero mercato che si costruisce su tre pilastri: privatizzazione dei mari e degli oceani, esclusione del principio competitivo e nascita di imperi formali e informali.
L’idea generale di crisi ineluttabile, in parte ecologica, in parte di diplomazia internazionale è tutta rintracciabile qui. Ci collochiamo a metà tra la pace e la guerra, una situazione spiegabile attraverso una retorica del limite che si è riproposta più volte nel corso della storia, alternandosi al capitalismo liberale.
Tra il XVI e il XVII secolo, in un’epoca di proto-capitalismo della finitudine, le potenze coloniali hanno agito la competizione globale come uno zero sum game in cui accaparrarsi un pezzo del Nuovo Mondo, il più in fretta possibile. Poche risorse da aggiudicarsi per generare ricchezza internamente e impedire agli altri Paesi di fare lo stesso. Il tutto accompagnato dalla nascita di monopoli come le Compagnie delle Indie, oggi sostituite dalle Big tech.
In più riprese il capitalismo liberale, indirizzato alla crescita generalizzata di tutti gli attori (imprese, individui e Stato), è stato l’alternativa a questo modello economico. Prima all’inizio del XIX secolo, quando la rivoluzione industriale e l’apertura ad un libero mercato hanno promosso l’idea di un possibile vantaggio commerciale nella collaborazione tra Paesi; poi nel 1945, quando la necessità di cooperazione internazionale e la nascita di organizzazioni come la FMI (Fondo Monetario Internazionale) e la WTO(World Trade Organization)hanno rilanciato l’economia globale.
Dal 2010 – causa la crisi economica del 2008 e altri fattori di instabilità internazionale – si è invece assistito al ritorno del capitalismo della finitudine, in una sua terza fase, permeata da aggressivismo politico.
La svolta America First
Il massimo allievo del capitalismo della finitudine è senza dubbio Trump. La sua idea di politica estera è sicuramente cambiata rispetto al 2017: più rapida e decisa e con una modalità di agire più incisiva. Un po’ per l’esperienza accumulata nel primo mandato, un po’ per la pregressa carriera di uomo d’affari. Non che fosse un visionario nelle scelte imprenditoriali – anche se sicuramente geniale nel self-branding – , ma la sua mentalità imprenditoriale gli è rimasta.
La retorica del “riprendiamoci quello che è nostro” rientra in un panorama populista più vasto. Con l’imposizione di dazi commerciali, il protezionismo economico statunitense si alimenta di un gioco a somma zero in cui “il mio nemico è il mio vicino”. Chiunque possa anche solo competere per il controllo delle risorse è da combattere. Da qui l’accusa alla sovraccapacità cinese e alla volontà iraniana di dotarsi della bomba atomica oltre che l’odio, recentemente trapelato con il Signalgate, nei confronti del Vecchio continente.
L’obiettivo di Washington è “to Make America Great Again”, allontanando usurpatori (gli europei) dipendenti dal vassallaggio americano e “punendo” chi si vuole arricchire sulle spalle del continente a stelle e strisce. L’aspra tassazione su automobili, settore farmaceutico e chi più ne ha, più ne metta, rientra nell’obiettivo di breve termine di aumentare le entrate, con la possibilità futura di provvedere a degli investimenti e alla delocalizzazione della produzione industriale.
Obiettivo di lungo termine
Rendendo più costose le esportazioni delle importazioni, l’effetto sperato è una reindustrializzazione degli USA che in parte sta vedendo i suoi effetti con le aziende europee ArcelorMittal, Stellantis e quella taiwanese, TSMC, che stanno investendo negli Stati Uniti per sfruttare un mercato più stabile con maggiori incentivi fiscali, opportunità di crescita e minori costi di produzione.
A questa prospettiva si aggiunge anche l’inversione di tendenza di un colosso che non ha più voglia di essere il gendarme mondiale come lo era l’Inghilterra nell’Ottocento. La conquista di una reputazione internazionale di protettore dell’ordine di pace globale, tramite l’applicazione di un soft power senza precedenti, ha raggiunto il suo massimo. Ora gli Stati Uniti sganciano dalla propria orbita di protezione colei che ne ha beneficiato di più: l’Europa.
L’antieuropeismo americano e gli imperi high-tech
Donald Trump non si schiera contro il singolo Stato europeo, ma in contrapposizione del progetto comunitario UE in cui è il diritto a costruire i rapporti diplomatici e non la forza. La Realpolitik statunitense non fa sconti a nessuno e persegue interessi nazionali senza considerare le alleanze storiche come quella con l’Europa. La politica, d’altronde, è cinica e non conosce moralità, ma solo strategia. In questo contesto si inseriscono scelte fortemente unilaterali come la minaccia alla Groenlandia o la questione delle terre rare, usate come merce di scambio nella mediazione Russia-Ucraina.
Nell’ottica trumpiana è inaccettabile l’intervento statale ed è anzi auspicabile una sua progressiva riduzione. Un approccio che si scontra con la priorità europea di tutelare i diritti dei cittadini che in parte passa per una forte e solida regolamentazione. Per l’amministrazione americana attuale questo fa dell’Europa un blocco troppo burocratico e centralizzato, lontano dalle dinamiche economiche in atto.
È pur vero che i tagli voluti da Trump finirebbero per conferire ampio potere ai monopoli tecnologici di Marc Zuckerberg e Elon Musk, così potenti da diventare entità sovrane di tutto rispetto e non più aziende. Meta ha un impero digitale nel progetto metaverso, che gestisce le piattaforme social essenziali per la comunicazione globale, Starlink e SpaceX sono rispettivamente una rete globale di satelliti e un’impresa spaziale con la pretesa ambiziosa di colonizzare Marte.
In questo senso, il ritorno alla logica di conquista passa per nuove strutture, diverse da uno Stato, ma ugualmente potenti, se non di più, che, non dovendosi sottoporre alla legge come un normale apparato statale, sono più libere e deresponsabilizzate. Nella misura che più le aggrada, quest’ultime possono influenzare le politiche governative per strappare regolamentazioni a loro favorevoli e influenzare l’opinione pubblica mediante informazioni e dati personali degli utenti.
Il grande gioco della competizione marittima con Pechino
Un ultimo punto su cui riflettere è la questione mercantile e marittima in cui la direzione di Washington sembra essere orientata alla riduzione, sul lungo periodo, dell’influenza cinese nel proprio cortile di casa – Canale di Panama e America Latina – tramite l’acquisizione del controllo dei porti più importanti. Lo dimostra il recente cambio di guardia dei terminal portuali gestiti dalla società cinese Hutchison Ports, ora passati di mano alla compagnia italo-svizzera MSC e al gigante americano della finanza BlackRocks.
Tra i grattacapi dell’attuale amministrazione, la minaccia degli Houthi dello Yemen – di cui sono famosi gli attacchi alle navi commerciali occidentali – che rischia di mettere in pericolo il traffico marittimo nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, uno dei principali collegamenti via mare tra Asia ed Europa.
Inoltre, bisognerà capire come Trump deciderà di muoversi in merito alla questione commerciale peruviana: l’apertura di Chancay, un porto situato a 80km a nord da Lima e controllato da Cosco, un gigante marittimo legato all’esercito di Pechino, potrebbe trasformarsi in un importante sfida per la temuta influenza orientale.
In ultima analisi, l’obiettivo del Paese statunitense rimane proteggere le rotte commerciali di suo interesse a costo di lasciare ad altri la faccenda della sicurezza e della libertà marittima, troppo onerosa da gestire. Tra l’altro Washington ha ridotto la sua dipendenza economica dal commercio, a differenza di Pechino, per cui il terreno d’attacco americano resta il grande gioco marittimo in cui ha ancora molto da dimostrare.