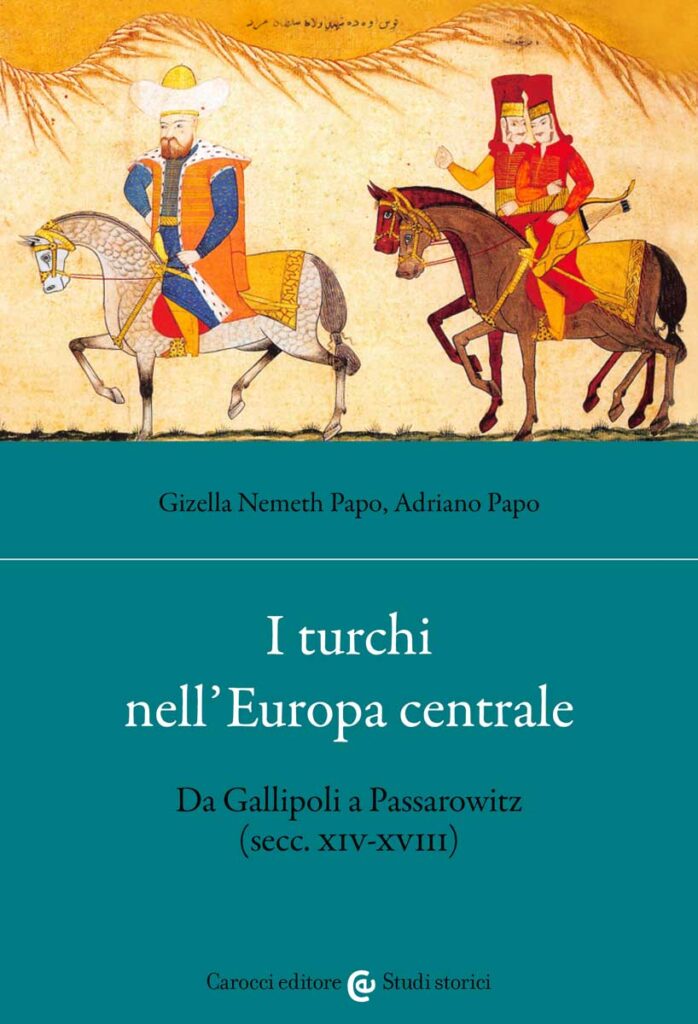L’identità si definisce attraverso la polarità positiva ma anche e forse soprattutto attraverso la mancanza, l’assenza, l’altro. Solo al cospetto del desiderio, in senso lacaniano, si comprende il soggetto, in quanto sua condizione. In tali termini la maturazione storica d’Europa non è comprensibile senza un’attenta riflessione storiografica puntuale sul legame/scontro che ha posto per lunghi secoli le potenze del Vecchio Continente al cospetto della potenza altaica ottomana.
Dal primo passo della conquista di Gallipoli nel 1354, le forze della dinastia turca oghuz, erede del fondatore Osman, rappresenteranno specchio, paura e desiderio dell’Europa continentale. Esemplare, in questo processo, di questa dinamica che compie la storia nel segno dell’assenza, in questo caso della sconfitta, sarà la battaglia di Kosovo Polje, la Piana dei Merli, disfatta assurta a simbolo mitopoietico dei cantori del passato serbo contro l’esercito del Sultano.
Un gioco di specchi infinito quello tra i regni europei e la potenza del divano di Istanbul, il governo guidato dal Visir per conto dell’autorità del Gran re, il Padisha, proveniente dai monti altaici. Un tessuto di trama umana che appare straordinariamente fitto. Dall’istituto del Millet che garantiva libertà di culto e rappresentanza comunitaria ai non musulmani fino al meccanismo del devşirm, la raccolta, il sistema di reclutamento dei giovanissimi cristiani al servizio del sultano e del corpo dei giannizzeri fondato da Murad I.
Legami profondi tra rinnegati, conversioni e intrecci biografici straordinari. Figure speculari, l’uno patriota cristiano, l’altro rinnegato divenuto pascià, entrambi simboli di resistenza e ascesa individuale nell’epoca di confine: da un lato le storie di coraggio e abilità di Giovanni Castriota Scandeberg, patriota albanese in lotta feroce con gli ottomani; dall’altro l’ascesa sorprendente del pescatore calabrese Giovanni Dionigi Galeni, divenuto da schiavo terrore dei mari come corsaro con il nome di Uluç Ali e infine Gran Ammiraglio (Kapudan Paşa) della flotta ottomana sotto Selim II.
Una storia, quella dei Balcani e dell’Europa centrale non scindibile da quella delle vicende della dinastia turca, come spiegano in maniera esemplare Gizella Nemeth Papo e Adriano Papo nel loro ultimo lavoro per Carocci, I turchi nell’Europa centrale. Da Gallipoli a Passarowitz (secc. XIV-XVIII). Nella loro ricostruzione storica un ruolo chiave gioca, naturalmente, il Regno d’Ungheria, che da Sigismondo di Lussemburgo a Matteo Corvino rimarrà l’ostacolo fondamentale all’avanzata dei sultani di Istanbul in Europa.
Solo Solimano Il Magnifico, il Salomone altaico, riuscirà ad infrangere la potenza ungherese nella battaglia di Mohács del 29 agosto 1526, causando il disfacimento del regno magiaro allora retto da Luigi II della dinastia lituano-polacca Jagellone. Una sconfitta, una nuova negatività e assenza che segnerà in modo significativo il volto dell’Europa spingendo stabilmente la direttrice di espansione asburgica verso i Balcani.
Direttiva che sarà legata al nome di altra figura emblematica della storia europea e dell’impero d’Austria, il genio militare di Eugenio di Savoia. Nato a Parigi nel 1663, ma dal ramo cadetto della Casa dei Savoia, respinto da Luigi XIV e in prima battuta avviato alla carriera ecclesiastica, Eugenio diventerà simbolo della nuova avanzata austrica contro gli ottomani prima in Ungheria e poi nel Balcani, divenendo protagonista della conquista di Belgrado e della successiva pace di Passarowitz. Accordo che segnerà uno spartiacque: l’espansione degli Asburgo nei Balcani e la fine delle grandi campagne ottomane nel Vecchio Continente. Ma anche la parabola discendente di Venezia, che con la perdita della Morea vedrà ridursi drasticamente il proprio ruolo di potenza mediterranea.
Da Gallipoli a Passarowitz: l’identità europea allo specchio della potenza ottomana