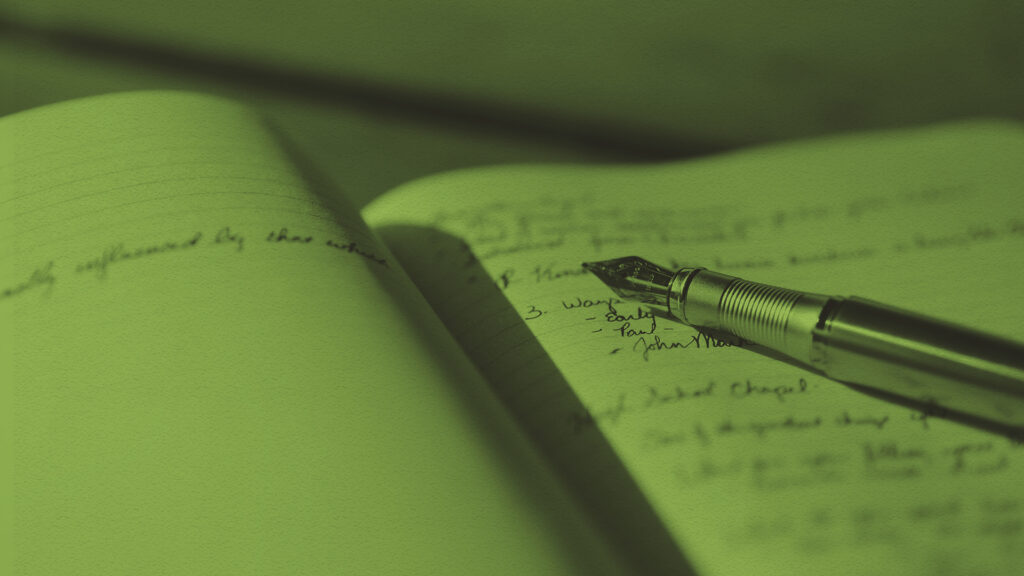Unioni civili, il ricorso alla Corte Costituzionale
Sono 40 i senatori che hanno deciso di presentare ricorso alla Corte Costituzionale per una presunta violazione dei loro diritti di parlamentari a causa del mancato rispetto delle normali procedure nell’esame del ddl Cirinnà sulle unioni civili. Il gruppo di senatori, tra cui figurano Quagliariello, Giovanardi, Augello, Compagna e Mauro, sostengono che l’iter del ddl sulle unioni civili ha violato l’articolo 72 Cost., per il quale ogni disegno di legge dev’essere esaminato prima in commissione e poi in aula. «Vogliamo farci rispettare – sostiene Quagliariello, che ha aggiunto – Se la Costituzione viene messa sotto i piedi, non lo possiamo accettare». Curioso, però, che un ‘conflitto d’attribuzione’ di tale portata venga alla luce soltanto adesso, come rilevato anche dal presidente del Senato Pietro Grasso: l’iter del provvedimento risale al 18 giugno del 2013, quando si svolsero «ben 69 sedute della commissione in 29 ore di dibattito». Da allora non «sono arrivate voci contrarie quando il presidente della commissione propose di proseguire l’esame del ddl Cirinnà in congiunta con gli altri ddl». Per il presidente Grasso, il ricorso alla consulta è una mossa da ‘azzeccagarbugli’ che poco ha a che fare con la messa in evidenza di una presunta violazione dell’art. 72: si tratta, in estrema sintesi, di una forma di ostruzionismo, strumento che proveremo a delineare in modo più preciso. Per il momento di certo c’è il rinvo alla prossima settimana della discussione sul ddl Cirinnà, che riprenderà martedì 9 febbraio alle 12.
Cos’è l’ostruzionismo
Chi è all’opposizione tende con frequenza a ricorrere all’ostruzionismo, che si compone di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire la deliberazione da parte dell’assemblea. L’ostruzionismo è parte della tradizione delle assemblee rappresentative, è una forma volontaria di resistenza estrema da parte delle minoranze che si manifesta quando sono in discussione i valori più alti e le regole della convivenza sociale e dei rapporti tra le Istituzioni. Seguendo le indicazioni fornite da Augusto Barbera (professore di diritto costituzionale) e Carlo Fusaro (docente di diritto elettorale e parlamentare e di diritto pubblico comparato), si scopre che «nella prassi italiana, invece, l’ostruzionismo è adoperato con la convinzione che il compito dell’opposizione non sia tanto quello di presentare all’opinione pubblica soluzioni diverse e un indirizzo politico alternativo a quello della maggioranza e del governo, quanto ostacolare l’una e l’altro nel perseguimento del programma sul quale pure hanno ricevuto la fiducia delle Camere e prima ancora quella degli elettori. A tal fine si fa largo uso, per esempio, della possibilità di presentare centinaia e addirittura migliaia di emendamenti e, soprattutto, di sollecitare continue verifiche del numero legale (arrivate anche a 500 in soli 3 giorni). Naturalmente l’ostruzionismo è usato spesso anche per ottenere l’attenzione dei mezzi d’informazione».
Ostruzionismo vs Contingentamento
L’ostruzionismo, in sostanza, si oppone alla programmazione dei lavori, che è sfociata – attraverso un’integrazione regolamentare del 1988 al Senato e del 1997 alla Camera – nel cosiddetto ‘contingentamento’, una ripartizione del tempo disponibile tra i vari soggetti che hanno titolo a prendere parola. Il contingentamento è introdotto per la prima volta come possibilità nel regolamento del Senato del 1971. Questo viene riformato in seguito a una pagina storica di ostruzionismo: quello – ricorda il prof Claudio De Cesare – attuato nel 1968 dal centro destra contro l’elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario e che aveva paralizzato l’attività del Senato per quasi 3 mesi. Il nuovo regolamento del 1971, art. 55, comma 5, stabilsce che per l’organizzazione della discussione dei singoli argomenti del calendario, la Conferenza dei presidenti può determinare il numero massimo d’interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo. Con la riforma del 1988 il contingentamento diventò ‘ordinario’ e venne introdotta la cosiddetta ghigliottina, presente nell’art. 55, comma 5. Il contingentamento, comunque, è soggetto a limiti ed eccezioni, ad esempio i progetti che trattano materie sottoponibili allo scrutinio segreto ai sensi dell’art. 49 del r.C. e i progetti di legge costituzionale non sono sottoposti – nella loro prima iscrizione nel calendario – a contingentamento nelle fasi successive alla discussione sulle linee generali, mentre la discussione generale resta sempre contingentata.